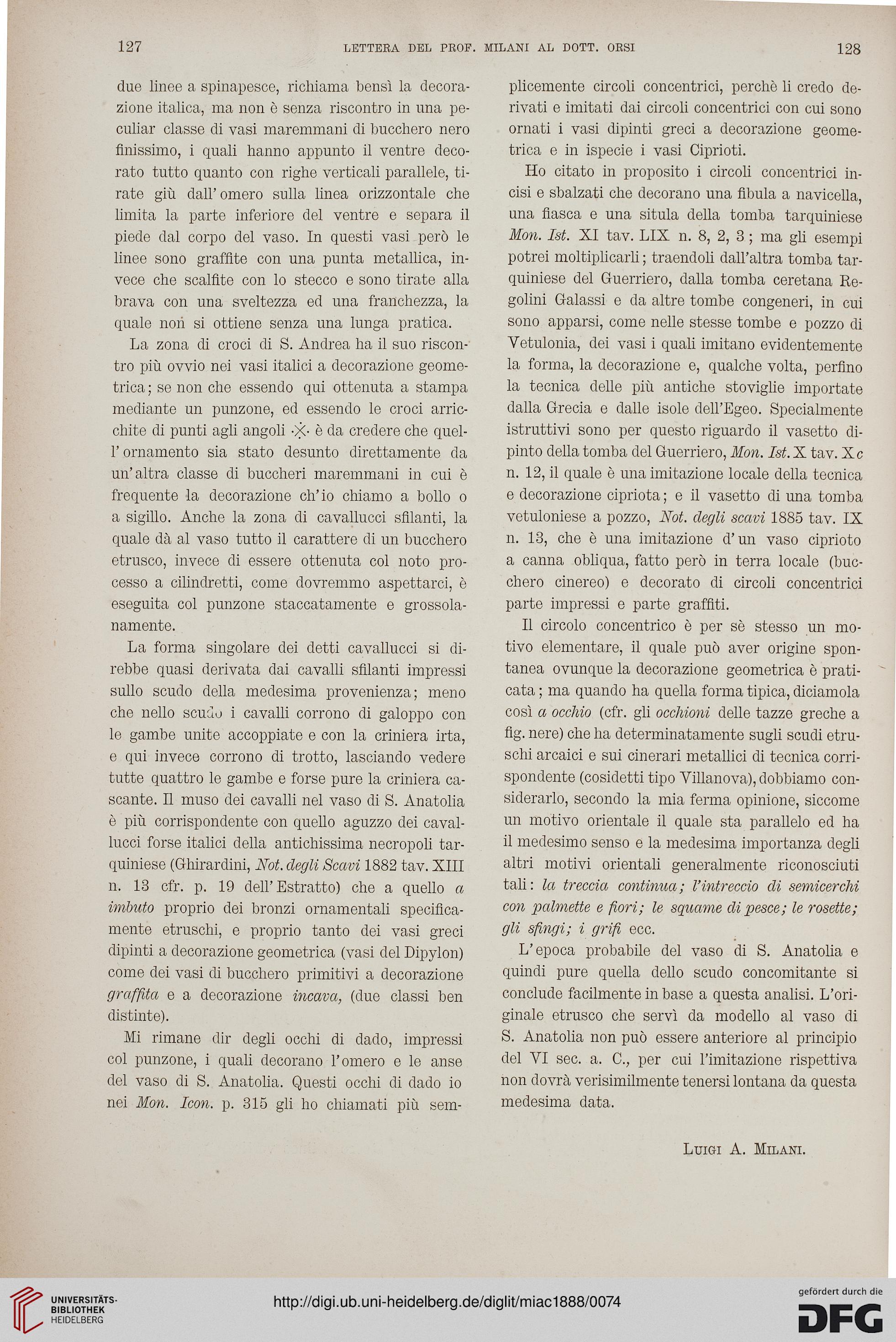127
lettera del prof. milani al dott. orsi
128
due linee a spinapesce, richiama bensì la decora-
zione italica, ma non è senza riscontro in una pe-
culiar classe di vasi maremmani di bucchero nero
finissimo, i quali hanno appunto il ventre deco-
rato tutto quanto con righe verticali parallele, ti-
rate giù dall'omero sulla linea orizzontale che
limita la parte inferiore del ventre e separa il
piede dal corpo del vaso. In questi vasi però le
linee sono graffite con una punta metallica, in-
vece che scalfite con lo stecco e sono tirate alla
brava con una sveltezza ed una franchezza, la
quale non si ottiene senza una lunga pratica.
La zona di croci di S. Andrea ha il suo riscon-
tro più ovvio nei vasi italici a decorazione geome-
trica ; se non che essendo qui ottenuta a stampa
mediante un punzone, ed essendo le croci arric-
chite di punti agli angoli •><• è da credere che quel-
l'ornamento sia stato desunto direttamente da
un'altra classe di buccheri maremmani in cui è
frequente la decorazione ch'io chiamo a bollo o
a sigillo. Anche la zona di cavallucci sfilanti, la
quale dà al vaso tutto il carattere di un bucchero
etrusco, invece di essere ottenuta col noto pro-
cesso a cilindretti, come dovremmo aspettarci, è
eseguita col punzone staccatamente e grossola-
namente.
La forma singolare dei detti cavallucci si di-
rebbe quasi derivata dai cavalli sfilanti impressi
sullo scudo della medesima provenienza; meno
che nello scudo i cavalli corrono di galoppo con
le gambe unite accoppiate e con la criniera irta,
e qui invece corrono di trotto, lasciando vedere
tutte quattro le gambe e forse pure la criniera ca-
scante. Il muso dei cavalli nel vaso di S. Anatolia
è più corrispondente con quello aguzzo dei caval-
lucci forse italici della antichissima necropoli tar-
quiniese (Ghirardini, Not. degli Scavi 1882 tav. XIII
n. 13 cfr. p. 19 dell'Estratto) che a quello a
imbuto proprio dei bronzi ornamentali specifica-
mente etruschi, e proprio tanto dei vasi greci
dipinti a decorazione geometrica (vasi del Dipylon)
come dei vasi di bucchero primitivi a decorazione
graffito, e a decorazione incava, (due classi ben
distinte).
Mi rimane dir degli occhi di dado, impressi
col punzone, i quali decorano l'omero e le anse
del vaso di S. Anatolia. Questi occhi di dado io
nei Mon. Icon. p. 315 gli ho chiamati più sem-
plicemente circoli concentrici, perchè li credo de-
rivati e imitati dai circoli concentrici con cui sono
ornati i vasi dipinti greci a decorazione geome-
trica e in ispecie i vasi Ciprioti.
Ho citato in proposito i circoli concentrici in-
cisi e sbalzati che decorano una fibula a navicella,
una fiasca e una situla della tomba tarquiniese
Mon. Ist. XI tav. LIX n. 8, 2, 3 ; ma gli esempi
potrei moltiplicarli ; traendoli dall'altra tomba tar-
quiniese del Guerriero, dalla tomba ceretana Re-
golini Galassi e da altre tombe congeneri, in cui
sono apparsi, come nelle stesse tombe e pozzo di
Vetulonia, dei vasi i quali imitano evidentemente
la forma, la decorazione e, qualche volta, perfino
la tecnica delle più antiche stoviglie importate
dalla Grecia e dalle isole dell'Egeo. Specialmente
istruttivi sono per questo riguardo il vasetto di-
pinto della tomba del Guerriero, Mon. Ist. X tav. Xc
n. 12, il quale è una imitazione locale della tecnica
e decorazione cipriota ; e il vasetto di una tomba
vetuloniese a pozzo, Not. degli scavi 1885 tav. IX
n. 13, che è una imitazione d'un vaso ciprioto
a canna obliqua, fatto però in terra locale (buc-
chero cinereo) e decorato di circoli concentrici
parte impressi e parte graffiti.
Il circolo concentrico è per sè stesso un mo-
tivo elementare, il quale può aver origine spon-
tanea ovunque la decorazione geometrica è prati-
cata ; ma quando ha quella forma tipica, diciamola
così a occhio (cfr. gli occhioni delle tazze greche a
fig. nere) che ha determinatamente sugli scudi etru-
schi arcaici e sui cinerari metallici di tecnica corri-
spondente (cosidetti tipo Villanova), dobbiamo con-
siderarlo, secondo la mia ferma opinione, siccome
un motivo orientale il quale sta parallelo ed ha
il medesimo senso e la medesima importanza degli
altri motivi orientali generalmente riconosciuti
tali: la treccia continua; l'intreccio di semicerchi
con palmette e fiori; le squame di pesce; le rosette;
gli sfingi; i grifi ecc.
L'epoca probabile del vaso di S. Anatolia e
quindi pure quella dello scudo concomitante si
conclude facilmente in base a questa analisi. L'ori-
ginale etrusco che servì da modello al vaso di
S. Anatolia non può essere anteriore al principio
del VI sec. a. C, per cui l'imitazione rispettiva
non dovrà verisimilmente tenersi lontana da questa
medesima data.
Luigi A. Milani.
lettera del prof. milani al dott. orsi
128
due linee a spinapesce, richiama bensì la decora-
zione italica, ma non è senza riscontro in una pe-
culiar classe di vasi maremmani di bucchero nero
finissimo, i quali hanno appunto il ventre deco-
rato tutto quanto con righe verticali parallele, ti-
rate giù dall'omero sulla linea orizzontale che
limita la parte inferiore del ventre e separa il
piede dal corpo del vaso. In questi vasi però le
linee sono graffite con una punta metallica, in-
vece che scalfite con lo stecco e sono tirate alla
brava con una sveltezza ed una franchezza, la
quale non si ottiene senza una lunga pratica.
La zona di croci di S. Andrea ha il suo riscon-
tro più ovvio nei vasi italici a decorazione geome-
trica ; se non che essendo qui ottenuta a stampa
mediante un punzone, ed essendo le croci arric-
chite di punti agli angoli •><• è da credere che quel-
l'ornamento sia stato desunto direttamente da
un'altra classe di buccheri maremmani in cui è
frequente la decorazione ch'io chiamo a bollo o
a sigillo. Anche la zona di cavallucci sfilanti, la
quale dà al vaso tutto il carattere di un bucchero
etrusco, invece di essere ottenuta col noto pro-
cesso a cilindretti, come dovremmo aspettarci, è
eseguita col punzone staccatamente e grossola-
namente.
La forma singolare dei detti cavallucci si di-
rebbe quasi derivata dai cavalli sfilanti impressi
sullo scudo della medesima provenienza; meno
che nello scudo i cavalli corrono di galoppo con
le gambe unite accoppiate e con la criniera irta,
e qui invece corrono di trotto, lasciando vedere
tutte quattro le gambe e forse pure la criniera ca-
scante. Il muso dei cavalli nel vaso di S. Anatolia
è più corrispondente con quello aguzzo dei caval-
lucci forse italici della antichissima necropoli tar-
quiniese (Ghirardini, Not. degli Scavi 1882 tav. XIII
n. 13 cfr. p. 19 dell'Estratto) che a quello a
imbuto proprio dei bronzi ornamentali specifica-
mente etruschi, e proprio tanto dei vasi greci
dipinti a decorazione geometrica (vasi del Dipylon)
come dei vasi di bucchero primitivi a decorazione
graffito, e a decorazione incava, (due classi ben
distinte).
Mi rimane dir degli occhi di dado, impressi
col punzone, i quali decorano l'omero e le anse
del vaso di S. Anatolia. Questi occhi di dado io
nei Mon. Icon. p. 315 gli ho chiamati più sem-
plicemente circoli concentrici, perchè li credo de-
rivati e imitati dai circoli concentrici con cui sono
ornati i vasi dipinti greci a decorazione geome-
trica e in ispecie i vasi Ciprioti.
Ho citato in proposito i circoli concentrici in-
cisi e sbalzati che decorano una fibula a navicella,
una fiasca e una situla della tomba tarquiniese
Mon. Ist. XI tav. LIX n. 8, 2, 3 ; ma gli esempi
potrei moltiplicarli ; traendoli dall'altra tomba tar-
quiniese del Guerriero, dalla tomba ceretana Re-
golini Galassi e da altre tombe congeneri, in cui
sono apparsi, come nelle stesse tombe e pozzo di
Vetulonia, dei vasi i quali imitano evidentemente
la forma, la decorazione e, qualche volta, perfino
la tecnica delle più antiche stoviglie importate
dalla Grecia e dalle isole dell'Egeo. Specialmente
istruttivi sono per questo riguardo il vasetto di-
pinto della tomba del Guerriero, Mon. Ist. X tav. Xc
n. 12, il quale è una imitazione locale della tecnica
e decorazione cipriota ; e il vasetto di una tomba
vetuloniese a pozzo, Not. degli scavi 1885 tav. IX
n. 13, che è una imitazione d'un vaso ciprioto
a canna obliqua, fatto però in terra locale (buc-
chero cinereo) e decorato di circoli concentrici
parte impressi e parte graffiti.
Il circolo concentrico è per sè stesso un mo-
tivo elementare, il quale può aver origine spon-
tanea ovunque la decorazione geometrica è prati-
cata ; ma quando ha quella forma tipica, diciamola
così a occhio (cfr. gli occhioni delle tazze greche a
fig. nere) che ha determinatamente sugli scudi etru-
schi arcaici e sui cinerari metallici di tecnica corri-
spondente (cosidetti tipo Villanova), dobbiamo con-
siderarlo, secondo la mia ferma opinione, siccome
un motivo orientale il quale sta parallelo ed ha
il medesimo senso e la medesima importanza degli
altri motivi orientali generalmente riconosciuti
tali: la treccia continua; l'intreccio di semicerchi
con palmette e fiori; le squame di pesce; le rosette;
gli sfingi; i grifi ecc.
L'epoca probabile del vaso di S. Anatolia e
quindi pure quella dello scudo concomitante si
conclude facilmente in base a questa analisi. L'ori-
ginale etrusco che servì da modello al vaso di
S. Anatolia non può essere anteriore al principio
del VI sec. a. C, per cui l'imitazione rispettiva
non dovrà verisimilmente tenersi lontana da questa
medesima data.
Luigi A. Milani.