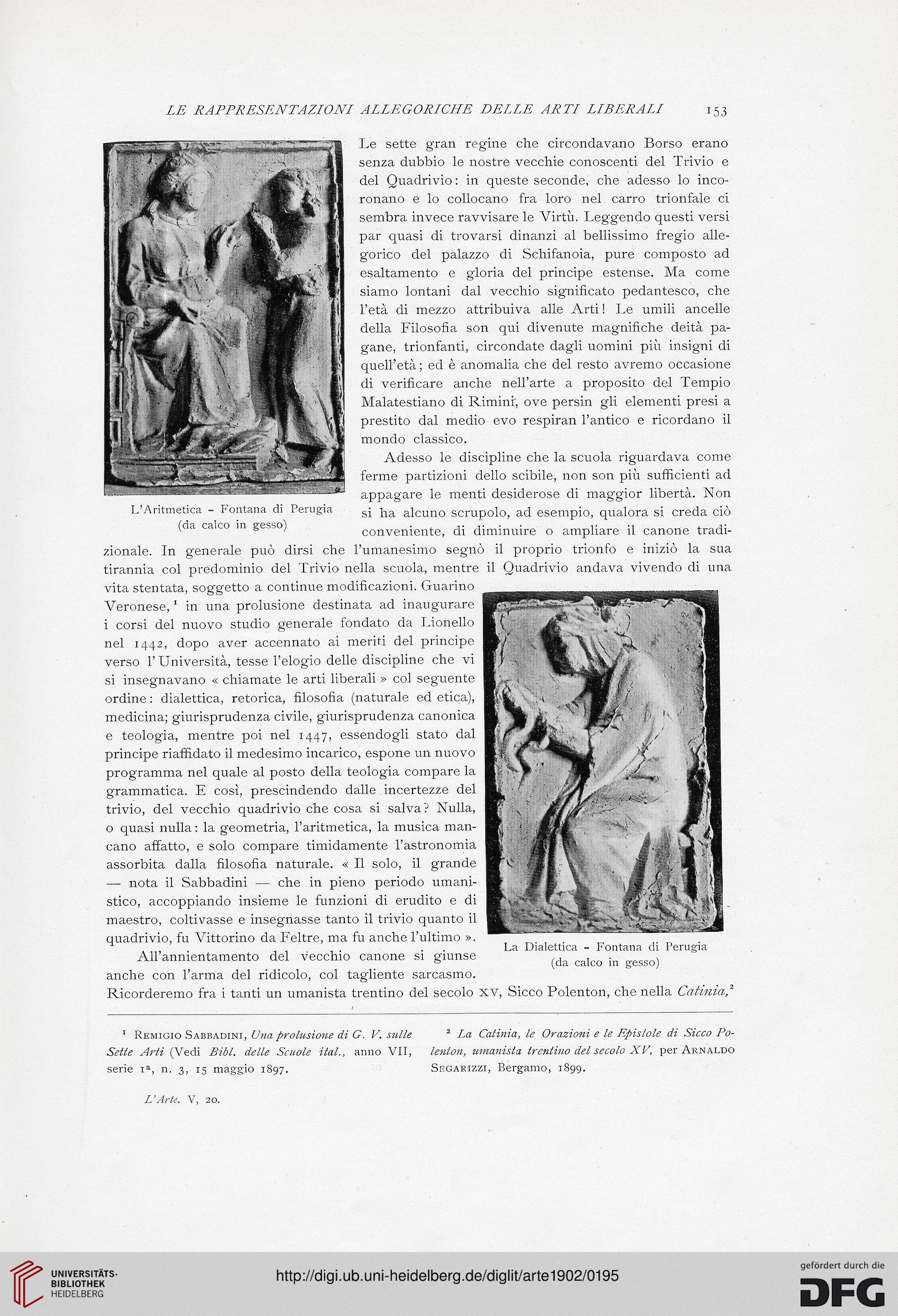LE RAPPRESENTAZIONI ALLEGORICHE DELLE ARTI LIBERALI
153
Le sette gran regine che circondavano Borso erano
senza dubbio le nostre vecchie conoscenti del Trivio e
del Quadrivio: in queste seconde, che adesso lo inco-
ronano e lo collocano fra loro nel carro trionfale ci
sembra invece ravvisare le Virtù. Leggendo questi versi
par quasi di trovarsi dinanzi al bellissimo fregio alle-
gorico del palazzo di Schifanoia, pure composto ad
esaltamento e gloria del principe estense. Ma come
siamo lontani dal vecchio significato pedantesco, che
l’età di mezzo attribuiva alle Arti ! Le umili ancelle
della Filosofia son qui divenute magnifiche deità pa-
gane, trionfanti, circondate dagli uomini più insigni di
quell’età ; ed è anomalia che del resto avremo occasione
di verificare anche nell’arte a proposito del Tempio
Malatestiano di Rimini', ove persili gli elementi presi a
prestito dal medio evo respiran l’antico e ricordano il
mondo classico.
Adesso le discipline che la scuola riguardava come
ferme partizioni dello scibile, non son più sufficienti ad
appagare le menti desiderose di maggior libertà. Non
si ha alcuno scrupolo, ad esempio, qualora si creda ciò
conveniente, di diminuire o ampliare il canone tradi-
zionale. In generale può dirsi che l’umanesimo segnò il proprio trionfo e iniziò la sua
tirannia col predominio del Trivio nella scuola, mentre il Quadrivio andava vivendo di una
vita stentata, soggetto a continue modificazioni. Guarino
Veronese,1 in una prolusione destinata ad inaugurare
i corsi del nuovo studio generale fondato da Lionello
nel 1442, dopo aver accennato ai meriti del principe
verso l’Università, tesse l’elogio delle discipline che vi
si insegnavano « chiamate le arti liberali » col seguente
ordine : dialettica, retorica, filosofia (naturale ed etica),
medicina; giurisprudenza civile, giurisprudenza canonica
e teologia, mentre poi nel 1447, essendogli stato dal
principe riaffidato il medesimo incarico, espone un nuovo
programma nel quale al posto della teologia compare la
grammatica. E così, prescindendo dalle incertezze del
trivio, del vecchio quadrivio che cosa si salva? Nulla,
o quasi nulla : la geometria, l’aritmetica, la musica man-
cano affatto, e solo compare timidamente l’astronomia
assorbita dalla filosofia naturale. « Il solo, il grande
— nota il Sabbadini — che in pieno periodo umani-
stico, accoppiando insieme le funzioni di erudito e di
maestro, coltivasse e insegnasse tanto il trivio quanto il
quadrivio, fu Vittorino da Feltre, ma fu anche l’ultimo ».
All’annientamento del vecchio canone si giunse
anche con l’arma del ridicolo, col tagliente sarcasmo.
Ricorderemo fra i tanti un umanista trentino del secolo XV, Sicco Polenton, che nella Catinia,2
1 Remigio Sabbadini, Una prolusione di G. V. sulle 2 La Catinia, le Orazioni e le Epistole di Sicco Po-
Sette Arti (Vedi Bibl. delle Scuole ital., anno VII, lenton, umanista trentino del secolo XV, per Arnaldo
serie ia, n. 3, 15 maggio 1897. Segarizzi, Bergamo, 1899.
L’Arte. V, 20.
153
Le sette gran regine che circondavano Borso erano
senza dubbio le nostre vecchie conoscenti del Trivio e
del Quadrivio: in queste seconde, che adesso lo inco-
ronano e lo collocano fra loro nel carro trionfale ci
sembra invece ravvisare le Virtù. Leggendo questi versi
par quasi di trovarsi dinanzi al bellissimo fregio alle-
gorico del palazzo di Schifanoia, pure composto ad
esaltamento e gloria del principe estense. Ma come
siamo lontani dal vecchio significato pedantesco, che
l’età di mezzo attribuiva alle Arti ! Le umili ancelle
della Filosofia son qui divenute magnifiche deità pa-
gane, trionfanti, circondate dagli uomini più insigni di
quell’età ; ed è anomalia che del resto avremo occasione
di verificare anche nell’arte a proposito del Tempio
Malatestiano di Rimini', ove persili gli elementi presi a
prestito dal medio evo respiran l’antico e ricordano il
mondo classico.
Adesso le discipline che la scuola riguardava come
ferme partizioni dello scibile, non son più sufficienti ad
appagare le menti desiderose di maggior libertà. Non
si ha alcuno scrupolo, ad esempio, qualora si creda ciò
conveniente, di diminuire o ampliare il canone tradi-
zionale. In generale può dirsi che l’umanesimo segnò il proprio trionfo e iniziò la sua
tirannia col predominio del Trivio nella scuola, mentre il Quadrivio andava vivendo di una
vita stentata, soggetto a continue modificazioni. Guarino
Veronese,1 in una prolusione destinata ad inaugurare
i corsi del nuovo studio generale fondato da Lionello
nel 1442, dopo aver accennato ai meriti del principe
verso l’Università, tesse l’elogio delle discipline che vi
si insegnavano « chiamate le arti liberali » col seguente
ordine : dialettica, retorica, filosofia (naturale ed etica),
medicina; giurisprudenza civile, giurisprudenza canonica
e teologia, mentre poi nel 1447, essendogli stato dal
principe riaffidato il medesimo incarico, espone un nuovo
programma nel quale al posto della teologia compare la
grammatica. E così, prescindendo dalle incertezze del
trivio, del vecchio quadrivio che cosa si salva? Nulla,
o quasi nulla : la geometria, l’aritmetica, la musica man-
cano affatto, e solo compare timidamente l’astronomia
assorbita dalla filosofia naturale. « Il solo, il grande
— nota il Sabbadini — che in pieno periodo umani-
stico, accoppiando insieme le funzioni di erudito e di
maestro, coltivasse e insegnasse tanto il trivio quanto il
quadrivio, fu Vittorino da Feltre, ma fu anche l’ultimo ».
All’annientamento del vecchio canone si giunse
anche con l’arma del ridicolo, col tagliente sarcasmo.
Ricorderemo fra i tanti un umanista trentino del secolo XV, Sicco Polenton, che nella Catinia,2
1 Remigio Sabbadini, Una prolusione di G. V. sulle 2 La Catinia, le Orazioni e le Epistole di Sicco Po-
Sette Arti (Vedi Bibl. delle Scuole ital., anno VII, lenton, umanista trentino del secolo XV, per Arnaldo
serie ia, n. 3, 15 maggio 1897. Segarizzi, Bergamo, 1899.
L’Arte. V, 20.