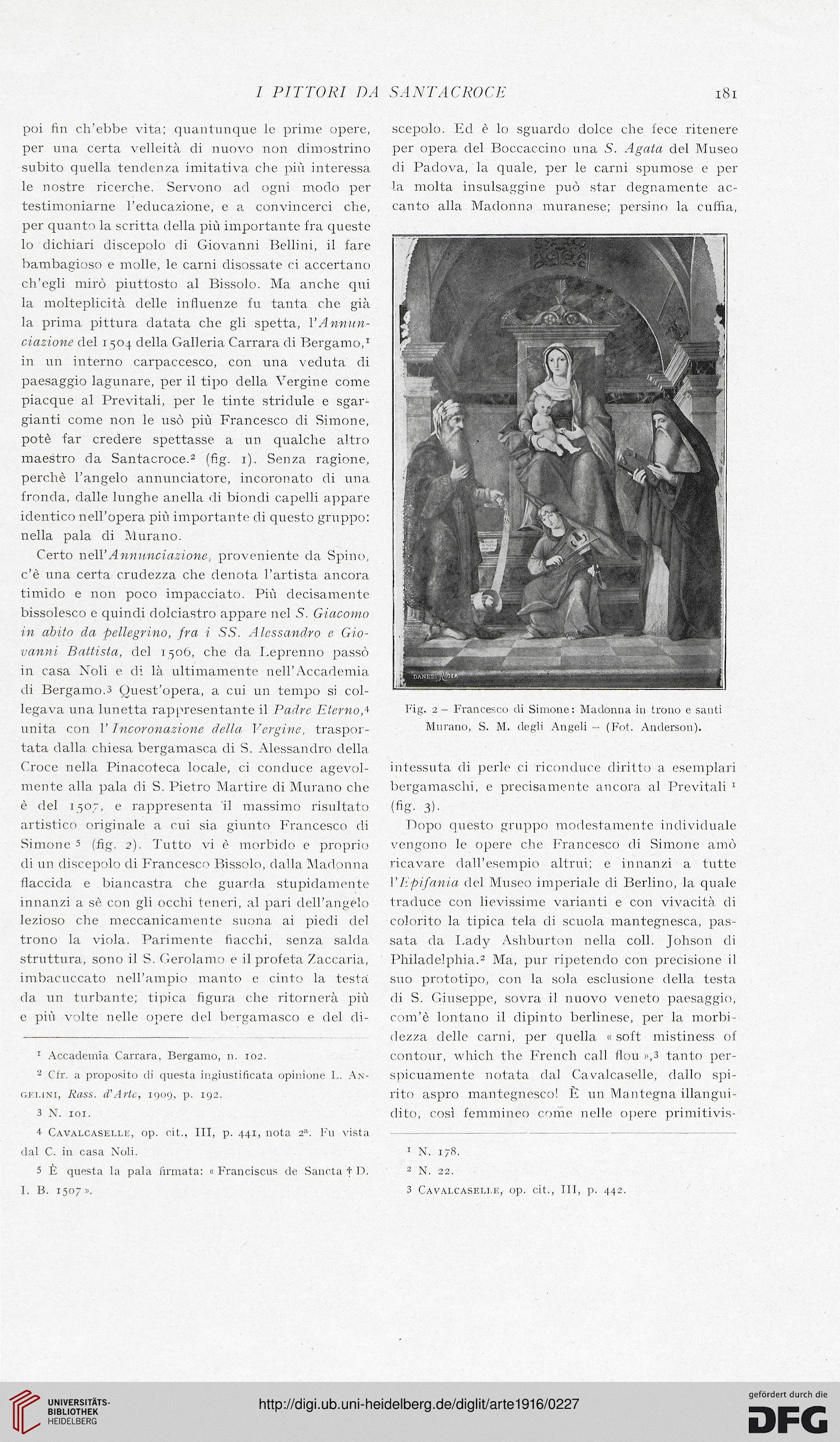/ PITTORI DA SANTACROCE 181
poi fin ch'ebbe vita; quantunque le prime opere,
per una certa velleità di nuovo non dimostrino
subito quella tendenza imitativa che più interessa
le nostre ricerche. Servono acl ogni modo per
testimoniarne l'educazione, e a convincerci che,
per quanto la scritta della più importante fra queste
lo dichiari discepolo di Giovanni Bellini, il fare
bambagioso e molle, le carni disossate ci accertano
ch'egli mirò piuttosto al Bissolo. Ma anche qui
la molteplicità delle influenze fu tanta che già
la prima pittura datata che gli spetta, l'Annun-
ciazione del 1504 della Galleria Carrara di Bergamo,1
in un interno carpaccesco, con una veduta di
paesaggio lagunare, per il tipo della Vergine come
piacque al Previtali, per le tinte stridule e sgar-
gianti come non le usò più Francesco di Simone,
potè far credere spettasse a un qualche altro
maestro da Santacroce.2 (fig. 1). Senza ragione,
perchè l'angelo annunciatore, incoronato di una
fronda, dalle lunghe anella di biondi capelli appare
identico nell'opera più importante di questo gruppo:
nella pala di Murano.
Certo nell'Annunciazione, proveniente da Spino,
c'è una certa crudezza che denota l'artista ancora
timido e non poco impacciato. Più decisamente
bissolesco e quindi dolciastro appare nel S. Giacomo
in abito da pellegrino, fra i SS. Alessandro e Gio-
vanni Ballista, del 7 506, che da I.eprenno passò
in casa Noli e di là ultimamente nell'Accademia
di Bergamo.3 Quest'opera, a cui un tempo si col-
legava una lunetta rappresentante il Padre Eterno,*
unita con V Jncoronazione della Vergine, traspor-
tata dalla chiesa bergamasca di S. Alessandro della
Croce nella Pinacoteca locale, ci conduce agevol-
mente alla pala di S. Pietro Martire di Murano che
è del 1507, e rappresenta il massimo risultato
artistico originale a cui sia giunto Francesco di
Simone 5 (fig. 2). Tutto vi è morbido e proprio
di un discepolo di Francesco Bissolo, dalla Madonna
flaccida e biancastra che guarda stupidamente
innanzi a sè con gli occhi teneri, al pari dell'angelo
lezioso che meccanicamente snona ai piedi del
trono la viola. Parimente fiacchi, senza salda
struttura, sono il S. Gerolamo e il profeta Zaccaria,
imbacuccato nell'ampio manto e cinto la testa
da un turbante; tipica figura che ritornerà più
e pili volte nelle opere del bergamasco e del di-
1 Accademia Carrara. Bergamo, n. 102.
2 Gir. a proposito eli questa ingiustificata opinione I.. An-
gelini, Rass. d'Arte, 1909, p. 192.
3 N. 101.
4 Cavalcasiìlli;, op. cit., Ili, p. 441, nota 2*. Fu vista
dal C. in casa Noli.
5 È questa la pala firmata: « Franciscus de Sancta t I).
I. B. 1507».
scepolo. Ed è lo sguardo dolce che fece ritenere
per opera del Boccaccino una 5. Agata del Museo
di Padova, la quale, per le carni spumose e per
la molta insulsaggine può star degnamente ac-
canto alla Madonna muranese; persino la cuffia,
Fig. 2 — Francesco di Simone: Madonna in trono e santi
Murano, S. M. degli Angeli - (Fot. Anderson).
intessuta di perle ci riconduce diritto a esemplari
bergamaschi, e precisamente ancora al Previtali 1
(fig. 3)-
Dopo questo gruppo modestamente individuale
vengono le opere che Francesco di Simone amò
ricavare dall'esempio altrui: e innanzi a tutte
VEpifania del Museo imperiale di Berlino, la quale
traduce con lievissime varianti e con vivacità di
colorito la tipica tela di scuola mantegnesca, pas-
sata da Lady Ashburton nella coli. Johson di
Philadelphia.2 Ma, pur ripetendo con precisione il
suo prototipo, con la sola esclusione della testa
di S. Giuseppe, sovra il nuovo veneto paesaggio,
com'è lontano il dipinto berlinese, per la morbi-
dezza delle carni, per quella « soft mistiness of
contour, which the French cali flou »,3 tanto per-
spicuamente notata dal Cavalcasene, dallo spi-
rito aspro mantegnesco! F un Mantegna illangui-
dito, così femmineo come nelle opere primitivis-
1 N. 178.
2 N. 22.
3 Cavalcaseli.^, op. cit., Ili, p. 442.
poi fin ch'ebbe vita; quantunque le prime opere,
per una certa velleità di nuovo non dimostrino
subito quella tendenza imitativa che più interessa
le nostre ricerche. Servono acl ogni modo per
testimoniarne l'educazione, e a convincerci che,
per quanto la scritta della più importante fra queste
lo dichiari discepolo di Giovanni Bellini, il fare
bambagioso e molle, le carni disossate ci accertano
ch'egli mirò piuttosto al Bissolo. Ma anche qui
la molteplicità delle influenze fu tanta che già
la prima pittura datata che gli spetta, l'Annun-
ciazione del 1504 della Galleria Carrara di Bergamo,1
in un interno carpaccesco, con una veduta di
paesaggio lagunare, per il tipo della Vergine come
piacque al Previtali, per le tinte stridule e sgar-
gianti come non le usò più Francesco di Simone,
potè far credere spettasse a un qualche altro
maestro da Santacroce.2 (fig. 1). Senza ragione,
perchè l'angelo annunciatore, incoronato di una
fronda, dalle lunghe anella di biondi capelli appare
identico nell'opera più importante di questo gruppo:
nella pala di Murano.
Certo nell'Annunciazione, proveniente da Spino,
c'è una certa crudezza che denota l'artista ancora
timido e non poco impacciato. Più decisamente
bissolesco e quindi dolciastro appare nel S. Giacomo
in abito da pellegrino, fra i SS. Alessandro e Gio-
vanni Ballista, del 7 506, che da I.eprenno passò
in casa Noli e di là ultimamente nell'Accademia
di Bergamo.3 Quest'opera, a cui un tempo si col-
legava una lunetta rappresentante il Padre Eterno,*
unita con V Jncoronazione della Vergine, traspor-
tata dalla chiesa bergamasca di S. Alessandro della
Croce nella Pinacoteca locale, ci conduce agevol-
mente alla pala di S. Pietro Martire di Murano che
è del 1507, e rappresenta il massimo risultato
artistico originale a cui sia giunto Francesco di
Simone 5 (fig. 2). Tutto vi è morbido e proprio
di un discepolo di Francesco Bissolo, dalla Madonna
flaccida e biancastra che guarda stupidamente
innanzi a sè con gli occhi teneri, al pari dell'angelo
lezioso che meccanicamente snona ai piedi del
trono la viola. Parimente fiacchi, senza salda
struttura, sono il S. Gerolamo e il profeta Zaccaria,
imbacuccato nell'ampio manto e cinto la testa
da un turbante; tipica figura che ritornerà più
e pili volte nelle opere del bergamasco e del di-
1 Accademia Carrara. Bergamo, n. 102.
2 Gir. a proposito eli questa ingiustificata opinione I.. An-
gelini, Rass. d'Arte, 1909, p. 192.
3 N. 101.
4 Cavalcasiìlli;, op. cit., Ili, p. 441, nota 2*. Fu vista
dal C. in casa Noli.
5 È questa la pala firmata: « Franciscus de Sancta t I).
I. B. 1507».
scepolo. Ed è lo sguardo dolce che fece ritenere
per opera del Boccaccino una 5. Agata del Museo
di Padova, la quale, per le carni spumose e per
la molta insulsaggine può star degnamente ac-
canto alla Madonna muranese; persino la cuffia,
Fig. 2 — Francesco di Simone: Madonna in trono e santi
Murano, S. M. degli Angeli - (Fot. Anderson).
intessuta di perle ci riconduce diritto a esemplari
bergamaschi, e precisamente ancora al Previtali 1
(fig. 3)-
Dopo questo gruppo modestamente individuale
vengono le opere che Francesco di Simone amò
ricavare dall'esempio altrui: e innanzi a tutte
VEpifania del Museo imperiale di Berlino, la quale
traduce con lievissime varianti e con vivacità di
colorito la tipica tela di scuola mantegnesca, pas-
sata da Lady Ashburton nella coli. Johson di
Philadelphia.2 Ma, pur ripetendo con precisione il
suo prototipo, con la sola esclusione della testa
di S. Giuseppe, sovra il nuovo veneto paesaggio,
com'è lontano il dipinto berlinese, per la morbi-
dezza delle carni, per quella « soft mistiness of
contour, which the French cali flou »,3 tanto per-
spicuamente notata dal Cavalcasene, dallo spi-
rito aspro mantegnesco! F un Mantegna illangui-
dito, così femmineo come nelle opere primitivis-
1 N. 178.
2 N. 22.
3 Cavalcaseli.^, op. cit., Ili, p. 442.