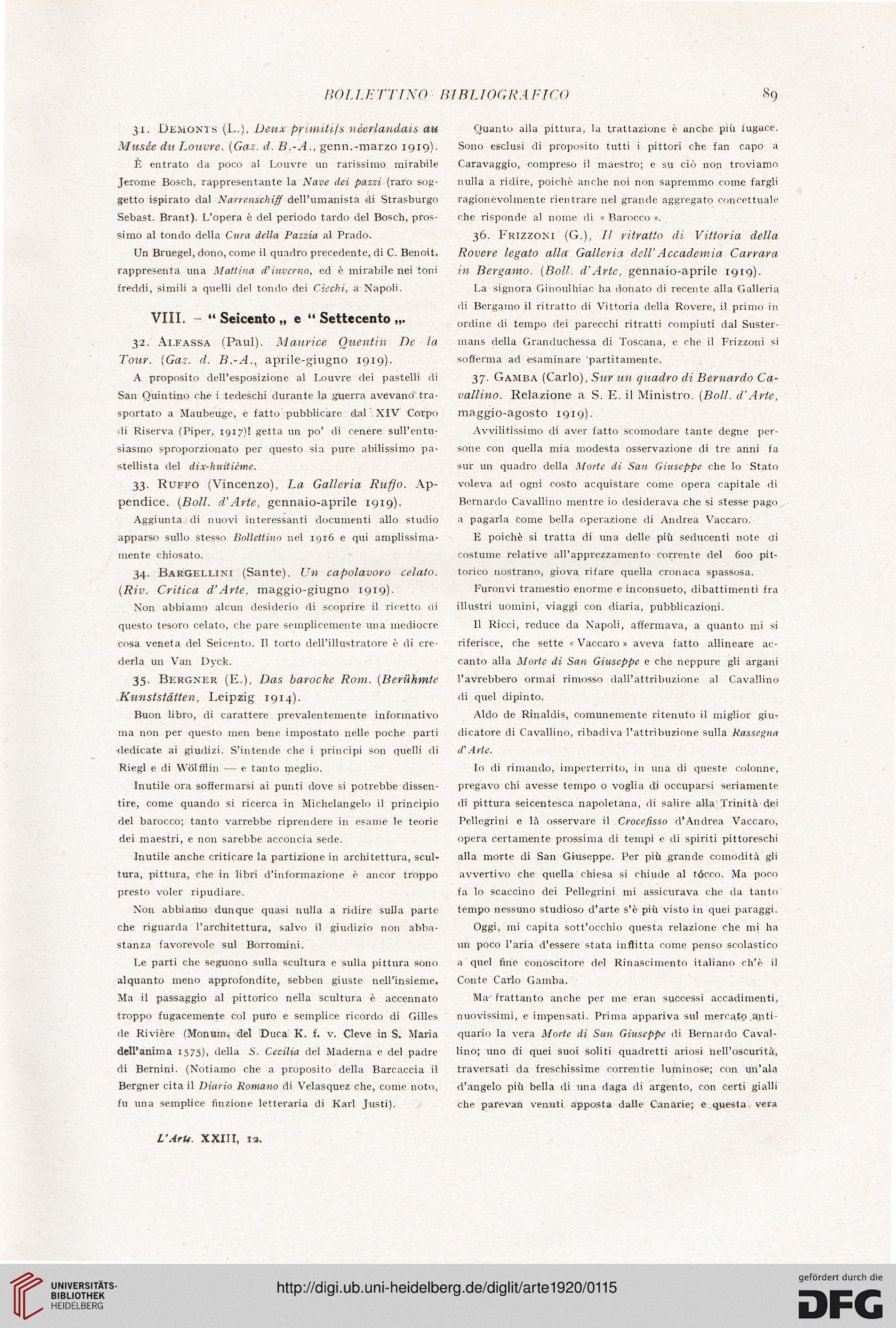BOLLETTINO BIBLIOGRA FICO
89
31. Dbhonts (-L.)ì Diux primitila iiéerlandais au
Musée du Louvre. (Gas. d. B.-A., genn.-marzo 1919).
È entrato da poco al Louvre un rarissimo mirabile
Jerome Bosch. rappresentante la Nave dei pazzi (raro sog-
getto ispirato dal Narrenschiff dell'umanista di Strasburgo
Sebast. Brant). L'opera è del periodo tardo del Bosch, pros-
simo al tondo della Cura della Pazzia al Prado.
Un Bruegel, dono, come il quadro precedente, di C. Benoit,
rappresenta una Mattina d'inverno, ed è mirabile nei toni
freddi, simili a quelli del tondo dei Cicchi, a Napoli.
Vili. - "Seicento,, e "Settecento,,.
32. Ai.fassa (Paul). Maurice Quenlin De la
Tour. (Gaz. d. B.-A., aprile-giugno 1919).
A proposito dell'esposizione al Louvre dei pastelli ili
San Quintino che i tedeschi durante la guerra avevano tra-
sportato a Maubeuge, e fatto pubblicare dal XIV Corpo
di Riserva (Piper, 1917)! getta un po' di cenere sull'entu-
siasmo sproporzionato per questo sia pure abilissimo pa-
stellista del dix-huiticme.
33. Ruffo (Vincenzo), La Galleria Ruffo. Ap-
pendice. (Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
Aggiunta di nuovi interessanti documenti allo studio
apparso sullo stesso Bollettino nel 1916 e qui amplissima-
mente chiosato.
34. Bargellini (Sante). Un capolavoro celato.
(Riv. Critica d'Arte, maggio-giugno 1919)-
Non abbiamo alcun desiderio di scoprire il ricetto di
questo tesoro celato, che pare semplicemente una mediocre
cosa veneta del Seicento. Il torto dell'illustratore è di cre-
derla un Van Dyck.
35. Bergner (E.), Das barocke Rom. (Beruhmte
Kunststàtten, Leipzig 1914).
Buon libro, di carattere prevalentemente informativo
ma non per questo men bene impostato nelle poche parti
dedicate ai giudizi. S'intende che i principi son quelli di
Riegl e di Wolfflin — e tanto meglio.
Inutile ora soffermarsi ai punti dove si potrebbe dissen-
tire, come quando si ricerca in Michelangelo il principio
del barocco; tanto varrebbe riprendere in esame le teorie
dei maestri, e non sarebbe acconcia sede.
Inutile anche criticare la partizione in architettura, scul-
tura, pittura, che in libri d'informazione è ancor troppo
presto voler ripudiare.
Non abbiamo dunque quasi nulla a ridire sulla parte
che riguarda l'architettura, salvo il giudizio non abba-
stanza favorevole sul Borromini.
Le parti che seguono sulla scultura e sulla pittura sono
alquanto meno approfondite, sebben giuste nell'insieme.
Ma il passaggio al pittorico nella scultura è accennato
troppo fugacemente col puro e semplice ricordo di Gilles
de Rivière (Monum. del Duca K. f. v. Cleve in S. Maria
dell'anima 1575), della 5. Cecilia del Maderna e del padre
di Bernini. (Notiamo che a proposito della Barcaccia il
Bergner cita il Diario Romano di Velasquez che, come noto,
fu una semplice finzione letteraria di Karl Justi).
Quanto alla pittura, la trattazione è anche più fugace.
Sono esclusi di proposito tutti i pittori che fan capo a
Caravaggio, compreso il maestro; e su ciò non troviamo
nulla a ridire, poiché anche noi non sapremmo come fargli
ragionevolmente rientrare nel grande aggregato concettuale
che risponde al nome di « Barocco ».
36. Frizzoni (G.), // ritratto di Vittoria della
Rovere legato alla Galleria dell' Accademia Carrara
in Bergamo. (Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
La signora Ginoulhiac ha donato di recente alla Galleria
di Bergamo il ritratto di Vittoria della Rovere, il primo in
ordine di tempo dei parecchi ritratti compiuti dal Suster-
mans della Granduchessa di Toscana, e che il Frizzoni si
sofferma ad esaminare 'partitamelite.
37. Gamba (Carlo), Sur un quadro dì Bernardo Ca-
vallino. Relazione a S. E. il Ministro. (Boll, d'Arte,
maggio-agosto 1919).
Avvintissimo di aver fatto scomodare tante degne per-
sone con quella mia modesta osservazione di tre anni fa
sur un quadro della Morte di San Giuseppe che lo Stato
voleva ad ogni costo acquistare come opera capitale di
Bernardo Cavallino mentre io desiderava che si stesse pago
a pagarla Come bella operazione di Andrea Vaccaro.
E poiché si tratta di una delle più seducenti note di
costume relative all'apprezzamento corrente del 600 pit-
torico nostrano, giova rifare quella cronaca spassosa.
Furonvi tramestio enorme e inconsueto, dibattimenti fra
illustri uomini, viaggi con diaria, pubblicazioni.
11 Ricci, reduce da Napoli, affermava, a quanto mi si
riferisce, che sette «Vaccaro» aveva fatto allineare ac-
canto alla Morte di San Giuseppe e che neppure gli argani
l'avrebbero ormai rimosso dall'attribuzione al Cavallino
di quel dipinto.
Aldo de Rinaldis, comunemente ritenuto il miglior giu-
dicatore di Cavallino, ribadiva l'attribuzione sulla Rassegna
d'Arte.
Io di rimando, imperterrito, in una di queste colonne,
pregavo chi avesse tempo o voglia di occuparsi seriamente
di pittura seicentesca napoletana, di salire alla Trinità dei
Pellegrini e là osservare il Crocefisso d'Andrea Vaccaro,
opera certamente prossima di tempi e di spiriti pittoreschi
alla morte di San Giuseppe. Per più grande comodità gli
avvertivo che quella chiesa si chiude al tócco. Ma poco
fa lo scaccino dei Pellegrini mi assicurava che da tanto
tempo nessuno studioso d'arte s'è più visto in quei paraggi.
Oggi, mi capita sott'occhio questa relazione che mi ha
un poco l'aria d'essere stata inflitta come penso scolastico
a quel fine conoscitore del Rinascimento italiano ch'è il
Conte Carlo Gamba.
Ma frattanto anche per ine eran successi accadimenti,
nuovissimi, e impensati. Prima appariva sul mercato anti-
quario la vera Morte di San Giuseppe di Bernardo Caval-
lino; uno di quei suoi soliti quadretti ariosi nell'oscurità,
traversati da freschissime correntie luminose; con un'ala
d'angelo più bella di una daga di argento, con certi gialli
che parevan venuti apposta dalle Canarie; e.questa vera
L'Arti. XXIII, 13.
89
31. Dbhonts (-L.)ì Diux primitila iiéerlandais au
Musée du Louvre. (Gas. d. B.-A., genn.-marzo 1919).
È entrato da poco al Louvre un rarissimo mirabile
Jerome Bosch. rappresentante la Nave dei pazzi (raro sog-
getto ispirato dal Narrenschiff dell'umanista di Strasburgo
Sebast. Brant). L'opera è del periodo tardo del Bosch, pros-
simo al tondo della Cura della Pazzia al Prado.
Un Bruegel, dono, come il quadro precedente, di C. Benoit,
rappresenta una Mattina d'inverno, ed è mirabile nei toni
freddi, simili a quelli del tondo dei Cicchi, a Napoli.
Vili. - "Seicento,, e "Settecento,,.
32. Ai.fassa (Paul). Maurice Quenlin De la
Tour. (Gaz. d. B.-A., aprile-giugno 1919).
A proposito dell'esposizione al Louvre dei pastelli ili
San Quintino che i tedeschi durante la guerra avevano tra-
sportato a Maubeuge, e fatto pubblicare dal XIV Corpo
di Riserva (Piper, 1917)! getta un po' di cenere sull'entu-
siasmo sproporzionato per questo sia pure abilissimo pa-
stellista del dix-huiticme.
33. Ruffo (Vincenzo), La Galleria Ruffo. Ap-
pendice. (Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
Aggiunta di nuovi interessanti documenti allo studio
apparso sullo stesso Bollettino nel 1916 e qui amplissima-
mente chiosato.
34. Bargellini (Sante). Un capolavoro celato.
(Riv. Critica d'Arte, maggio-giugno 1919)-
Non abbiamo alcun desiderio di scoprire il ricetto di
questo tesoro celato, che pare semplicemente una mediocre
cosa veneta del Seicento. Il torto dell'illustratore è di cre-
derla un Van Dyck.
35. Bergner (E.), Das barocke Rom. (Beruhmte
Kunststàtten, Leipzig 1914).
Buon libro, di carattere prevalentemente informativo
ma non per questo men bene impostato nelle poche parti
dedicate ai giudizi. S'intende che i principi son quelli di
Riegl e di Wolfflin — e tanto meglio.
Inutile ora soffermarsi ai punti dove si potrebbe dissen-
tire, come quando si ricerca in Michelangelo il principio
del barocco; tanto varrebbe riprendere in esame le teorie
dei maestri, e non sarebbe acconcia sede.
Inutile anche criticare la partizione in architettura, scul-
tura, pittura, che in libri d'informazione è ancor troppo
presto voler ripudiare.
Non abbiamo dunque quasi nulla a ridire sulla parte
che riguarda l'architettura, salvo il giudizio non abba-
stanza favorevole sul Borromini.
Le parti che seguono sulla scultura e sulla pittura sono
alquanto meno approfondite, sebben giuste nell'insieme.
Ma il passaggio al pittorico nella scultura è accennato
troppo fugacemente col puro e semplice ricordo di Gilles
de Rivière (Monum. del Duca K. f. v. Cleve in S. Maria
dell'anima 1575), della 5. Cecilia del Maderna e del padre
di Bernini. (Notiamo che a proposito della Barcaccia il
Bergner cita il Diario Romano di Velasquez che, come noto,
fu una semplice finzione letteraria di Karl Justi).
Quanto alla pittura, la trattazione è anche più fugace.
Sono esclusi di proposito tutti i pittori che fan capo a
Caravaggio, compreso il maestro; e su ciò non troviamo
nulla a ridire, poiché anche noi non sapremmo come fargli
ragionevolmente rientrare nel grande aggregato concettuale
che risponde al nome di « Barocco ».
36. Frizzoni (G.), // ritratto di Vittoria della
Rovere legato alla Galleria dell' Accademia Carrara
in Bergamo. (Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
La signora Ginoulhiac ha donato di recente alla Galleria
di Bergamo il ritratto di Vittoria della Rovere, il primo in
ordine di tempo dei parecchi ritratti compiuti dal Suster-
mans della Granduchessa di Toscana, e che il Frizzoni si
sofferma ad esaminare 'partitamelite.
37. Gamba (Carlo), Sur un quadro dì Bernardo Ca-
vallino. Relazione a S. E. il Ministro. (Boll, d'Arte,
maggio-agosto 1919).
Avvintissimo di aver fatto scomodare tante degne per-
sone con quella mia modesta osservazione di tre anni fa
sur un quadro della Morte di San Giuseppe che lo Stato
voleva ad ogni costo acquistare come opera capitale di
Bernardo Cavallino mentre io desiderava che si stesse pago
a pagarla Come bella operazione di Andrea Vaccaro.
E poiché si tratta di una delle più seducenti note di
costume relative all'apprezzamento corrente del 600 pit-
torico nostrano, giova rifare quella cronaca spassosa.
Furonvi tramestio enorme e inconsueto, dibattimenti fra
illustri uomini, viaggi con diaria, pubblicazioni.
11 Ricci, reduce da Napoli, affermava, a quanto mi si
riferisce, che sette «Vaccaro» aveva fatto allineare ac-
canto alla Morte di San Giuseppe e che neppure gli argani
l'avrebbero ormai rimosso dall'attribuzione al Cavallino
di quel dipinto.
Aldo de Rinaldis, comunemente ritenuto il miglior giu-
dicatore di Cavallino, ribadiva l'attribuzione sulla Rassegna
d'Arte.
Io di rimando, imperterrito, in una di queste colonne,
pregavo chi avesse tempo o voglia di occuparsi seriamente
di pittura seicentesca napoletana, di salire alla Trinità dei
Pellegrini e là osservare il Crocefisso d'Andrea Vaccaro,
opera certamente prossima di tempi e di spiriti pittoreschi
alla morte di San Giuseppe. Per più grande comodità gli
avvertivo che quella chiesa si chiude al tócco. Ma poco
fa lo scaccino dei Pellegrini mi assicurava che da tanto
tempo nessuno studioso d'arte s'è più visto in quei paraggi.
Oggi, mi capita sott'occhio questa relazione che mi ha
un poco l'aria d'essere stata inflitta come penso scolastico
a quel fine conoscitore del Rinascimento italiano ch'è il
Conte Carlo Gamba.
Ma frattanto anche per ine eran successi accadimenti,
nuovissimi, e impensati. Prima appariva sul mercato anti-
quario la vera Morte di San Giuseppe di Bernardo Caval-
lino; uno di quei suoi soliti quadretti ariosi nell'oscurità,
traversati da freschissime correntie luminose; con un'ala
d'angelo più bella di una daga di argento, con certi gialli
che parevan venuti apposta dalle Canarie; e.questa vera
L'Arti. XXIII, 13.