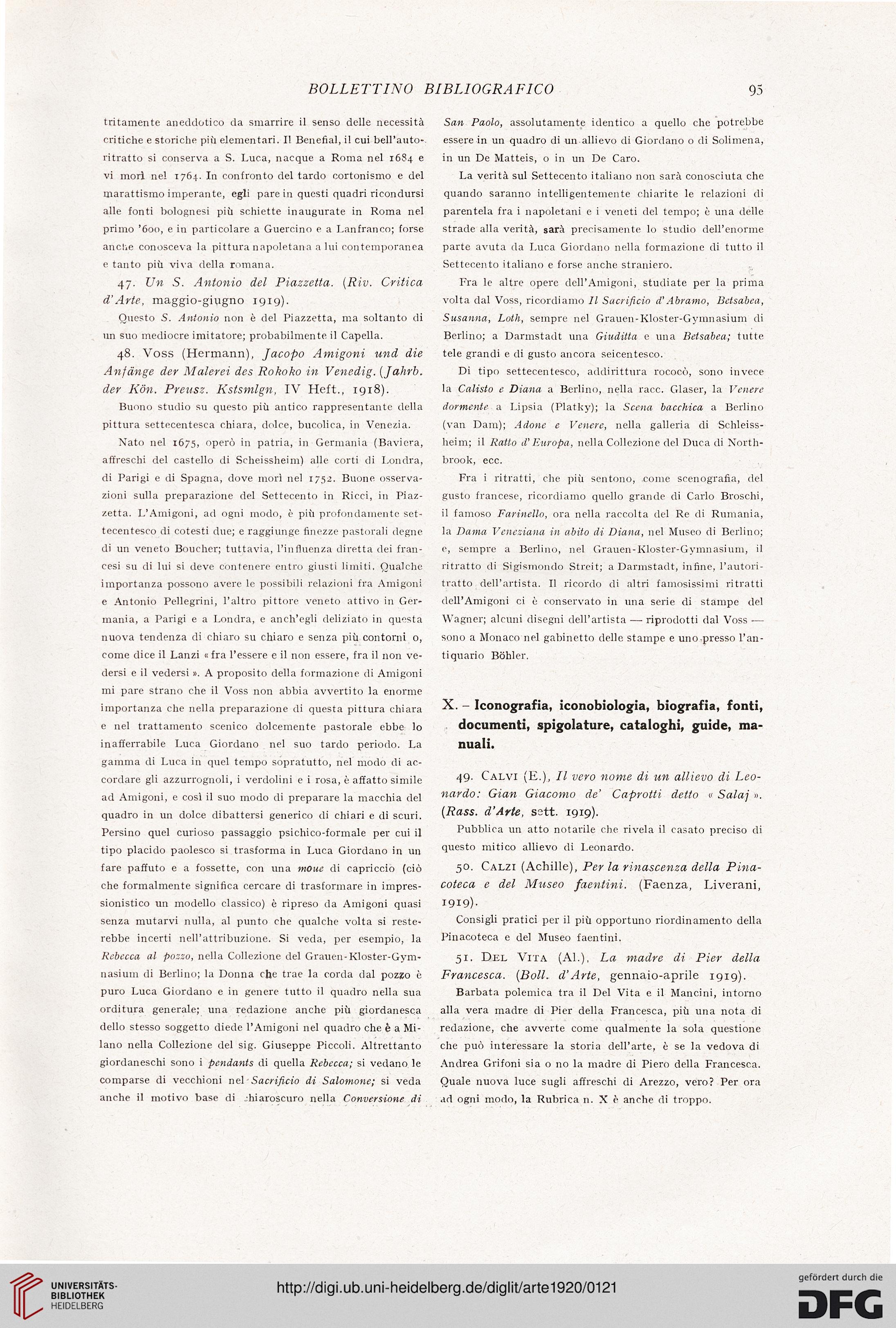BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
95
tritamente aneddotico da smarrire il senso delle necessità
critiche e storiche più elementari. I! Benefial, il cui bell'auto-
ritratto si conserva a S. Luca, nacque a Roma nel 1684 e
vi morì nel 1764. In confronto del tardo cortonismo e del
marattismo imperante, egli pare in questi quadri ricondursi
alle fonti bolognesi più schiette inaugurate in Roma nel
primo '600, e in particolare a Guercino e a Lanfranco; forse
anche conosceva la pittura napoletana a lui contemporanea
e tanto più viva della romana.
47. Un S. Antonio del Piazzetta. {Riv. Critica
d'Arte, maggio-giugno 1919).
Questo S. Antonio non è del Piazzetta, ma soltanto di
un suo mediocre imitatore; probabilmente il Capella.
48. Voss (Hermann), Jacopo Amigoni und die
Anfànge der Malerei des Rokoko in Venedig. (Jalirb.
der Kon. Preusz. Kstsmlgn, IV Hoft., 1918).
Buono studio su questo più antico rappresentante della
pittura settecentesca chiara, dolce, bucolica, in Venezia.
Nato nel 1675, operò in patria, in Germania (Baviera,
affreschi del castello di Scheissheim) alle corti di Londra,
di Parigi e di Spagna, dove mori nel 1752. Buone osserva-
zioni sulla preparazione del Settecento in Ricci, in Piaz-
zetta. L'Amigoni, ad ogni modo, è più profondamente set-
tecentesco di cotesti due; e raggiunge finezze pastorali degne
di un veneto Boucher; tuttavia, l'influenza diretta dei fran-
cesi su di lui si deve contenere entro giusti limiti. Qualche
importanza possono avere le possibili relazioni fra Amigoni
e Antonio Pellegrini, l'altro pittore veneto attivo in Ger-
mania, a Parigi e a Londra, e anch'egli deliziato in questa
nuova tendenza di chiaro su chiaro e senza più contorni 0,
come dice il Lanzi « fra l'essere e il non essere, fra il non ve-
dersi e il vedersi ». A proposito della formazione di Amigoni
mi pare strano che il Voss non abbia avvertito la enorme
importanza che nella preparazione di questa pittura chiara
e nel trattamento scenico dolcemente pastorale ebbe lo
inafferrabile Luca Giordano nel suo tardo periodo. La
gamma di Luca in quel tempo sopratutto, nel modo di ac-
cordare gli azzurrognoli, i verdolini e i rosa, è affatto simile
ad Amigoni, e così il suo modo di preparare la macchia del
quadro in un dolce dibattersi generico di chiari e di scuri.
Persino quel curioso passaggio psichico-formale per cui il
tipo placido paolesco si trasforma in Luca Giordano in un
fare paffuto e a fossette, con una mouc di capriccio (ciò
che formalmente significa cercare di trasformare in impres-
sionistico un modello classico) è ripreso da Amigoni quasi
senza mutarvi nulla, al punto che qualche volta si reste-
rebbe incerti nell'attribuzione. Si veda, per esempio, la
Rebecca al pozzo, nella Collezione del Graueu-Kloster-Gym-
nasium di Berlino; la Donna che trae la corda dal pozzo è
puro Luca Giordano e in genere tutto il quadro nella sua
orditura generale; una redazione anche più giordanesca
dello stesso soggetto diede l'Amigoni nel quadro che è a Mi-
lano nella Collezione del sig. Giuseppe Piccoli. Altrettanto
giordaneschi sono i pendants di quella Rebecca; si vedano le
comparse di vecchioni nel Sacrificio di Salomone; si veda
anche il motivo base di chiaroscuro nella Conversione di
San Paolo, assolutamente identico a quello che potrebbe
essere in un quadro di un allievo di Giordano o di Solimena,
in un De Matteis, o in un De Caro.
La verità sul Settecento italiano non sarà conosciuta che
quando saranno intelligentemente chiarite le relazioni di
parentela fra i napoletani e i veneti del tempo; è una delle
strade alla verità, sarà precisamente lo studio dell'enorme
parte avuta da Luca Giordano nella formazione di tutto il
Settecento italiano e forse anche straniero.
Fra le altre opere dcll'Amigoni, studiate per la prima
volta dal Voss, ricordiamo II Sacrificio d'Abramo, Betsabea,
Susanna, Lotk, sempre nel Grauen-Kloster-Gymnasium di
Berlino; a Darmstadt una Giuditta e una Betsabea; tutte
tele grandi e di gusto ancora seicentesco.
Di tipo settecentesco, addirittura rococò, sono invece
la Calisto e Diana a Berlino, nella race. Glaser, la Venere
dormente a Lipsia (Platky); la Scena bacchica a Berlino
(van Dara); Adone e Venere, nella galleria di Schleiss-
heim; il Ratto d'Europa, nella Collezione del Duca di Xorth-
brook, ecc.
Fra i ritratti, che più sentono, come scenografia, del
gusto francese, ricordiamo quello grande di Carlo Broschi,
il famoso Farinello, ora nella raccolta del Re di Rumania,
la Dama Veneziana in abito di Diana, nel Museo di Berlino;
e, sempre a Berlino, nel Grauen-Kloster-Gymnasium, il
ritratto di Sigismondo Streit; a Darmstadt, infine, l'autori-
tratto dell'artista. Il ricordo di altri famosissimi ritratti
dcll'Amigoni ci è conservato in una serie di stampe del
Wagner; alcuni disegni dell'artista — riprodotti dal Voss —
sono a Monaco nel gabinetto delle, stampe e uno presso l'an-
tiquario Bohler.
X. - Iconografia, iconobiologia, biografia, fonti,
documenti, spigolature, cataloghi, guide, ma-
nuali.
49. Calvi (E.), Il vero nome di un allievo di Leo-
nardo: Gian Giacomo de' Caprotti detto « Salaj ».
(Rass. d'Arte, sott. 1919).
Pubblica un atto notarile che rivela il casato preciso di
questo mitico allievo di Leonardo.
50. Calzi (Achille), Per la rinascenza della Pina-
coteca e del Museo faentini. (Faenza, Liverani,
1919).
Consigli pratici per il più opportuno riordinamento della
Pinacoteca e del Museo faentini.
51. Del Vita (Al.), La madre di Pier della
Francesca. {Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
Barbata polemica tra il Del Vita e il Mancini, intorno
alla vera madre di Pier della Francesca, più una nota di
redazione, che avverte come qualmente la sola questione
che può interessare la storia dell'arte, è se la vedova di
Andrea Grifoni sia o no la madre di Piero della Francesca.
Quale nuova luce sugli affreschi di Arezzo, vero? Per ora
ad ogni modo, la Rubrica n. X è anche di troppo.
95
tritamente aneddotico da smarrire il senso delle necessità
critiche e storiche più elementari. I! Benefial, il cui bell'auto-
ritratto si conserva a S. Luca, nacque a Roma nel 1684 e
vi morì nel 1764. In confronto del tardo cortonismo e del
marattismo imperante, egli pare in questi quadri ricondursi
alle fonti bolognesi più schiette inaugurate in Roma nel
primo '600, e in particolare a Guercino e a Lanfranco; forse
anche conosceva la pittura napoletana a lui contemporanea
e tanto più viva della romana.
47. Un S. Antonio del Piazzetta. {Riv. Critica
d'Arte, maggio-giugno 1919).
Questo S. Antonio non è del Piazzetta, ma soltanto di
un suo mediocre imitatore; probabilmente il Capella.
48. Voss (Hermann), Jacopo Amigoni und die
Anfànge der Malerei des Rokoko in Venedig. (Jalirb.
der Kon. Preusz. Kstsmlgn, IV Hoft., 1918).
Buono studio su questo più antico rappresentante della
pittura settecentesca chiara, dolce, bucolica, in Venezia.
Nato nel 1675, operò in patria, in Germania (Baviera,
affreschi del castello di Scheissheim) alle corti di Londra,
di Parigi e di Spagna, dove mori nel 1752. Buone osserva-
zioni sulla preparazione del Settecento in Ricci, in Piaz-
zetta. L'Amigoni, ad ogni modo, è più profondamente set-
tecentesco di cotesti due; e raggiunge finezze pastorali degne
di un veneto Boucher; tuttavia, l'influenza diretta dei fran-
cesi su di lui si deve contenere entro giusti limiti. Qualche
importanza possono avere le possibili relazioni fra Amigoni
e Antonio Pellegrini, l'altro pittore veneto attivo in Ger-
mania, a Parigi e a Londra, e anch'egli deliziato in questa
nuova tendenza di chiaro su chiaro e senza più contorni 0,
come dice il Lanzi « fra l'essere e il non essere, fra il non ve-
dersi e il vedersi ». A proposito della formazione di Amigoni
mi pare strano che il Voss non abbia avvertito la enorme
importanza che nella preparazione di questa pittura chiara
e nel trattamento scenico dolcemente pastorale ebbe lo
inafferrabile Luca Giordano nel suo tardo periodo. La
gamma di Luca in quel tempo sopratutto, nel modo di ac-
cordare gli azzurrognoli, i verdolini e i rosa, è affatto simile
ad Amigoni, e così il suo modo di preparare la macchia del
quadro in un dolce dibattersi generico di chiari e di scuri.
Persino quel curioso passaggio psichico-formale per cui il
tipo placido paolesco si trasforma in Luca Giordano in un
fare paffuto e a fossette, con una mouc di capriccio (ciò
che formalmente significa cercare di trasformare in impres-
sionistico un modello classico) è ripreso da Amigoni quasi
senza mutarvi nulla, al punto che qualche volta si reste-
rebbe incerti nell'attribuzione. Si veda, per esempio, la
Rebecca al pozzo, nella Collezione del Graueu-Kloster-Gym-
nasium di Berlino; la Donna che trae la corda dal pozzo è
puro Luca Giordano e in genere tutto il quadro nella sua
orditura generale; una redazione anche più giordanesca
dello stesso soggetto diede l'Amigoni nel quadro che è a Mi-
lano nella Collezione del sig. Giuseppe Piccoli. Altrettanto
giordaneschi sono i pendants di quella Rebecca; si vedano le
comparse di vecchioni nel Sacrificio di Salomone; si veda
anche il motivo base di chiaroscuro nella Conversione di
San Paolo, assolutamente identico a quello che potrebbe
essere in un quadro di un allievo di Giordano o di Solimena,
in un De Matteis, o in un De Caro.
La verità sul Settecento italiano non sarà conosciuta che
quando saranno intelligentemente chiarite le relazioni di
parentela fra i napoletani e i veneti del tempo; è una delle
strade alla verità, sarà precisamente lo studio dell'enorme
parte avuta da Luca Giordano nella formazione di tutto il
Settecento italiano e forse anche straniero.
Fra le altre opere dcll'Amigoni, studiate per la prima
volta dal Voss, ricordiamo II Sacrificio d'Abramo, Betsabea,
Susanna, Lotk, sempre nel Grauen-Kloster-Gymnasium di
Berlino; a Darmstadt una Giuditta e una Betsabea; tutte
tele grandi e di gusto ancora seicentesco.
Di tipo settecentesco, addirittura rococò, sono invece
la Calisto e Diana a Berlino, nella race. Glaser, la Venere
dormente a Lipsia (Platky); la Scena bacchica a Berlino
(van Dara); Adone e Venere, nella galleria di Schleiss-
heim; il Ratto d'Europa, nella Collezione del Duca di Xorth-
brook, ecc.
Fra i ritratti, che più sentono, come scenografia, del
gusto francese, ricordiamo quello grande di Carlo Broschi,
il famoso Farinello, ora nella raccolta del Re di Rumania,
la Dama Veneziana in abito di Diana, nel Museo di Berlino;
e, sempre a Berlino, nel Grauen-Kloster-Gymnasium, il
ritratto di Sigismondo Streit; a Darmstadt, infine, l'autori-
tratto dell'artista. Il ricordo di altri famosissimi ritratti
dcll'Amigoni ci è conservato in una serie di stampe del
Wagner; alcuni disegni dell'artista — riprodotti dal Voss —
sono a Monaco nel gabinetto delle, stampe e uno presso l'an-
tiquario Bohler.
X. - Iconografia, iconobiologia, biografia, fonti,
documenti, spigolature, cataloghi, guide, ma-
nuali.
49. Calvi (E.), Il vero nome di un allievo di Leo-
nardo: Gian Giacomo de' Caprotti detto « Salaj ».
(Rass. d'Arte, sott. 1919).
Pubblica un atto notarile che rivela il casato preciso di
questo mitico allievo di Leonardo.
50. Calzi (Achille), Per la rinascenza della Pina-
coteca e del Museo faentini. (Faenza, Liverani,
1919).
Consigli pratici per il più opportuno riordinamento della
Pinacoteca e del Museo faentini.
51. Del Vita (Al.), La madre di Pier della
Francesca. {Boll. d'Arte, gennaio-aprile 1919).
Barbata polemica tra il Del Vita e il Mancini, intorno
alla vera madre di Pier della Francesca, più una nota di
redazione, che avverte come qualmente la sola questione
che può interessare la storia dell'arte, è se la vedova di
Andrea Grifoni sia o no la madre di Piero della Francesca.
Quale nuova luce sugli affreschi di Arezzo, vero? Per ora
ad ogni modo, la Rubrica n. X è anche di troppo.