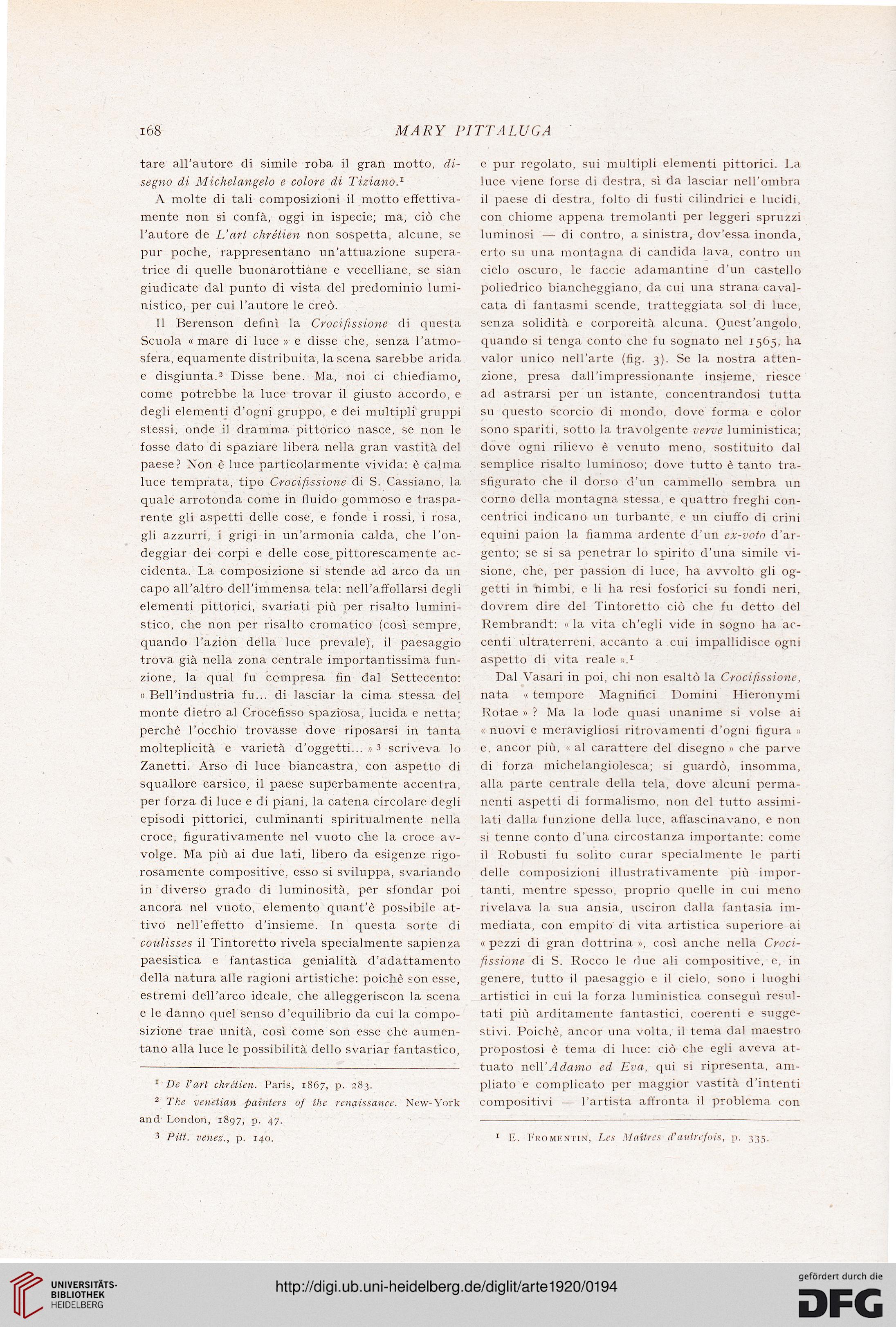i68
MARY PITTA LUCA
tare all'autore di simile roba il gran motto, di-
segno di Michelangelo e colore di Tiziano.1
A molte di tali composizioni il motto effettiva-
mente non si confà, oggi in ispecie; ma, ciò che
l'autore de L'art chrétien non sospetta, alcune, se
pur poche, rappresentano un'attuazione supera-
tricc di quelle buonarottiane e vecelliane, se sian
giudicate dal punto di vista del predominio lumi-
nistico, per cui l'autore le creò.
Il Berenson definì la Crocifissione di questa
Scuola « mare di luce » e disse che, senza l'atmo-
sfera, equamente distribuita, la scena sarebbe arida
e disgiunta.2 Disse bene. Ma, noi ci chiediamo,
come potrebbe la luce trovar il giusto accordo, e
degli elementi d'ogni gruppo, e dei multipli gruppi
stessi, onde il dramma, pittorico nasce, se non le
fosse dato di spaziare libera nella gran vastità del
paese? Non è luce particolarmente vivida: è calma
luce temprata, tipo Crocifissione di S. Cassiano, la
quale arrotonda come in fluido gommoso e traspa-
rente gli aspetti delle cose, e fonde i rossi, i rosa,
gli azzurri, i grigi in un'armonia calda, che l'on-
deggiar dei corpi e delle cose,pittorescamente ac-
cidenta. La composizione si stende ad arco da un
capo all'altro dell'immensa tela: nell'affollarsi degli
elementi pittorici, svariati più per risalto lumini-
stico, che non per risalto cromatico (così sempre,
quando l'azion della luce prevale), il paesaggio
trova già nella zona centrale importantissima fun-
zione, la qual fu compresa fin dal Settecento:
« Bell'industria fu... di lasciar la cima stessa del
monte dietro al Crocefisso spaziosa, lucida e netta;
perchè l'occhio trovasse dove riposarsi in tanta
molteplicità e varietà d'oggetti... » 3 scriveva lo
Zanetti. Arso di luce biancastra, con aspetto di
squallore carsico, il paese superbamente accentra,
per forza di luce e di piani, la catena circolare degli
episodi pittorici, culminanti spiritualmente nella
croce, figurativamente nel vuoto che la croce av-
volge. Ma più ai due lati, libero da esigenze rigo-
rosamente compositive, esso si sviluppa, svariando
in diverso grado di luminosità, per sfondar poi
ancora nel vuoto, elemento quant'è possibile at-
tivo nell'effetto d'insieme. In questa sorte di
coulisses il Tintoretto rivela specialmente sapienza
paesistica e fantastica genialità d'adattamento
della natura alle ragioni artistiche: poiché son esse,
estremi dell'arco ideale, che alleggeriscon la scena
e le danno quel senso d'equilibrio da cui la compo-
sizione trae unità, così come son esse che aumen-
tano alla luce le possibilità dello svariar fantastico,
1 De l'art chrétien. Paris, 1867, p. 283.
2 The venetian painters of the renaissance. New-York
and London, 1897, p. 47.
3 Pitt. venti., p. 140.
e pur regolato, sui multipli elementi pittorici. La
luce viene forse di destra, sì da lasciar nell'ombra
il paese di destra, folto di fusti cilindrici e lucidi,
con chiome appena tremolanti per leggeri spruzzi
luminosi — di contro, a sinistra, dov'essa inonda,
erto su una montagna di candida lava, contro un
cielo oscuro, le l'accie adamantine d'un castello
poliedrico biancheggiano, da cui una strana caval-
cata di fantasmi scende, tratteggiata sol di luce,
senza solidità e corporeità alcuna. Quest'angolo,
quando si tenga conto che fu sognato nel 1565, ha
valor unico nell'arte (fig. 3). Se la nostra atten-
zione, presa dall'impressionante insieme, riesce
ad astrarsi per un istante, concentrandosi tutta
su questo scorcio di mondo, dove forma e color
sono spariti, sotto la travolgente verve luministica;
dove ogni rilievo è venuto meno, sostituito dal
semplice risalto luminoso; dove tutto è tanto tra-
sfigurato che il dorso d'un cammello sembra un
corno della montagna stessa, e quattro freghi con-
centrici indicano un turbante, e un ciuffo di crini
equini paion la fiamma ardente d'un ex-voto d'ar-
gento; se si sa penetrar lo spirito d'una simile vi-
sione, che, per passion di luce, ha avvolto gli og-
getti in nimbi, e li ha resi fosforici su fondi neri,
dovrem dire del Tintoretto ciò che fu detto del
Rcmbrandt: « la vita ch'egli vide in sogno ha ac-
centi ultraterreni, accanto a cui impallidisce ogni
aspetto di vita reale ».J
Dal Vasari in poi, chi non esaltò la Crocifissione,
nata « tempore Magnifici Domini Hieronymi
Rotae » ? Ma la lode quasi unanime si volse ai
« nuovi e meravigliosi ritrovamenti d'ogni figura »
e, ancor più, « al carattere del disegno » che parve
di forza michelangiolesca; si guardò, insomma,
alla parte centrale della tela, dove alcuni perma-
nenti aspetti di formalismo, non del tutto assimi-
lati dalla funzione della luce, affascinavano, e non
si tenne conto d'una circostanza importante: come
il Robusti fu solito curar specialmente le parti
delle composizioni illustrativamente più impor-
tanti, mentre spesso, proprio quelle in cui meno
rivelava la sua ansia, usciron dalla fantasia im-
mediata, con empito di vita artistica superiore ai
« pezzi di gran dottrina », così anche nella Croci-
fissione di S. Rocco le due ali compositive, e, in
genere, tutto il paesaggio e il cielo, sono i luoghi
artistici in cui la forza luministica conseguì resul-
tati più arditamente fantastici, coerenti e sugge-
stivi. Poiché, ancor una volta, il tema dal maestro
propostosi è tema di luce: ciò che egli aveva at-
tuato nell'Adamo ed Eva, qui si ripresenta, am-
pliato e complicato per maggior vastità d'intenti
compositivi — l'artista affronta il problema con
1 E. \''kOHKNriN, Les Maitres d'nutrefuis, p. 335.
MARY PITTA LUCA
tare all'autore di simile roba il gran motto, di-
segno di Michelangelo e colore di Tiziano.1
A molte di tali composizioni il motto effettiva-
mente non si confà, oggi in ispecie; ma, ciò che
l'autore de L'art chrétien non sospetta, alcune, se
pur poche, rappresentano un'attuazione supera-
tricc di quelle buonarottiane e vecelliane, se sian
giudicate dal punto di vista del predominio lumi-
nistico, per cui l'autore le creò.
Il Berenson definì la Crocifissione di questa
Scuola « mare di luce » e disse che, senza l'atmo-
sfera, equamente distribuita, la scena sarebbe arida
e disgiunta.2 Disse bene. Ma, noi ci chiediamo,
come potrebbe la luce trovar il giusto accordo, e
degli elementi d'ogni gruppo, e dei multipli gruppi
stessi, onde il dramma, pittorico nasce, se non le
fosse dato di spaziare libera nella gran vastità del
paese? Non è luce particolarmente vivida: è calma
luce temprata, tipo Crocifissione di S. Cassiano, la
quale arrotonda come in fluido gommoso e traspa-
rente gli aspetti delle cose, e fonde i rossi, i rosa,
gli azzurri, i grigi in un'armonia calda, che l'on-
deggiar dei corpi e delle cose,pittorescamente ac-
cidenta. La composizione si stende ad arco da un
capo all'altro dell'immensa tela: nell'affollarsi degli
elementi pittorici, svariati più per risalto lumini-
stico, che non per risalto cromatico (così sempre,
quando l'azion della luce prevale), il paesaggio
trova già nella zona centrale importantissima fun-
zione, la qual fu compresa fin dal Settecento:
« Bell'industria fu... di lasciar la cima stessa del
monte dietro al Crocefisso spaziosa, lucida e netta;
perchè l'occhio trovasse dove riposarsi in tanta
molteplicità e varietà d'oggetti... » 3 scriveva lo
Zanetti. Arso di luce biancastra, con aspetto di
squallore carsico, il paese superbamente accentra,
per forza di luce e di piani, la catena circolare degli
episodi pittorici, culminanti spiritualmente nella
croce, figurativamente nel vuoto che la croce av-
volge. Ma più ai due lati, libero da esigenze rigo-
rosamente compositive, esso si sviluppa, svariando
in diverso grado di luminosità, per sfondar poi
ancora nel vuoto, elemento quant'è possibile at-
tivo nell'effetto d'insieme. In questa sorte di
coulisses il Tintoretto rivela specialmente sapienza
paesistica e fantastica genialità d'adattamento
della natura alle ragioni artistiche: poiché son esse,
estremi dell'arco ideale, che alleggeriscon la scena
e le danno quel senso d'equilibrio da cui la compo-
sizione trae unità, così come son esse che aumen-
tano alla luce le possibilità dello svariar fantastico,
1 De l'art chrétien. Paris, 1867, p. 283.
2 The venetian painters of the renaissance. New-York
and London, 1897, p. 47.
3 Pitt. venti., p. 140.
e pur regolato, sui multipli elementi pittorici. La
luce viene forse di destra, sì da lasciar nell'ombra
il paese di destra, folto di fusti cilindrici e lucidi,
con chiome appena tremolanti per leggeri spruzzi
luminosi — di contro, a sinistra, dov'essa inonda,
erto su una montagna di candida lava, contro un
cielo oscuro, le l'accie adamantine d'un castello
poliedrico biancheggiano, da cui una strana caval-
cata di fantasmi scende, tratteggiata sol di luce,
senza solidità e corporeità alcuna. Quest'angolo,
quando si tenga conto che fu sognato nel 1565, ha
valor unico nell'arte (fig. 3). Se la nostra atten-
zione, presa dall'impressionante insieme, riesce
ad astrarsi per un istante, concentrandosi tutta
su questo scorcio di mondo, dove forma e color
sono spariti, sotto la travolgente verve luministica;
dove ogni rilievo è venuto meno, sostituito dal
semplice risalto luminoso; dove tutto è tanto tra-
sfigurato che il dorso d'un cammello sembra un
corno della montagna stessa, e quattro freghi con-
centrici indicano un turbante, e un ciuffo di crini
equini paion la fiamma ardente d'un ex-voto d'ar-
gento; se si sa penetrar lo spirito d'una simile vi-
sione, che, per passion di luce, ha avvolto gli og-
getti in nimbi, e li ha resi fosforici su fondi neri,
dovrem dire del Tintoretto ciò che fu detto del
Rcmbrandt: « la vita ch'egli vide in sogno ha ac-
centi ultraterreni, accanto a cui impallidisce ogni
aspetto di vita reale ».J
Dal Vasari in poi, chi non esaltò la Crocifissione,
nata « tempore Magnifici Domini Hieronymi
Rotae » ? Ma la lode quasi unanime si volse ai
« nuovi e meravigliosi ritrovamenti d'ogni figura »
e, ancor più, « al carattere del disegno » che parve
di forza michelangiolesca; si guardò, insomma,
alla parte centrale della tela, dove alcuni perma-
nenti aspetti di formalismo, non del tutto assimi-
lati dalla funzione della luce, affascinavano, e non
si tenne conto d'una circostanza importante: come
il Robusti fu solito curar specialmente le parti
delle composizioni illustrativamente più impor-
tanti, mentre spesso, proprio quelle in cui meno
rivelava la sua ansia, usciron dalla fantasia im-
mediata, con empito di vita artistica superiore ai
« pezzi di gran dottrina », così anche nella Croci-
fissione di S. Rocco le due ali compositive, e, in
genere, tutto il paesaggio e il cielo, sono i luoghi
artistici in cui la forza luministica conseguì resul-
tati più arditamente fantastici, coerenti e sugge-
stivi. Poiché, ancor una volta, il tema dal maestro
propostosi è tema di luce: ciò che egli aveva at-
tuato nell'Adamo ed Eva, qui si ripresenta, am-
pliato e complicato per maggior vastità d'intenti
compositivi — l'artista affronta il problema con
1 E. \''kOHKNriN, Les Maitres d'nutrefuis, p. 335.