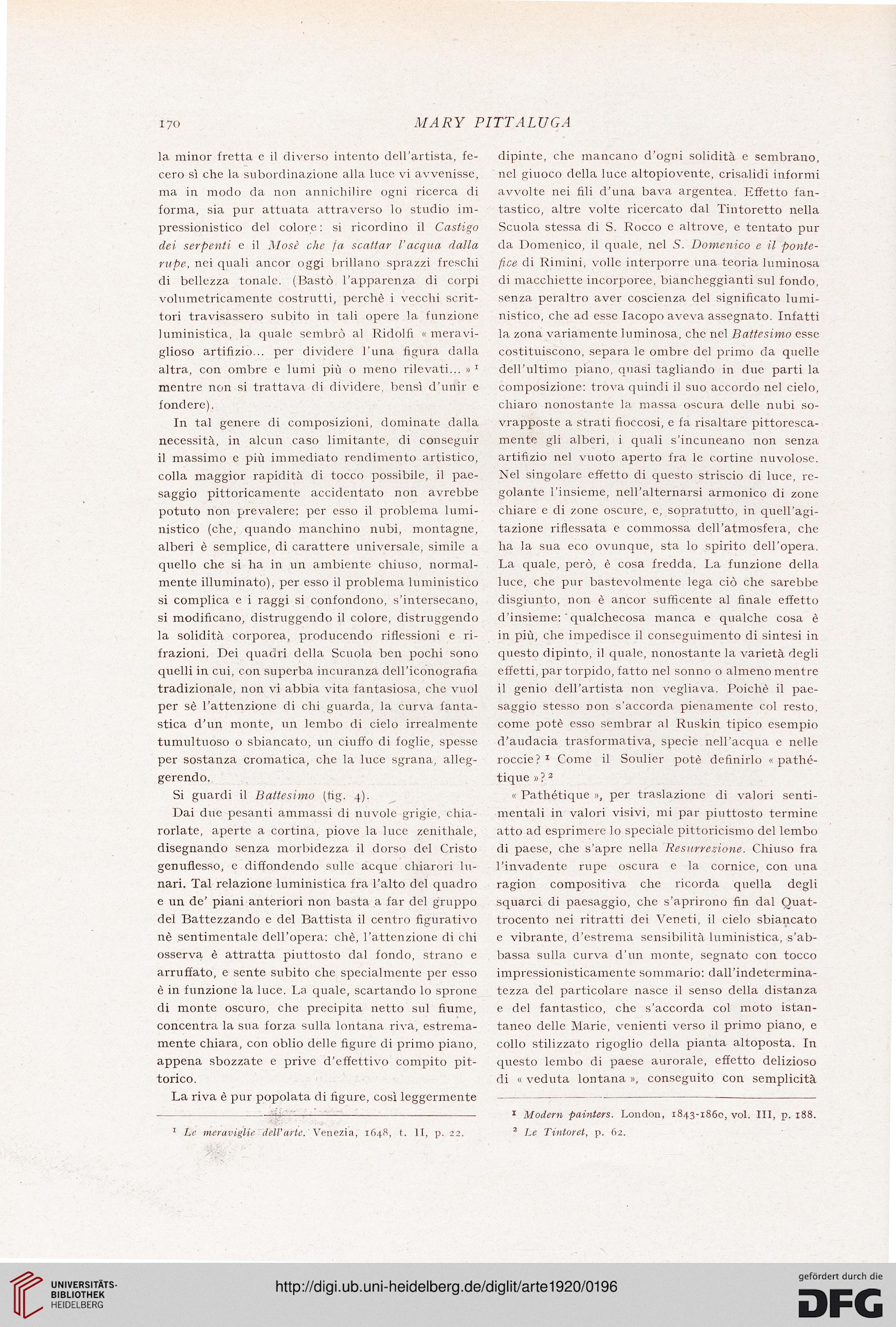170
MARY PITTA LUCA
la minor fretta e il diverso intento dell'artista, fe-
cero sì che la subordinazione alla luce vi avvenisse,
ma in modo da non annichilire ogni ricerca di
forma, sia pur attuata attraverso lo studio im-
pressionistico del colore : si ricordino il Castigo
dei serpenti e il Mose che ja scattar l'acqua dalla
rupe, nei quali ancor oggi brillano sprazzi freschi
di bellezza tonale. (Bastò l'apparenza di corpi
volumetricamente costrutti, perchè i vecchi scrit-
tori travisassero subito in tali opere la funzione
luministica, la quale sembrò al Ridolfi « meravi-
glioso artifizio... per dividere l'ima figura dalla
altra, con ombre e lumi più o meno rilevati... » 1
mentre non si trattava di dividere, bensì d'unir e
fondere).
In tal genere di composizioni, dominate dalla
necessità, in alcun caso limitante, di conseguir
il massimo e più immediato rendimento artistico,
colla maggior rapidità di tocco possibile, il pae-
saggio pittoricamente accidentato non avrebbe
potuto non prevalere: per esso il problema lumi-
nistico (che, quando manchino nubi, montagne,
alberi è semplice, di carattere universale, simile a
quello che si ha in un ambiente chiuso, normal-
mente illuminato), per esso il problema luministico
si complica e i raggi si confondono, s'intersecano,
si modificano, distruggendo il colore, distruggendo
la solidità corporea, producendo riflessioni e ri-
frazioni. Dei quadri della Scuola ben pochi sono
quelli in cui, con superba incuranza dell'iconografia
tradizionale, non vi abbia vita fantasiosa, che vuol
per sè l'attenzione di chi guarda, la curva fanta-
stica d'un monte, un lembo di cielo irrealmente
tumultuoso o sbiancato, un ciuffo di foglie, spesse
per sostanza cromatica, che la luce sgrana, alleg-
gerendo.
Si guardi il Battesimo (tìg. 4).
Dai due pesanti ammassi di nuvole grigie, chia-
rorlate, aperte a cortina, piove la luce zenithale,
disegnando senza morbidezza il dorso del Cristo
genuflesso, e diffondendo sulle acque chiarori lu-
nari. Tal relazione luministica fra l'alto del quadro
e un de' piani anteriori non basta a far del gruppo
del Battezzando e del Battista il centro figurativo
nè sentimentale dell'opera: chè, l'attenzione di chi
osserva è attratta piuttosto dal fondo, strano e
arruffato, e sente subito che specialmente per esso
è in funzione la luce. La quale, scartando lo sprone
di monte oscuro, che precipita netto sul fiume,
concentra la sua forza sulla lontana riva, estrema-
mente chiara, con oblio delle figure di primo piano,
appena sbozzate e prive d'effettivo compito pit-
torico.
La riva è pur popolata di figure, così leggermente
1 Le meraviglie lìelVtirte;'Venezia, 1648, t. IT, p. 22.
dipinte, che mancano d'ogni solidità e sembrano,
nel giuoco della luce altopiovente, crisalidi informi
avvolte nei fili d'una bava argentea. Effetto fan-
tastico, altre volte ricercato dal Tintoretto nella
Scuola stessa di S. Rocco e altrove, e tentato pur
da Domenico, il quale, nel S. Domenico e il ponte-
fice di Rimini, volle interporre una teoria luminosa
di macchiette incorporee, biancheggianti sul fondo,
senza peraltro aver coscienza del significato lumi-
nistico, che ad esse Iacopo aveva assegnato. Infatti
la zona variamente luminosa, che nel Battesimo esse
costituiscono, separa le ombre del primo da quelle
dell'ultimo piano, quasi tagliando in due parti la
composizione: trova quindi il suo accordo nel cielo,
chiaro nonostante la massa oscura delle nubi so-
vrapposte a strati fioccosi, e fa risaltare pittoresca-
mente gli alberi, i quali s'incuneano non senza
artifizio nel vuoto aperto fra le cortine nuvolose.
Nel singolare effetto di questo striscio di luce, re-
golante l'insieme, nell'alternarsi armonico di zone
chiare e di zone oscure, e, sopratutto, in quell'agi-
tazione riflessata e commossa dell'atmosfera, che
ha la sua eco ovunque, sta lo spirito dell'opera.
La quale, però, è cosa fredda. La funzione della
luce, che pur bastevolmente lega ciò che sarebbe
disgiunto, non è ancor sufficente al finale effetto
d'insieme: ' qualchecosa manca e qualche cosa è
in più, che impedisce il conseguimento di sintesi in
questo dipinto, il quale, nonostante la varietà degli
effetti, par torpido, fatto nel sonno o almeno mentre
il genio dell'artista non vegliava. Poiché il pae-
saggio stesso non s'accorda pienamente col resto,
come potè esso sembrar al Ruskin tipico esempio
d'audacia trasformativa, specie nell'acqua e nelle
roccie? 1 Come il Soulier potè definirlo « pathé-
tique »?2
« Pathétique », per traslazione di valori senti-
mentali in valori visivi, mi par piuttosto termine
atto ad esprimere lo speciale pittoricismo del lembo
di paese, che s'apre nella Resurrezione. Chiuso fra
l'invadente rupe oscura e la cornice, con una
ragion compositiva che ricorda quella degli
squarci di paesaggio, che s'aprirono fin dal Quat-
trocento nei ritratti dei Veneti, il cielo sbiancato
e vibrante, d'estrema sensibilità luministica, s'ab-
bassa sulla curva d'un monte, segnato con tocco
impressionisticamente sommario: dall'indetermina-
tezza del particolare nasce il senso della distanza
e del fantastico, che s'accorda col moto istan-
taneo delle Marie, venienti verso il primo piano, e
collo stilizzato rigoglio della pianta altoposta. In
questo lembo di paese aurorale, effetto delizioso
di « veduta lontana », conseguito con semplicità
1 Modem painters. London, 1843-1860, voi. Ili, p. 188.
2 Le Tintoret, p. 62.
MARY PITTA LUCA
la minor fretta e il diverso intento dell'artista, fe-
cero sì che la subordinazione alla luce vi avvenisse,
ma in modo da non annichilire ogni ricerca di
forma, sia pur attuata attraverso lo studio im-
pressionistico del colore : si ricordino il Castigo
dei serpenti e il Mose che ja scattar l'acqua dalla
rupe, nei quali ancor oggi brillano sprazzi freschi
di bellezza tonale. (Bastò l'apparenza di corpi
volumetricamente costrutti, perchè i vecchi scrit-
tori travisassero subito in tali opere la funzione
luministica, la quale sembrò al Ridolfi « meravi-
glioso artifizio... per dividere l'ima figura dalla
altra, con ombre e lumi più o meno rilevati... » 1
mentre non si trattava di dividere, bensì d'unir e
fondere).
In tal genere di composizioni, dominate dalla
necessità, in alcun caso limitante, di conseguir
il massimo e più immediato rendimento artistico,
colla maggior rapidità di tocco possibile, il pae-
saggio pittoricamente accidentato non avrebbe
potuto non prevalere: per esso il problema lumi-
nistico (che, quando manchino nubi, montagne,
alberi è semplice, di carattere universale, simile a
quello che si ha in un ambiente chiuso, normal-
mente illuminato), per esso il problema luministico
si complica e i raggi si confondono, s'intersecano,
si modificano, distruggendo il colore, distruggendo
la solidità corporea, producendo riflessioni e ri-
frazioni. Dei quadri della Scuola ben pochi sono
quelli in cui, con superba incuranza dell'iconografia
tradizionale, non vi abbia vita fantasiosa, che vuol
per sè l'attenzione di chi guarda, la curva fanta-
stica d'un monte, un lembo di cielo irrealmente
tumultuoso o sbiancato, un ciuffo di foglie, spesse
per sostanza cromatica, che la luce sgrana, alleg-
gerendo.
Si guardi il Battesimo (tìg. 4).
Dai due pesanti ammassi di nuvole grigie, chia-
rorlate, aperte a cortina, piove la luce zenithale,
disegnando senza morbidezza il dorso del Cristo
genuflesso, e diffondendo sulle acque chiarori lu-
nari. Tal relazione luministica fra l'alto del quadro
e un de' piani anteriori non basta a far del gruppo
del Battezzando e del Battista il centro figurativo
nè sentimentale dell'opera: chè, l'attenzione di chi
osserva è attratta piuttosto dal fondo, strano e
arruffato, e sente subito che specialmente per esso
è in funzione la luce. La quale, scartando lo sprone
di monte oscuro, che precipita netto sul fiume,
concentra la sua forza sulla lontana riva, estrema-
mente chiara, con oblio delle figure di primo piano,
appena sbozzate e prive d'effettivo compito pit-
torico.
La riva è pur popolata di figure, così leggermente
1 Le meraviglie lìelVtirte;'Venezia, 1648, t. IT, p. 22.
dipinte, che mancano d'ogni solidità e sembrano,
nel giuoco della luce altopiovente, crisalidi informi
avvolte nei fili d'una bava argentea. Effetto fan-
tastico, altre volte ricercato dal Tintoretto nella
Scuola stessa di S. Rocco e altrove, e tentato pur
da Domenico, il quale, nel S. Domenico e il ponte-
fice di Rimini, volle interporre una teoria luminosa
di macchiette incorporee, biancheggianti sul fondo,
senza peraltro aver coscienza del significato lumi-
nistico, che ad esse Iacopo aveva assegnato. Infatti
la zona variamente luminosa, che nel Battesimo esse
costituiscono, separa le ombre del primo da quelle
dell'ultimo piano, quasi tagliando in due parti la
composizione: trova quindi il suo accordo nel cielo,
chiaro nonostante la massa oscura delle nubi so-
vrapposte a strati fioccosi, e fa risaltare pittoresca-
mente gli alberi, i quali s'incuneano non senza
artifizio nel vuoto aperto fra le cortine nuvolose.
Nel singolare effetto di questo striscio di luce, re-
golante l'insieme, nell'alternarsi armonico di zone
chiare e di zone oscure, e, sopratutto, in quell'agi-
tazione riflessata e commossa dell'atmosfera, che
ha la sua eco ovunque, sta lo spirito dell'opera.
La quale, però, è cosa fredda. La funzione della
luce, che pur bastevolmente lega ciò che sarebbe
disgiunto, non è ancor sufficente al finale effetto
d'insieme: ' qualchecosa manca e qualche cosa è
in più, che impedisce il conseguimento di sintesi in
questo dipinto, il quale, nonostante la varietà degli
effetti, par torpido, fatto nel sonno o almeno mentre
il genio dell'artista non vegliava. Poiché il pae-
saggio stesso non s'accorda pienamente col resto,
come potè esso sembrar al Ruskin tipico esempio
d'audacia trasformativa, specie nell'acqua e nelle
roccie? 1 Come il Soulier potè definirlo « pathé-
tique »?2
« Pathétique », per traslazione di valori senti-
mentali in valori visivi, mi par piuttosto termine
atto ad esprimere lo speciale pittoricismo del lembo
di paese, che s'apre nella Resurrezione. Chiuso fra
l'invadente rupe oscura e la cornice, con una
ragion compositiva che ricorda quella degli
squarci di paesaggio, che s'aprirono fin dal Quat-
trocento nei ritratti dei Veneti, il cielo sbiancato
e vibrante, d'estrema sensibilità luministica, s'ab-
bassa sulla curva d'un monte, segnato con tocco
impressionisticamente sommario: dall'indetermina-
tezza del particolare nasce il senso della distanza
e del fantastico, che s'accorda col moto istan-
taneo delle Marie, venienti verso il primo piano, e
collo stilizzato rigoglio della pianta altoposta. In
questo lembo di paese aurorale, effetto delizioso
di « veduta lontana », conseguito con semplicità
1 Modem painters. London, 1843-1860, voi. Ili, p. 188.
2 Le Tintoret, p. 62.