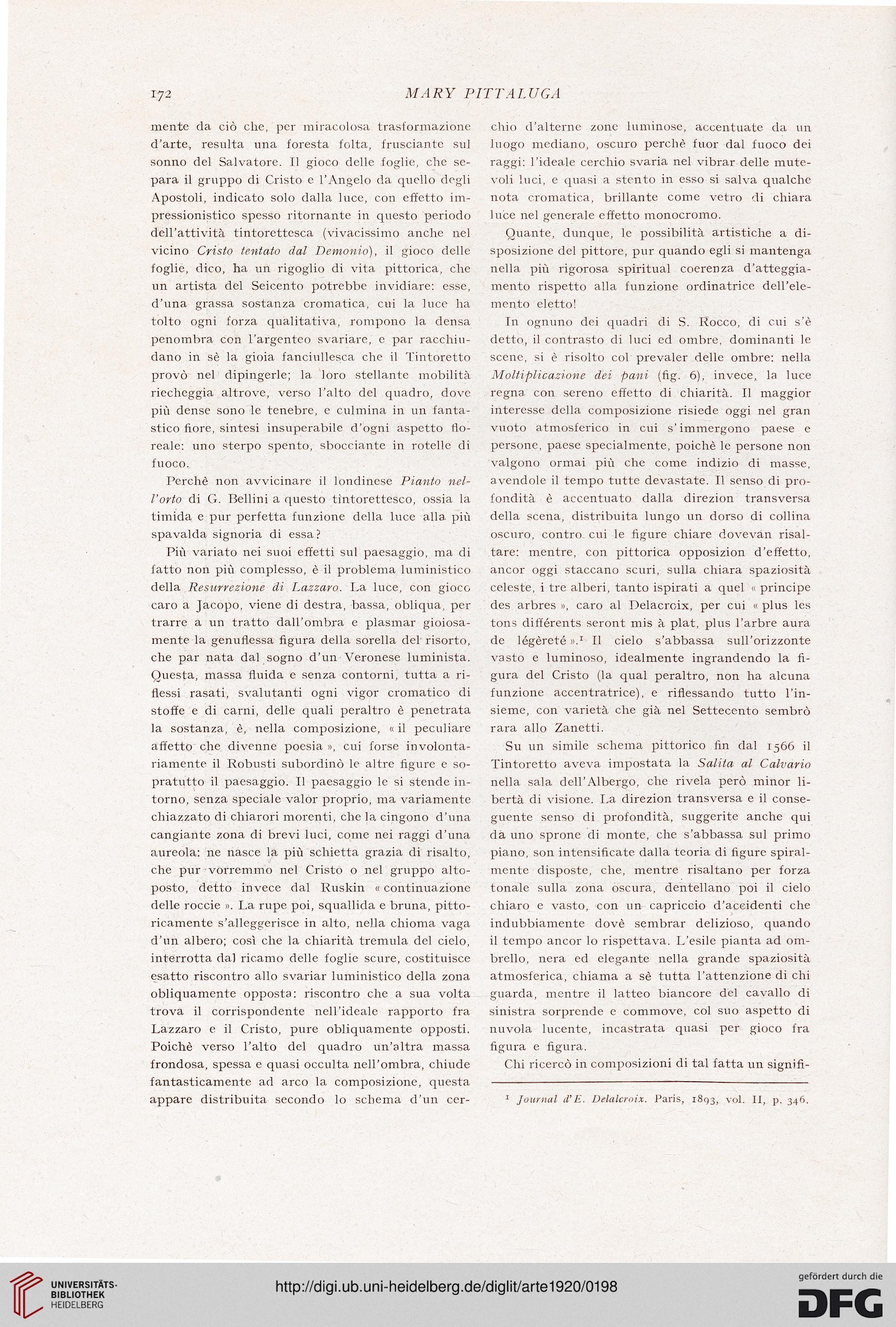172
MARY PITTA LUCA
mente da ciò che, per miracolosa trasformazione
d'arte, resulta una foresta folta, frusciaste sul
sonno del Salvatore. Il gioco delle foglie, che se-
para il gruppo di Cristo e l'Angelo da quello degli
Apostoli, indicato solo dalla luce, con effetto im-
pressionistico spesso ritornante in questo periodo
dell'attività tintorcttesca (vivacissimo anche nel
vicino Cristo tentato dal Demonio), il gioco delle
foglie, dico, ha un rigoglio di vita pittorica, che
un artista del Seicento potrebbe invidiare: esse,
d'una grassa sostanza cromatica, cui la luce ha
tolto ogni forza qualitativa, rompono la densa
penombra con l'argenteo svariare, e par racchiu-
dano in sè la gioia fanciullesca che il ì'intoretto
provò nel dipingerle; la loro stellante mobilità
riecheggia altrove, verso l'alto del quadro, dove
più dense sono le tenebre, e culmina in un fanta-
stico fiore, sintesi insuperabile d'ogni aspetto flo-
reale: uno sterpo spento, sbocciante in rotelle di
fuoco.
Perchè non avvicinare il londinese Pianto nel-
l'orto di G. Bellini a questo tintorettesco, ossia la
timida e pur perfetta funzione della luce alla più
spavalda signoria di essa?
Più variato nei suoi effetti sul paesaggio, ma di
fatto non più complesso, è il problema luministico
della Resurrezione dì Lazzaro. La luce, con gioco
caro a Jacopo, viene di destra, bassa, obliqua, per
trarre a un tratto dall'ombra e plasmar gioiosa-
mente la genuflessa figura della sorella del risorto,
che par nata dal sogno d'un Veronese luminista.
Questa, massa fluida e senza contorni, tutta a ri-
flessi rasati, svalutanti ogni vigor cromatico di
stoffe e di carni, delle quali peraltro è penetrata
la sostanza, è, nella composizione, « il peculiare
affetto che divenne poesia », cui forse involonta-
riamente il Robusti subordinò le altre figure e so-
pratutto il paesaggio. Il paesaggio le si stende in-
torno, senza speciale valor proprio, ma variamente
chiazzato di chiarori morenti, che la cingono d'una
cangiante zona di brevi luci, come nei raggi d'una
aureola: ne nasce la più schietta grazia di risalto,
che pur vorremmo nel Cristo o nel gruppo alto-
posto, detto invece dal Rùskin « continuazione
delle roccie ». La rupe poi, squallida e bruna, pitto-
ricamente s'alleggerisce in alto, nella chioma vaga
d'un albero; così che la chiarità tremula del ciclo,
interrotta dal ricamo delle foglie scure, costituisce
esatto riscontro allo svariar luministico della zona
obliquamente opposta: riscontro che a sua volta
trova il corrispondente nell'ideale rapporto fra
Lazzaro e il Cristo, pure obliquamente opposti.
Poiché verso l'alto del quadro un'altra massa
frondosa, spessa e quasi occulta nell'ombra, chiude
fantasticamente ad arco la composizione, questa
appare distribuita secondo lo schema d'un cer-
chio d'alterne zone luminose, accentuate da un
luogo mediano, oscuro perchè fuor dal fuoco dei
raggi: l'ideale cerchio svaria nel vibrar delle mute-
voli luci, e quasi a stento in esso si salva qualche
nota cromatica, brillante come vetro di chiara
luce nel generale effetto monocromo.
Quante, dunque, le possibilità artistiche a di-
sposizione del pittore, pur quando egli si mantenga
nella più rigorosa spiritual coerenza d'atteggia-
mento rispetto alla funzione ordinatrice dell'ele-
mento eletto!
[d ognuno dei quadri di S. Rocco, di cui s'è
detto, il contrasto di luci ed ombre, dominanti le
scene, si è risolto col prevaler delle ombre: nella
Moltiplicazione dei pani (fig. 6), invece, la luce
regna con sereno effetto di chiarità. Il maggior
interesse della composizione risiede oggi nel gran
vuoto atmosferico in cui s'immergono paese e
persone, paese specialmente, poiché le persone non
valgono ormai più che come indizio di masse,
avendole il tempo tutte devastate. TI senso di pro-
fondità è accentuato dalla direzion transversa
della scena, distribuita lungo un dorso di collina
oscuro, contro cui le figure chiare dovevan risal-
tare: mentre, con pittorica opposizion d'effetto,
ancor oggi staccano scuri, sulla chiara spaziosità
celeste, i tre alberi, tanto ispirati a quel « principe
des arbres », caro al Delacroix, per cui « plus les
tons différents seront mis à plat, plus l'arbre aura
de légèreté ».: Il cielo s'abbassa sull'orizzonte
vasto e luminoso, idealmente ingrandendo la fi-
gura del Cristo (la qual peraltro, non ha alcuna
funzione accentratrice), e riflessando tutto l'in-
sieme, con varietà che già nel Settecento sembrò
rara allo Zanetti.
Su un simile schema pittorico fin dal r566 il
Tintoretto aveva impostata la Salita al Calvario
nella sala dell'Albergo, che rivela però minor li-
bertà di visione. La direzion transversa e il conse-
guente senso di profondità, suggerite anche qui
da uno sprone di monte, che s'abbassa sul primo
piano, son intensificate dalla teoria di figure spiral-
mente disposte, che, mentre risaltano per forza
tonale sulla zona oscura, dentellano poi il cielo
chiaro e vasto, con un capriccio d'accidenti che
indubbiamente dovè sembrar delizioso, qua.ndo
il tempo ancor lo rispettava. L'esile pianta ad om-
brello, nera ed elega.nte nella grande spaziosità
atmosferica, chiama a sè tutta l'attenzione di chi
guarda, mentre il latteo biancore del cavallo di
sinistra sorprende e commove, col suo aspetto di
nuvola lucente, incastrata quasi per gioco fra
figura e figura.
Chi ricercò in composizioni di tal fatta un signifì-
1 Journal d'E. Delalcroix. Paris, 1893, voi. ii, p. 346.
MARY PITTA LUCA
mente da ciò che, per miracolosa trasformazione
d'arte, resulta una foresta folta, frusciaste sul
sonno del Salvatore. Il gioco delle foglie, che se-
para il gruppo di Cristo e l'Angelo da quello degli
Apostoli, indicato solo dalla luce, con effetto im-
pressionistico spesso ritornante in questo periodo
dell'attività tintorcttesca (vivacissimo anche nel
vicino Cristo tentato dal Demonio), il gioco delle
foglie, dico, ha un rigoglio di vita pittorica, che
un artista del Seicento potrebbe invidiare: esse,
d'una grassa sostanza cromatica, cui la luce ha
tolto ogni forza qualitativa, rompono la densa
penombra con l'argenteo svariare, e par racchiu-
dano in sè la gioia fanciullesca che il ì'intoretto
provò nel dipingerle; la loro stellante mobilità
riecheggia altrove, verso l'alto del quadro, dove
più dense sono le tenebre, e culmina in un fanta-
stico fiore, sintesi insuperabile d'ogni aspetto flo-
reale: uno sterpo spento, sbocciante in rotelle di
fuoco.
Perchè non avvicinare il londinese Pianto nel-
l'orto di G. Bellini a questo tintorettesco, ossia la
timida e pur perfetta funzione della luce alla più
spavalda signoria di essa?
Più variato nei suoi effetti sul paesaggio, ma di
fatto non più complesso, è il problema luministico
della Resurrezione dì Lazzaro. La luce, con gioco
caro a Jacopo, viene di destra, bassa, obliqua, per
trarre a un tratto dall'ombra e plasmar gioiosa-
mente la genuflessa figura della sorella del risorto,
che par nata dal sogno d'un Veronese luminista.
Questa, massa fluida e senza contorni, tutta a ri-
flessi rasati, svalutanti ogni vigor cromatico di
stoffe e di carni, delle quali peraltro è penetrata
la sostanza, è, nella composizione, « il peculiare
affetto che divenne poesia », cui forse involonta-
riamente il Robusti subordinò le altre figure e so-
pratutto il paesaggio. Il paesaggio le si stende in-
torno, senza speciale valor proprio, ma variamente
chiazzato di chiarori morenti, che la cingono d'una
cangiante zona di brevi luci, come nei raggi d'una
aureola: ne nasce la più schietta grazia di risalto,
che pur vorremmo nel Cristo o nel gruppo alto-
posto, detto invece dal Rùskin « continuazione
delle roccie ». La rupe poi, squallida e bruna, pitto-
ricamente s'alleggerisce in alto, nella chioma vaga
d'un albero; così che la chiarità tremula del ciclo,
interrotta dal ricamo delle foglie scure, costituisce
esatto riscontro allo svariar luministico della zona
obliquamente opposta: riscontro che a sua volta
trova il corrispondente nell'ideale rapporto fra
Lazzaro e il Cristo, pure obliquamente opposti.
Poiché verso l'alto del quadro un'altra massa
frondosa, spessa e quasi occulta nell'ombra, chiude
fantasticamente ad arco la composizione, questa
appare distribuita secondo lo schema d'un cer-
chio d'alterne zone luminose, accentuate da un
luogo mediano, oscuro perchè fuor dal fuoco dei
raggi: l'ideale cerchio svaria nel vibrar delle mute-
voli luci, e quasi a stento in esso si salva qualche
nota cromatica, brillante come vetro di chiara
luce nel generale effetto monocromo.
Quante, dunque, le possibilità artistiche a di-
sposizione del pittore, pur quando egli si mantenga
nella più rigorosa spiritual coerenza d'atteggia-
mento rispetto alla funzione ordinatrice dell'ele-
mento eletto!
[d ognuno dei quadri di S. Rocco, di cui s'è
detto, il contrasto di luci ed ombre, dominanti le
scene, si è risolto col prevaler delle ombre: nella
Moltiplicazione dei pani (fig. 6), invece, la luce
regna con sereno effetto di chiarità. Il maggior
interesse della composizione risiede oggi nel gran
vuoto atmosferico in cui s'immergono paese e
persone, paese specialmente, poiché le persone non
valgono ormai più che come indizio di masse,
avendole il tempo tutte devastate. TI senso di pro-
fondità è accentuato dalla direzion transversa
della scena, distribuita lungo un dorso di collina
oscuro, contro cui le figure chiare dovevan risal-
tare: mentre, con pittorica opposizion d'effetto,
ancor oggi staccano scuri, sulla chiara spaziosità
celeste, i tre alberi, tanto ispirati a quel « principe
des arbres », caro al Delacroix, per cui « plus les
tons différents seront mis à plat, plus l'arbre aura
de légèreté ».: Il cielo s'abbassa sull'orizzonte
vasto e luminoso, idealmente ingrandendo la fi-
gura del Cristo (la qual peraltro, non ha alcuna
funzione accentratrice), e riflessando tutto l'in-
sieme, con varietà che già nel Settecento sembrò
rara allo Zanetti.
Su un simile schema pittorico fin dal r566 il
Tintoretto aveva impostata la Salita al Calvario
nella sala dell'Albergo, che rivela però minor li-
bertà di visione. La direzion transversa e il conse-
guente senso di profondità, suggerite anche qui
da uno sprone di monte, che s'abbassa sul primo
piano, son intensificate dalla teoria di figure spiral-
mente disposte, che, mentre risaltano per forza
tonale sulla zona oscura, dentellano poi il cielo
chiaro e vasto, con un capriccio d'accidenti che
indubbiamente dovè sembrar delizioso, qua.ndo
il tempo ancor lo rispettava. L'esile pianta ad om-
brello, nera ed elega.nte nella grande spaziosità
atmosferica, chiama a sè tutta l'attenzione di chi
guarda, mentre il latteo biancore del cavallo di
sinistra sorprende e commove, col suo aspetto di
nuvola lucente, incastrata quasi per gioco fra
figura e figura.
Chi ricercò in composizioni di tal fatta un signifì-
1 Journal d'E. Delalcroix. Paris, 1893, voi. ii, p. 346.