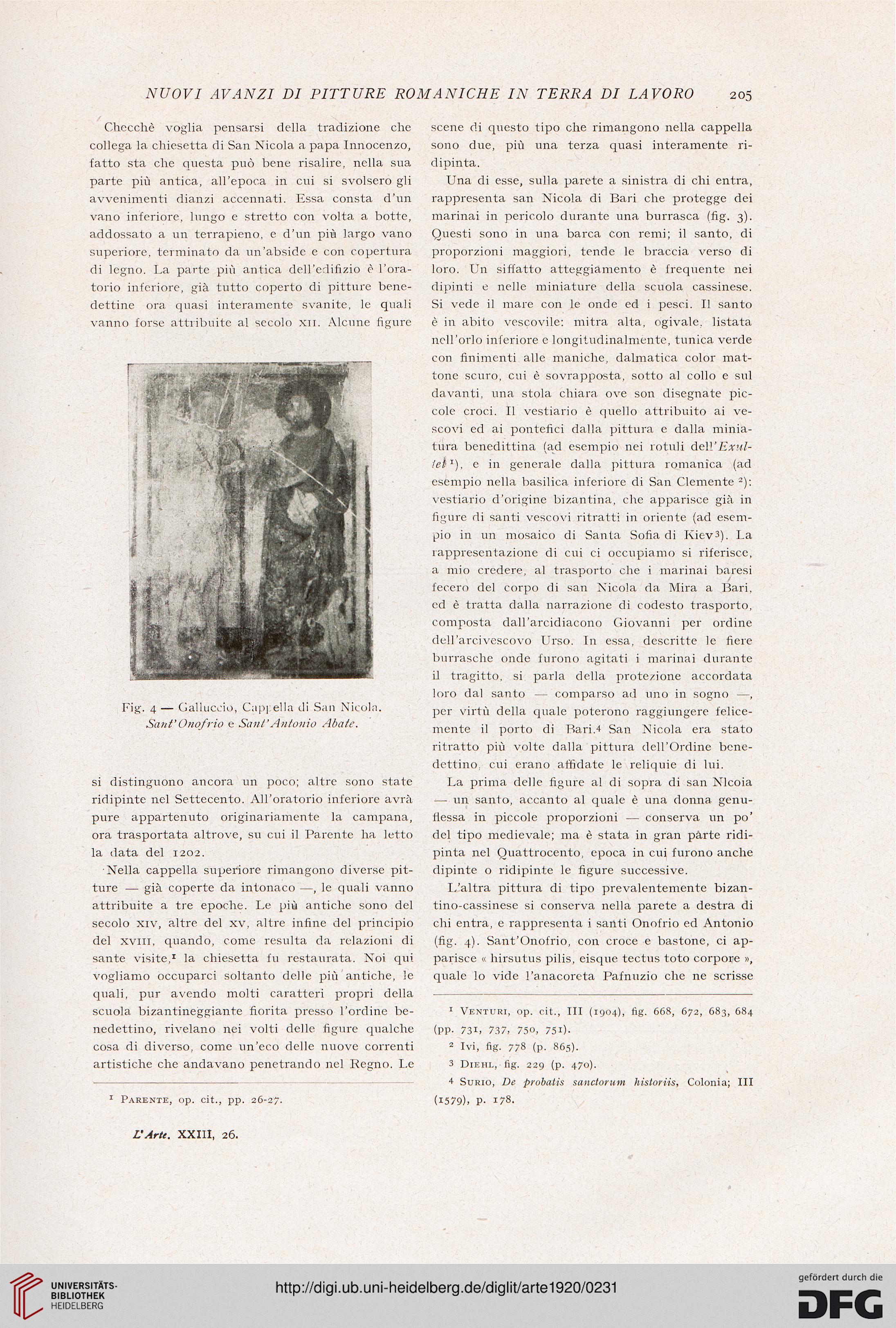NUOVI AVANZI DI PITTURE ROMANICHE IN TERRA DI LAVORO 205
Checché voglia pensarsi della tradizione che
collega la chiesetta di San Nicola a papa Innocenzo,
fatto sta che questa può bene risalire, nella sua
parte più antica, all'epoca in cui si svolsero gli
avvenimenti dianzi accennati. Essa consta d'un
vano inferiore, lungo e stretto con volta a botte,
addossato a un terrapieno, e d'un più largo vano
superiore, terminato da un'abside e con copertura
di legno. La parte più antica dell'edilizio è l'ora-
torio inferiore, già tutto coperto di pitture bene-
dettine ora quasi interamente svanite, le quali
vanno forse attribuite al secolo xn. Alcune figure
Fig. 4 — Galluccio, Capi ella San Nicola.
Sant'Onofrio e Sant'Antonio Abate.
si distinguono ancora un poco; altre sono state
ridipinte nel Settecento. All'oratorio inferiore avrà
pure appartenuto originariamente la campana,
ora trasportata altrove, su cui il Parente ha letto
la data del 1202.
Nella cappella superiore rimangono diverse pit-
ture — già coperte da intonaco —, le quali vanno
attribuite a tre epoche. Le più antiche sono del
secolo xiv, altre del xv, altre infine del principio
del xviii, quando, come resulta da relazioni di
sante visite,1 la chiesetta fu restaurata. Noi qui
vogliamo occuparci soltanto delle più antiche, le
quali, pur avendo molti caratteri propri della
scuola bizantineggiante fiorita presso l'ordine be-
nedettino, rivelano nei volti delle figure qualche
cosa di diverso, come un'eco delle nuove correnti
artistiche che andavano penetrando nel Regno. Le
1 Parente, op. cit., pp. 26-27.
scene di questo tipo che rimangono nella cappella
sono due, più una terza quasi interamente ri-
dipinta.
Una di esse, sulla parete a sinistra di chi entra,
rappresenta san Nicola di Bari che protegge dei
marinai in pericolo durante una burrasca (fig. 3).
Questi sono in una barca con remi; il santo, di
proporzioni maggiori, tende le braccia verso di
loro. Un siffatto atteggiamento è frequente nei
dipinti e nelle miniature della scuola cassinese.
Si vede il mare con le onde ed i pesci. Il santo
è in abito vescovile: mitra alta, ogivale, listata
nell'orlo inferiore e longitudinalmente, tunica verde
con finimenti alle maniche, dalmatica color mat-
tone scuro, cui è sovrapposta, sotto al collo e sul
davanti, una stola chiara ove son disegnate pic-
cole croci. Il vestiario è quello attribuito ai ve-
scovi ed ai pontefici dalla pittura e dalla minia-
tura benedittina (ad esempio nei rotuli AeWExul-
fel1). e in generale dalla pittura romanica (ad
esempio nella basilica inferiore di San Clemente 2):
vestiario d'origine bizantina, che apparisce già in
figure di santi vescovi ritratti in oriente (ad esem-
pio in un mosaico di Santa Sofia di Kiev3). La
rappresentazione di cui ci occupiamo si riferisce,
a mio credere, al trasporto che i marinai baresi
fecero del corpo di san Nicola da Mira a Bari,
ed è tratta dalla narrazione di codesto trasporto,
composta dall'arcidiacono Giovanni per ordine
dell'arcivescovo Urso. In essa, descritte le fiere
burrasche onde furono agitati i marinai durante
U tragitto, si parla della protezione accordata
loro dal santo — comparso ad uno in sogno —,
per virtù della quale poterono raggiungere felice-
mente il porto di Bari.4 San Nicola era stato
ritratto più volte dalla pittura dell'Ordine bene-
dettino, cui erano affidate le reliquie di lui.
La prima delle figure al di sopra di san Nlcoia
— un santo, accanto al quale è una donna genu-
flessa in piccole proporzioni — conserva un po'
del tipo medievale; ma è stata in gran pàrte ridi-
pinta nel Quattrocento, epoca in cui furono anche
dipinte o ridipinte le figure successive.
L'altra pittura di tipo prevalentemente bizan-
tino-cassinese si conserva nella parete a destra di
chi entra, e rappresenta i santi Onofrio ed Antonio
(fig. 4). Sant'Onofrio, con croce e bastone, ci ap-
parisce « hirsutus pilis, eisque tectus toto corpore »,
quale lo vide l'anacoreta Pafnuzio che ne scrisse
1 Venturi, op. cit., Ili (1904), fig. 668, 672, 683, 684
(PP- 73i, 737, 750, 751).
* Ivi, fig. 778 (p. 865).
3 DlEHL, fig. 229 (p. 47o).
4 Surio, De probalis sanctorum historiis, Colonia; III
(1579), P- 178.
L'Arte. XXIII, 26.
Checché voglia pensarsi della tradizione che
collega la chiesetta di San Nicola a papa Innocenzo,
fatto sta che questa può bene risalire, nella sua
parte più antica, all'epoca in cui si svolsero gli
avvenimenti dianzi accennati. Essa consta d'un
vano inferiore, lungo e stretto con volta a botte,
addossato a un terrapieno, e d'un più largo vano
superiore, terminato da un'abside e con copertura
di legno. La parte più antica dell'edilizio è l'ora-
torio inferiore, già tutto coperto di pitture bene-
dettine ora quasi interamente svanite, le quali
vanno forse attribuite al secolo xn. Alcune figure
Fig. 4 — Galluccio, Capi ella San Nicola.
Sant'Onofrio e Sant'Antonio Abate.
si distinguono ancora un poco; altre sono state
ridipinte nel Settecento. All'oratorio inferiore avrà
pure appartenuto originariamente la campana,
ora trasportata altrove, su cui il Parente ha letto
la data del 1202.
Nella cappella superiore rimangono diverse pit-
ture — già coperte da intonaco —, le quali vanno
attribuite a tre epoche. Le più antiche sono del
secolo xiv, altre del xv, altre infine del principio
del xviii, quando, come resulta da relazioni di
sante visite,1 la chiesetta fu restaurata. Noi qui
vogliamo occuparci soltanto delle più antiche, le
quali, pur avendo molti caratteri propri della
scuola bizantineggiante fiorita presso l'ordine be-
nedettino, rivelano nei volti delle figure qualche
cosa di diverso, come un'eco delle nuove correnti
artistiche che andavano penetrando nel Regno. Le
1 Parente, op. cit., pp. 26-27.
scene di questo tipo che rimangono nella cappella
sono due, più una terza quasi interamente ri-
dipinta.
Una di esse, sulla parete a sinistra di chi entra,
rappresenta san Nicola di Bari che protegge dei
marinai in pericolo durante una burrasca (fig. 3).
Questi sono in una barca con remi; il santo, di
proporzioni maggiori, tende le braccia verso di
loro. Un siffatto atteggiamento è frequente nei
dipinti e nelle miniature della scuola cassinese.
Si vede il mare con le onde ed i pesci. Il santo
è in abito vescovile: mitra alta, ogivale, listata
nell'orlo inferiore e longitudinalmente, tunica verde
con finimenti alle maniche, dalmatica color mat-
tone scuro, cui è sovrapposta, sotto al collo e sul
davanti, una stola chiara ove son disegnate pic-
cole croci. Il vestiario è quello attribuito ai ve-
scovi ed ai pontefici dalla pittura e dalla minia-
tura benedittina (ad esempio nei rotuli AeWExul-
fel1). e in generale dalla pittura romanica (ad
esempio nella basilica inferiore di San Clemente 2):
vestiario d'origine bizantina, che apparisce già in
figure di santi vescovi ritratti in oriente (ad esem-
pio in un mosaico di Santa Sofia di Kiev3). La
rappresentazione di cui ci occupiamo si riferisce,
a mio credere, al trasporto che i marinai baresi
fecero del corpo di san Nicola da Mira a Bari,
ed è tratta dalla narrazione di codesto trasporto,
composta dall'arcidiacono Giovanni per ordine
dell'arcivescovo Urso. In essa, descritte le fiere
burrasche onde furono agitati i marinai durante
U tragitto, si parla della protezione accordata
loro dal santo — comparso ad uno in sogno —,
per virtù della quale poterono raggiungere felice-
mente il porto di Bari.4 San Nicola era stato
ritratto più volte dalla pittura dell'Ordine bene-
dettino, cui erano affidate le reliquie di lui.
La prima delle figure al di sopra di san Nlcoia
— un santo, accanto al quale è una donna genu-
flessa in piccole proporzioni — conserva un po'
del tipo medievale; ma è stata in gran pàrte ridi-
pinta nel Quattrocento, epoca in cui furono anche
dipinte o ridipinte le figure successive.
L'altra pittura di tipo prevalentemente bizan-
tino-cassinese si conserva nella parete a destra di
chi entra, e rappresenta i santi Onofrio ed Antonio
(fig. 4). Sant'Onofrio, con croce e bastone, ci ap-
parisce « hirsutus pilis, eisque tectus toto corpore »,
quale lo vide l'anacoreta Pafnuzio che ne scrisse
1 Venturi, op. cit., Ili (1904), fig. 668, 672, 683, 684
(PP- 73i, 737, 750, 751).
* Ivi, fig. 778 (p. 865).
3 DlEHL, fig. 229 (p. 47o).
4 Surio, De probalis sanctorum historiis, Colonia; III
(1579), P- 178.
L'Arte. XXIII, 26.