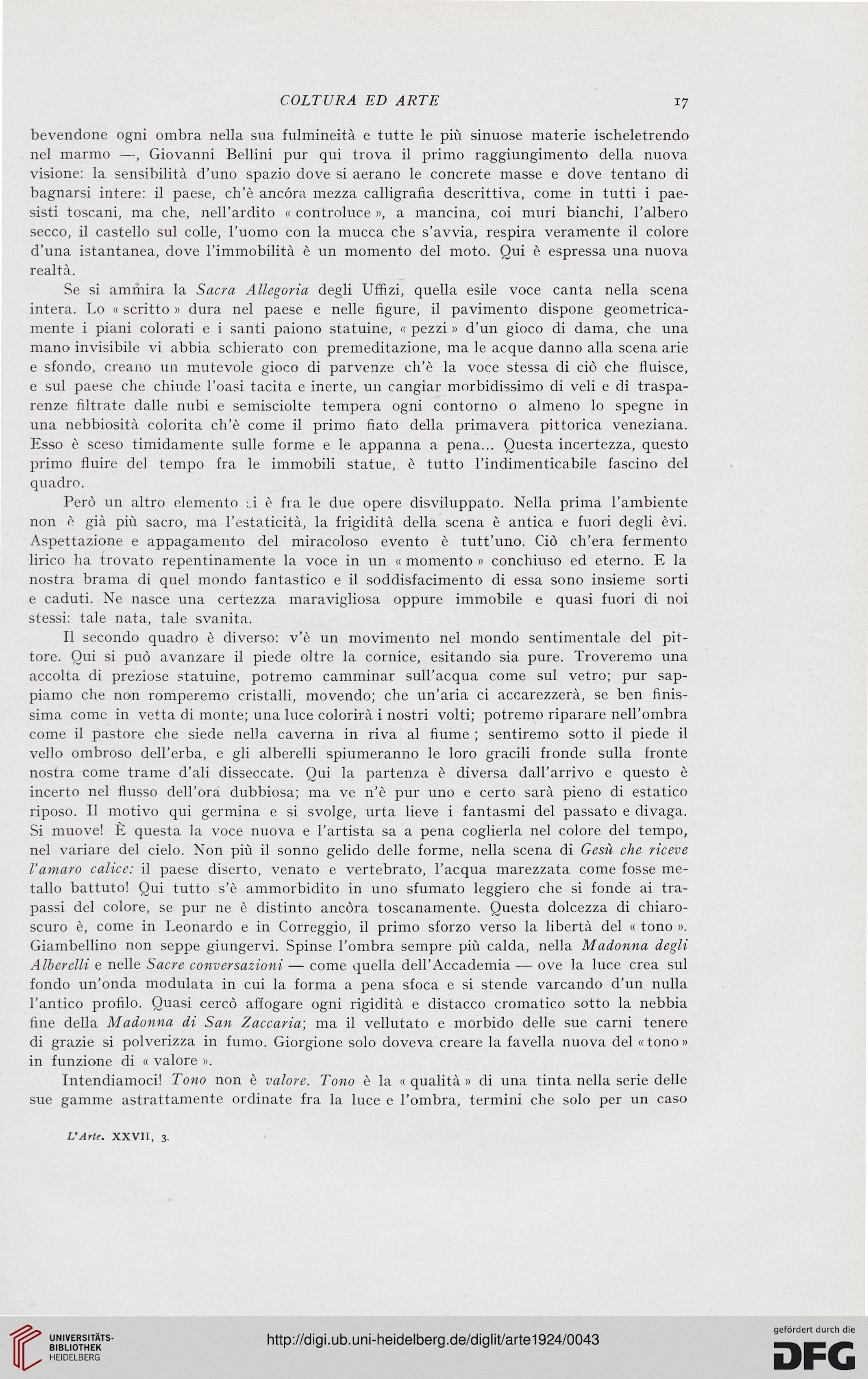COLTURA ED ARTE
17
bevendone ogni ombra nella sua fulmineità e tutte le più sinuose materie ischeletrendo
nel marmo —, Giovanni Bellini pur qui trova il primo raggiungimento della nuova
visione: la sensibilità d'uno spazio dove si aerano le concrete masse e dove tentano di
bagnarsi intere: il paese, eh'è ancóra mezza calligrafia descrittiva, come in tutti i pae-
sisti toscani, ma che, nell'ardito « controluce », a mancina, coi muri bianchi, l'albero
secco, il castello sul colle, l'uomo con la mucca che s'avvia, respira veramente il colore
d'una istantanea, dove l'immobilità è un momento del moto. Qui è espressa una nuova
realtà.
Se si ammira la Sacra Allegoria degli Uffìzi, quella esile voce canta nella scena
intera. Lo « scritto » dura nel paese e nelle figure, il pavimento dispone geometrica-
mente i piani colorati e i santi paiono statuine, « pezzi » d'un gioco di dama, che una
mano invisibile vi abbia schierato con premeditazione, ma le acque danno alla scena arie
e sfondo, creano un mutevole gioco di parvenze ch'è la voce stessa di ciò che fluisce,
e sul paese che chiude l'oasi tacita e inerte, un cangiar morbidissimo di veli e di traspa-
renze filtrate dalle nubi e semisciolte tempera ogni contorno o almeno lo spegne in
una nebbiosità colorita ch'è come il primo fiato della primavera pittorica veneziana.
Esso è sceso timidamente sulle forme e le appanna a pena... Questa incertezza, questo
primo fluire del tempo fra le immobili statue, è tutto l'indimenticabile fascino del
quadro.
Però un altro elemento lì è fra le due opere disviluppato. Nella prima l'ambiente
non è già più sacro, ma l'estaticità, la frigidità della scena è antica e fuori degli évi.
Aspettazione e appagamento del miracoloso evento è tutt'uno. Ciò ch'era fermento
lirico ha trovato repentinamente la voce in un « momento » conchiuso ed eterno. E la
nostra brama di quel mondo fantastico e il soddisfacimento di essa sono insieme sorti
e caduti. Ne nasce una certezza maravigliosa oppure immobile e quasi fuori di noi
stessi: tale nata, tale svanita.
Il secondo quadro è diverso: v'è un movimento nel mondo sentimentale del pit-
tore. Qui si può avanzare il piede oltre la cornice, esitando sia pure. Troveremo una
accolta di preziose statuine, potremo camminar sull'acqua come sul vetro; pur sap-
piamo che non romperemo cristalli, movendo; che un'aria ci accarezzerà, se ben finis-
sima come in vetta di monte; una luce colorirà i nostri volti; potremo riparare nell'ombra
come il pastore che siede nella caverna in riva al fiume ; sentiremo sotto il piede il
vello ombroso dell'erba, e gli alberelli spiumeranno le loro gracili fronde sulla fronte
nostra come trame d'ali disseccate. Qui la partenza è diversa dall'arrivo e questo è
incerto nel flusso dell'ora dubbiosa; ma ve n'è pur uno e certo sarà pieno di estatico
riposo. Il motivo qui germina e si svolge, urta lieve i fantasmi del passato e divaga.
Si muove! È questa la voce nuova e l'artista sa a pena coglierla nel colore del tempo,
nel variare del cielo. Non più il sonno gelido delle forme, nella scena di Gesù che riceve
l'amaro calice: il paese diserto, venato e vertebrato, l'acqua marezzata come fosse me-
tallo battuto! Qui tutto s'è ammorbidito in uno sfumato leggiero che si fonde ai tra-
passi del colore, se pur ne è distinto ancóra toscanamente. Questa dolcezza di chiaro-
scuro è, come in Leonardo e in Correggio, il primo sforzo verso la libertà del « tono ».
Giambellino non seppe giungervi. Spinse l'ombra sempre più calda, nella Madonna degli
Alberelli e nelle Sacre conversazioni — come quella dell'Accademia — ove la luce crea sul
fondo un'onda modulata in cui la forma a pena sfoca e si stende varcando d'un nulla
l'antico profilo. Quasi cercò affogare ogni rigidità e distacco cromatico sotto la nebbia
fine della Madonna di San Zaccaria; ma il vellutato e morbido delle sue carni tenere
di grazie si polverizza in fumo. Giorgione solo doveva creare la favella nuova del « tono »
in funzione di « valore ».
Intendiamoci! Tono non è valore. Tono è la « qualità » di una tinta nella serie delle
sue gamme astrattamente ordinate fra la luce e l'ombra, termini che solo per un caso
L'Arte. XXVII, 3.
17
bevendone ogni ombra nella sua fulmineità e tutte le più sinuose materie ischeletrendo
nel marmo —, Giovanni Bellini pur qui trova il primo raggiungimento della nuova
visione: la sensibilità d'uno spazio dove si aerano le concrete masse e dove tentano di
bagnarsi intere: il paese, eh'è ancóra mezza calligrafia descrittiva, come in tutti i pae-
sisti toscani, ma che, nell'ardito « controluce », a mancina, coi muri bianchi, l'albero
secco, il castello sul colle, l'uomo con la mucca che s'avvia, respira veramente il colore
d'una istantanea, dove l'immobilità è un momento del moto. Qui è espressa una nuova
realtà.
Se si ammira la Sacra Allegoria degli Uffìzi, quella esile voce canta nella scena
intera. Lo « scritto » dura nel paese e nelle figure, il pavimento dispone geometrica-
mente i piani colorati e i santi paiono statuine, « pezzi » d'un gioco di dama, che una
mano invisibile vi abbia schierato con premeditazione, ma le acque danno alla scena arie
e sfondo, creano un mutevole gioco di parvenze ch'è la voce stessa di ciò che fluisce,
e sul paese che chiude l'oasi tacita e inerte, un cangiar morbidissimo di veli e di traspa-
renze filtrate dalle nubi e semisciolte tempera ogni contorno o almeno lo spegne in
una nebbiosità colorita ch'è come il primo fiato della primavera pittorica veneziana.
Esso è sceso timidamente sulle forme e le appanna a pena... Questa incertezza, questo
primo fluire del tempo fra le immobili statue, è tutto l'indimenticabile fascino del
quadro.
Però un altro elemento lì è fra le due opere disviluppato. Nella prima l'ambiente
non è già più sacro, ma l'estaticità, la frigidità della scena è antica e fuori degli évi.
Aspettazione e appagamento del miracoloso evento è tutt'uno. Ciò ch'era fermento
lirico ha trovato repentinamente la voce in un « momento » conchiuso ed eterno. E la
nostra brama di quel mondo fantastico e il soddisfacimento di essa sono insieme sorti
e caduti. Ne nasce una certezza maravigliosa oppure immobile e quasi fuori di noi
stessi: tale nata, tale svanita.
Il secondo quadro è diverso: v'è un movimento nel mondo sentimentale del pit-
tore. Qui si può avanzare il piede oltre la cornice, esitando sia pure. Troveremo una
accolta di preziose statuine, potremo camminar sull'acqua come sul vetro; pur sap-
piamo che non romperemo cristalli, movendo; che un'aria ci accarezzerà, se ben finis-
sima come in vetta di monte; una luce colorirà i nostri volti; potremo riparare nell'ombra
come il pastore che siede nella caverna in riva al fiume ; sentiremo sotto il piede il
vello ombroso dell'erba, e gli alberelli spiumeranno le loro gracili fronde sulla fronte
nostra come trame d'ali disseccate. Qui la partenza è diversa dall'arrivo e questo è
incerto nel flusso dell'ora dubbiosa; ma ve n'è pur uno e certo sarà pieno di estatico
riposo. Il motivo qui germina e si svolge, urta lieve i fantasmi del passato e divaga.
Si muove! È questa la voce nuova e l'artista sa a pena coglierla nel colore del tempo,
nel variare del cielo. Non più il sonno gelido delle forme, nella scena di Gesù che riceve
l'amaro calice: il paese diserto, venato e vertebrato, l'acqua marezzata come fosse me-
tallo battuto! Qui tutto s'è ammorbidito in uno sfumato leggiero che si fonde ai tra-
passi del colore, se pur ne è distinto ancóra toscanamente. Questa dolcezza di chiaro-
scuro è, come in Leonardo e in Correggio, il primo sforzo verso la libertà del « tono ».
Giambellino non seppe giungervi. Spinse l'ombra sempre più calda, nella Madonna degli
Alberelli e nelle Sacre conversazioni — come quella dell'Accademia — ove la luce crea sul
fondo un'onda modulata in cui la forma a pena sfoca e si stende varcando d'un nulla
l'antico profilo. Quasi cercò affogare ogni rigidità e distacco cromatico sotto la nebbia
fine della Madonna di San Zaccaria; ma il vellutato e morbido delle sue carni tenere
di grazie si polverizza in fumo. Giorgione solo doveva creare la favella nuova del « tono »
in funzione di « valore ».
Intendiamoci! Tono non è valore. Tono è la « qualità » di una tinta nella serie delle
sue gamme astrattamente ordinate fra la luce e l'ombra, termini che solo per un caso
L'Arte. XXVII, 3.