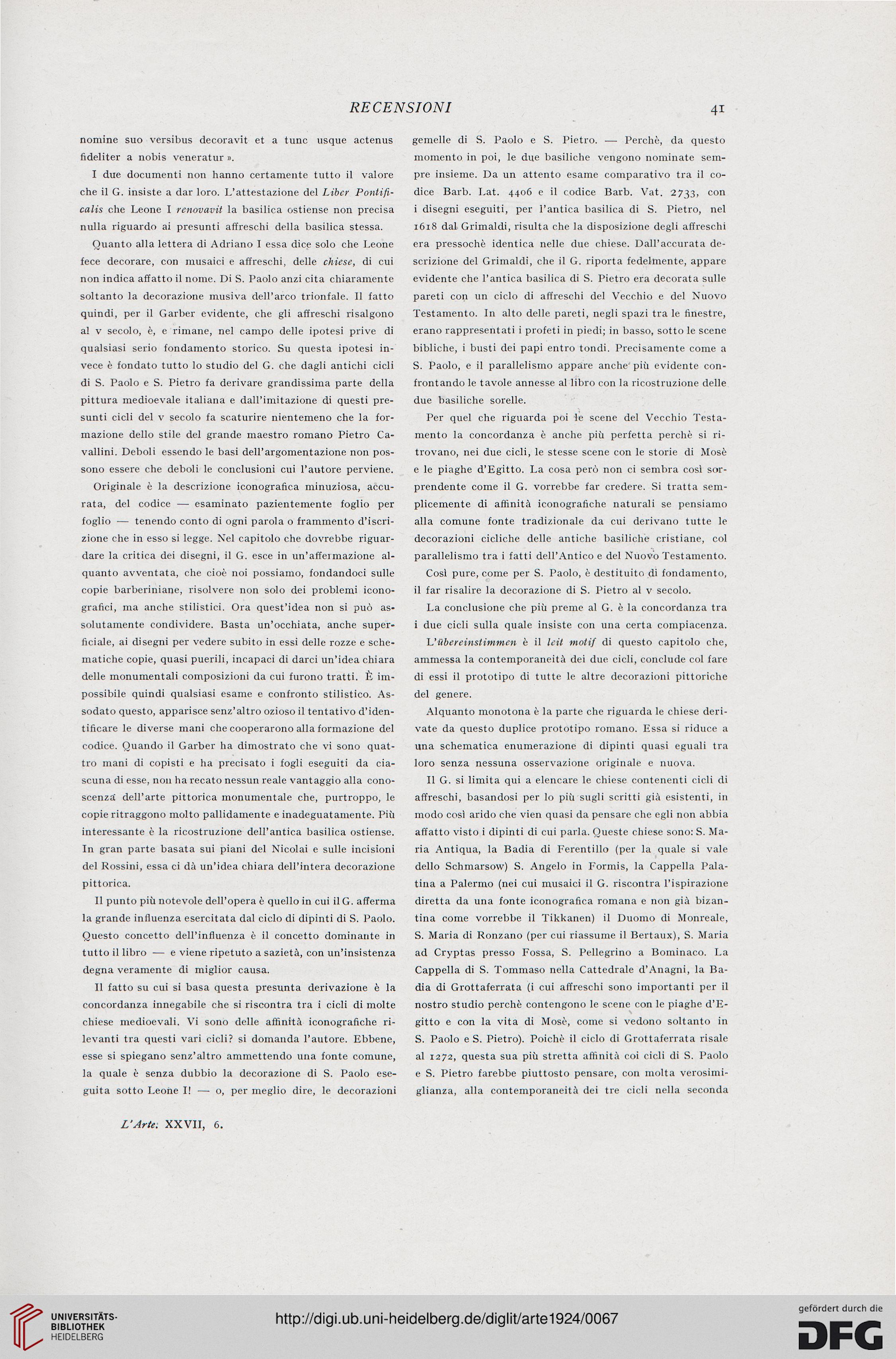RECENSIONI
4i
nomine suo versibus decoravit et a tunc usque actenus
fideliter a nobis veneratur ».
I due documenti non hanno certamente tutto il valore
che il G. insiste a dar loro. L'attestazione del Libcr Pontìfi-
calìs che Leone I rcnovavit la basilica ostiense non precisa
nulla riguardo ai presunti affreschi della basilica stessa.
Quanto alla lettera di Adriano I essa dice solo che Leone
fece decorare, con musaici e affreschi, delle chiese, di cui
non indica affatto il nome. Di S. Paolo anzi cita chiaramente
soltanto la decorazione musiva dell'arco trionfale. Il fatto
quindi, per il Garber evidente, che gli affreschi risalgono
al v secolo, è, e rimane, nel campo delle ipotesi prive di
qualsiasi serio fondamento storico. Su questa ipotesi in-
vece è fondato tutto lo studio del G. che dagli antichi cicli
di S. Paolo e S. Pietro fa derivare grandissima parte della
pittura medioevale italiana e dall'imitazione di questi pre-
sunti cicli del v secolo fa scaturire nientemeno che la for-
mazione dello stile del grande maestro romano Pietro Ca-
vallini. Deboli essendo le basi dell'argomentazione non pos-
sono essere che deboli le conclusioni cui l'autore perviene.
Originale è la descrizione iconografica minuziosa, accu-
rata, del codice — esaminato pazientemente foglio per
foglio — tenendo conto di ogni parola o frammento d'iscri-
zione che in esso si legge. Nel capitolo che dovrebbe riguar-
dare la critica dei disegni, il G. esce in un'affermazione al-
quanto avventata, che cioè noi possiamo, fondandoci sulle
copie barberiniane, risolvere non solo dei problemi icono-
grafici, ma anche stilistici. Ora quest'idea non si può as-
solutamente condividere. Basta un'occhiata, anche super-
ficiale, ai disegni per vedere subito in essi delle rozze e sche-
matiche copie, quasi puerili, incapaci di darci un'idea chiara
delle monumentali composizioni da cui furono tratti. È im-
possibile quindi qualsiasi esame e confronto stilistico. As-
sodato questo, apparisce senz'altro ozioso il tentativo d'iden-
tificare le diverse mani che cooperarono alla formazione del
codice. Quando il Garber ha dimostrato che vi sono quat-
tro mani di copisti e ha precisato i fogli eseguiti da cia-
scuna di esse, non ha recato nessun reale vantaggio alla cono-
scenza' dell'arte pittorica monumentale che, purtroppo, le
copie ritraggono molto pallidamente e inadeguatamente. Più
interessante è la ricostruzione dell'antica basilica ostiense.
In gran parte basata sui piani del Nicolai e sulle incisioni
del Rossini, essa ci dà un'idea chiara dell'intera decorazione
pittorica.
II punto più notevole dell'opera è quello in cui il G. afferma
la grande influenza esercitata dal ciclo di dipinti di S. Paolo.
Questo concetto dell'influenza è il concetto dominante in
tutto il libro — e viene ripetuto a sazietà, con un'insistenza
degna veramente di miglior causa.
Il fatto su cui si basa questa presunta derivazione è la
concordanza innegabile che si riscontra tra i cicli di molte
chiese medioevali. Vi sono delle affinità iconografiche ri-
levanti tra questi vari cicli? si domanda l'autore. Ebbene,
esse si spiegano senz'altro ammettendo una fonte comune,
la quale è senza dubbio la decorazione di S. Paolo ese-
guita sotto Leone I! — o, per meglio dire, le decorazioni
gemelle di S. Paolo e S. Pietro. — Perchè, da questo
momento in poi, le due basiliche vengono nominate sem-
pre insieme. Da un attento esame comparativo tra il co-
dice Barb. Lat. 4406 e il codice Barb. Vat. 2733, con
i disegni eseguiti, per l'antica basilica di S. Pietro, nel
1618 dal Grimaldi, risulta che la disposizione degli affreschi
era pressoché identica nelle due chiese. Dall'accurata de-
scrizione del Grimaldi, che il G. riporta fedelmente, appare
evidente che l'antica basilica di S. Pietro era decorata sulle
pareti con un ciclo di affreschi del Vecchio e del Nuovo
Testamento. In alto delle pareti, negli spazi tra le finestre,
erano rappresentati i profeti in piedi; in basso, sotto le scene
bibliche, i busti dei papi entro tondi. Precisamente come a
S. Paolo, e il parallelismo appare anche' più evidente con-
frontando le tavole annesse al libro con la ricostruzione delle
due basiliche sorelle.
Per quel che riguarda poi le scene del Vecchio Testa-
mento la concordanza è anche più perfetta perchè si ri-
trovano, nei due cicli, le stesse scene con le storie di Mosè
e le piaghe d'Egitto. La cosa però non ci sembra così sor-
prendente come il G. vorrebbe far credere. Si tratta sem-
plicemente di affinità iconografiche naturali se pensiamo
alla comune fonte tradizionale da cui derivano tutte le
decorazioni cicliche delle antiche basiliche cristiane, col
parallelismo tra i fatti dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Cosi pure, come per S. Paolo, è destituito di fondamento,
il far risalire la decorazione di S. Pietro al v secolo.
La conclusione che più preme al G. è la concordanza tra
i due cicli sulla quale insiste con una certa compiacenza.
~L'iibereìnstìmmen è il leti moti/ di questo capitolo che,
ammessa la contemporaneità dei due cicli, conclude col fare
di essi il prototipo di tutte le altre decorazioni pittoriche
del genere.
Alquanto monotona è la parte che riguarda le chiese deri-
vate da questo duplice prototipo romano. Essa si riduce a
una schematica enumerazione di dipinti quasi eguali tra
loro senza nessuna osservazione originale e nuova.
Il G. si limita qui a elencare le chiese contenenti cicli di
affreschi, basandosi per lo più sugli scritti già esistenti, in
modo così arido che vien quasi da pensare che egli non abbia
affatto visto i dipinti di cui parla. Queste chiese sono: S. Ma-
ria Antiqua, la Badia di Ferentino (per la quale si vale
dello Schmarsow) S. Angelo in Formis, la Cappella Pala-
tina a Palermo (nei cui musaici il G. riscontra l'ispirazione
diretta da una fonte iconografica romana e non già bizan-
tina come vorrebbe il Tikkanen) il Duomo di Monreale,
S. Maria di Ronzano (per cui riassume il Bertaux), S. Maria
ad Cryptas presso Fossa, S. Pellegrino a Bominaco. La
Cappella di S. Tommaso nella Cattedrale d'Anagni, la Ba-
dia di Grottaferrata (i cui affreschi sono importanti per il
nostro studio perchè contengono le scene con le piaghe d'E-
gitto e con la vita di Mosè, come si vedono soltanto in
S. Paolo e S. Pietro). Poiché il ciclo di Grottaferrata risale
al 1272, questa sua più stretta affinità coi cicli di S. Paolo
e S. Pietro farebbe piuttosto pensare, con molta verosimi-
glianza, alla contemporaneità dei tre cicli nella seconda
L'Arte. XXVII, 6.
4i
nomine suo versibus decoravit et a tunc usque actenus
fideliter a nobis veneratur ».
I due documenti non hanno certamente tutto il valore
che il G. insiste a dar loro. L'attestazione del Libcr Pontìfi-
calìs che Leone I rcnovavit la basilica ostiense non precisa
nulla riguardo ai presunti affreschi della basilica stessa.
Quanto alla lettera di Adriano I essa dice solo che Leone
fece decorare, con musaici e affreschi, delle chiese, di cui
non indica affatto il nome. Di S. Paolo anzi cita chiaramente
soltanto la decorazione musiva dell'arco trionfale. Il fatto
quindi, per il Garber evidente, che gli affreschi risalgono
al v secolo, è, e rimane, nel campo delle ipotesi prive di
qualsiasi serio fondamento storico. Su questa ipotesi in-
vece è fondato tutto lo studio del G. che dagli antichi cicli
di S. Paolo e S. Pietro fa derivare grandissima parte della
pittura medioevale italiana e dall'imitazione di questi pre-
sunti cicli del v secolo fa scaturire nientemeno che la for-
mazione dello stile del grande maestro romano Pietro Ca-
vallini. Deboli essendo le basi dell'argomentazione non pos-
sono essere che deboli le conclusioni cui l'autore perviene.
Originale è la descrizione iconografica minuziosa, accu-
rata, del codice — esaminato pazientemente foglio per
foglio — tenendo conto di ogni parola o frammento d'iscri-
zione che in esso si legge. Nel capitolo che dovrebbe riguar-
dare la critica dei disegni, il G. esce in un'affermazione al-
quanto avventata, che cioè noi possiamo, fondandoci sulle
copie barberiniane, risolvere non solo dei problemi icono-
grafici, ma anche stilistici. Ora quest'idea non si può as-
solutamente condividere. Basta un'occhiata, anche super-
ficiale, ai disegni per vedere subito in essi delle rozze e sche-
matiche copie, quasi puerili, incapaci di darci un'idea chiara
delle monumentali composizioni da cui furono tratti. È im-
possibile quindi qualsiasi esame e confronto stilistico. As-
sodato questo, apparisce senz'altro ozioso il tentativo d'iden-
tificare le diverse mani che cooperarono alla formazione del
codice. Quando il Garber ha dimostrato che vi sono quat-
tro mani di copisti e ha precisato i fogli eseguiti da cia-
scuna di esse, non ha recato nessun reale vantaggio alla cono-
scenza' dell'arte pittorica monumentale che, purtroppo, le
copie ritraggono molto pallidamente e inadeguatamente. Più
interessante è la ricostruzione dell'antica basilica ostiense.
In gran parte basata sui piani del Nicolai e sulle incisioni
del Rossini, essa ci dà un'idea chiara dell'intera decorazione
pittorica.
II punto più notevole dell'opera è quello in cui il G. afferma
la grande influenza esercitata dal ciclo di dipinti di S. Paolo.
Questo concetto dell'influenza è il concetto dominante in
tutto il libro — e viene ripetuto a sazietà, con un'insistenza
degna veramente di miglior causa.
Il fatto su cui si basa questa presunta derivazione è la
concordanza innegabile che si riscontra tra i cicli di molte
chiese medioevali. Vi sono delle affinità iconografiche ri-
levanti tra questi vari cicli? si domanda l'autore. Ebbene,
esse si spiegano senz'altro ammettendo una fonte comune,
la quale è senza dubbio la decorazione di S. Paolo ese-
guita sotto Leone I! — o, per meglio dire, le decorazioni
gemelle di S. Paolo e S. Pietro. — Perchè, da questo
momento in poi, le due basiliche vengono nominate sem-
pre insieme. Da un attento esame comparativo tra il co-
dice Barb. Lat. 4406 e il codice Barb. Vat. 2733, con
i disegni eseguiti, per l'antica basilica di S. Pietro, nel
1618 dal Grimaldi, risulta che la disposizione degli affreschi
era pressoché identica nelle due chiese. Dall'accurata de-
scrizione del Grimaldi, che il G. riporta fedelmente, appare
evidente che l'antica basilica di S. Pietro era decorata sulle
pareti con un ciclo di affreschi del Vecchio e del Nuovo
Testamento. In alto delle pareti, negli spazi tra le finestre,
erano rappresentati i profeti in piedi; in basso, sotto le scene
bibliche, i busti dei papi entro tondi. Precisamente come a
S. Paolo, e il parallelismo appare anche' più evidente con-
frontando le tavole annesse al libro con la ricostruzione delle
due basiliche sorelle.
Per quel che riguarda poi le scene del Vecchio Testa-
mento la concordanza è anche più perfetta perchè si ri-
trovano, nei due cicli, le stesse scene con le storie di Mosè
e le piaghe d'Egitto. La cosa però non ci sembra così sor-
prendente come il G. vorrebbe far credere. Si tratta sem-
plicemente di affinità iconografiche naturali se pensiamo
alla comune fonte tradizionale da cui derivano tutte le
decorazioni cicliche delle antiche basiliche cristiane, col
parallelismo tra i fatti dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Cosi pure, come per S. Paolo, è destituito di fondamento,
il far risalire la decorazione di S. Pietro al v secolo.
La conclusione che più preme al G. è la concordanza tra
i due cicli sulla quale insiste con una certa compiacenza.
~L'iibereìnstìmmen è il leti moti/ di questo capitolo che,
ammessa la contemporaneità dei due cicli, conclude col fare
di essi il prototipo di tutte le altre decorazioni pittoriche
del genere.
Alquanto monotona è la parte che riguarda le chiese deri-
vate da questo duplice prototipo romano. Essa si riduce a
una schematica enumerazione di dipinti quasi eguali tra
loro senza nessuna osservazione originale e nuova.
Il G. si limita qui a elencare le chiese contenenti cicli di
affreschi, basandosi per lo più sugli scritti già esistenti, in
modo così arido che vien quasi da pensare che egli non abbia
affatto visto i dipinti di cui parla. Queste chiese sono: S. Ma-
ria Antiqua, la Badia di Ferentino (per la quale si vale
dello Schmarsow) S. Angelo in Formis, la Cappella Pala-
tina a Palermo (nei cui musaici il G. riscontra l'ispirazione
diretta da una fonte iconografica romana e non già bizan-
tina come vorrebbe il Tikkanen) il Duomo di Monreale,
S. Maria di Ronzano (per cui riassume il Bertaux), S. Maria
ad Cryptas presso Fossa, S. Pellegrino a Bominaco. La
Cappella di S. Tommaso nella Cattedrale d'Anagni, la Ba-
dia di Grottaferrata (i cui affreschi sono importanti per il
nostro studio perchè contengono le scene con le piaghe d'E-
gitto e con la vita di Mosè, come si vedono soltanto in
S. Paolo e S. Pietro). Poiché il ciclo di Grottaferrata risale
al 1272, questa sua più stretta affinità coi cicli di S. Paolo
e S. Pietro farebbe piuttosto pensare, con molta verosimi-
glianza, alla contemporaneità dei tre cicli nella seconda
L'Arte. XXVII, 6.