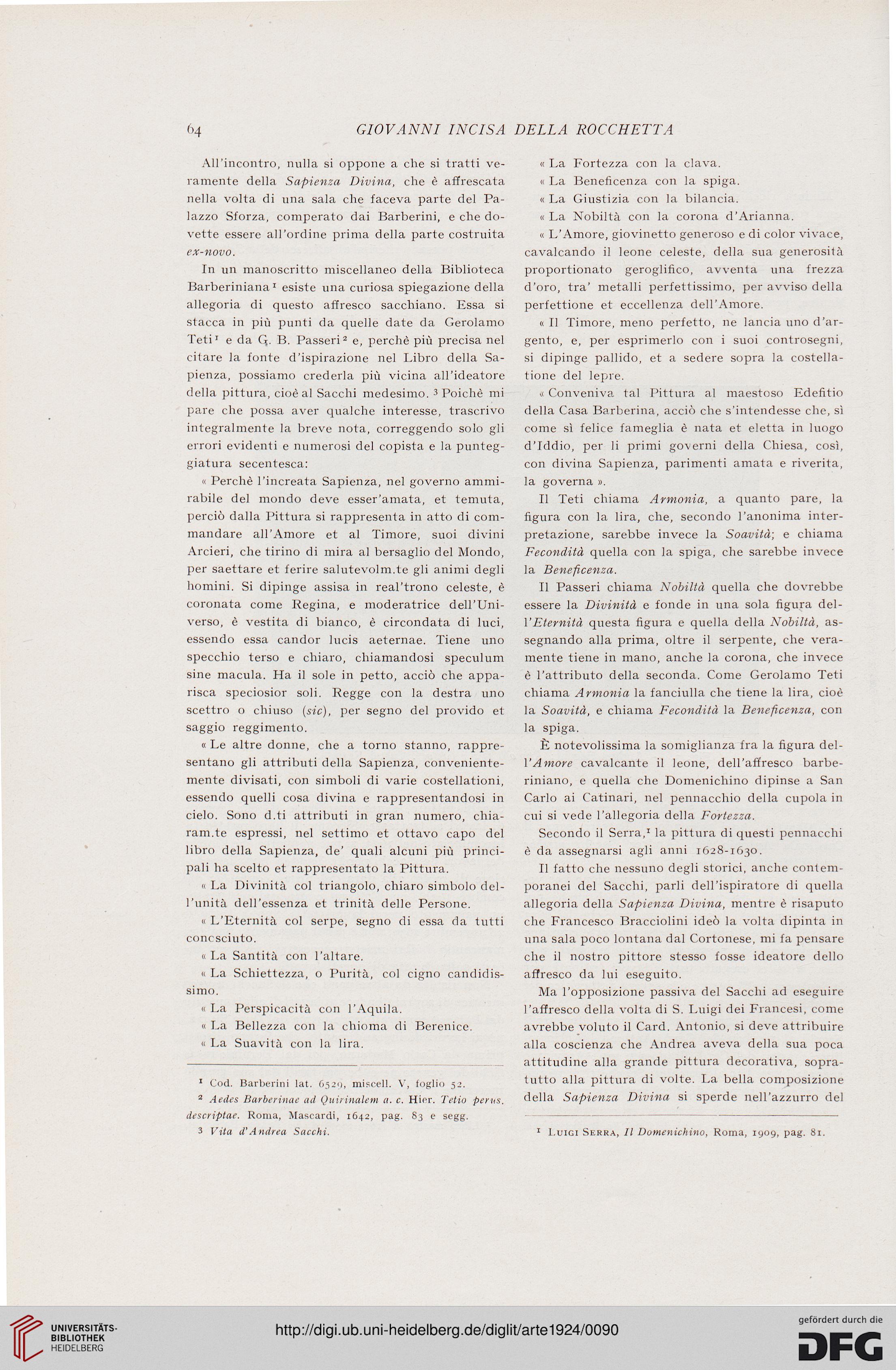64
GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA
All'incontro, nulla si oppone a che si tratti ve-
ramente della Sapienza Divina, che è affrescata
nella volta di una sala che faceva parte del Pa-
lazzo Sforza, comperato dai Barberini, e che do-
vette essere all'ordine prima della parte costruita
ex-novo.
In un manoscritto miscellaneo della Biblioteca
Barberiniana 1 esiste una curiosa spiegazione della
allegoria di questo affresco sacchiano. Essa si
stacca in più punti da quelle date da Gerolamo
Teti1 e da Q. B. Passeri2 e, perchè più precisa nel
citare la fonte d'ispirazione nel Libro della Sa-
pienza, possiamo crederla più vicina all'ideatore
della pittura, cioè al Sacchi medesimo. 3 Poiché mi
pare che possa aver qualche interesse, trascrivo
integralmente la breve nota, correggendo solo gli
errori evidenti e numerosi del copista e la punteg-
giatura secentesca:
« Perchè l'increata Sapienza, nel governo ammi-
rabile del mondo deve esser'amata, et temuta,
perciò dalla Pittura si rappresenta in atto di com-
mandare all'Amore et al Timore, suoi divini
Arcieri, che tirino di mira al bersaglio del Mondo,
per saettare et ferire salutevolm.te gli animi degli
homini. Si dipinge assisa in real'trono celeste, è
coronata come Regina, e moderatrice dell'Uni-
verso, è vestita di bianco, è circondata di luci,
essendo essa candor lucis aeternae. Tiene uno
specchio terso e chiaro, chiamandosi speculum
sine macula. Ha il sole in petto, acciò che appa-
risca speciosior soli. Regge con la destra uno
scettro o chiuso (sic), per segno del provido et
saggio reggimento.
« Le altre donne, che a torno stanno, rappre-
sentano gli attributi della Sapienza, conveniente-
mente divisati, con simboli di varie costellationi,
essendo quelli cosa divina e rappresentandosi in
cielo. Sono d.ti attributi in gran numero, chia-
ram.te espressi, nel settimo et ottavo capo del
libro della Sapienza, de' quali alcuni più princi-
pali ha scelto et rappresentato la Pittura.
« La Divinità col triangolo, chiaro simbolo del-
l'unità dell'essenza et trinità delle Persone.
« L'Eternità col serpe, segno di essa da tutti
conosciuto.
■ La Santità con l'altare.
« La Schiettezza, o Purità, col cigno candidis-
simo.
« La Perspicacità con l'Aquila.
« La Bellezza con la chioma di Berenice.
« La Soavità con la lira.
1 Cod. Barberini lat. 6529, misceli. V, foglio 5.!.
2 Aedes Barberinae ad Quiiinalem a. c. Hier. Tetio perus.
descriptae. Roma, Mascardi, 1642, pag. 83 e segg.
3 Vita d'Andrea Sacchi.
« La Fortezza con la clava.
« La Beneficenza con la spiga.
« La Giustizia con la bilancia.
« La Nobiltà con la corona d'Arianna.
« L'Amore, giovinetto generoso e di color vivace,
cavalcando il leone celeste, della sua generosità
proportionato geroglifico, avventa una frezza
d'oro, tra' metalli perfettissimo, per avviso della
perfettione et eccellenza dell'Amore.
i II Timore, meno perfetto, ne lancia uno d'ar-
gento, e, per esprimerlo con i suoi controsegni,
si dipinge pallido, et a sedere sopra la costella-
tione del lepre.
« Conveniva tal Pittura al maestoso Edefitio
della Casa Barberina, acciò che s'intendesse che, sì
come sì felice fameglia è nata et eletta in luogo
d'Iddio, per li primi governi della Chiesa, così,
con divina Sapienza, parimenti amata e riverita,
la governa ».
Il Teti chiama Armonia, a quanto pare, la
figura con la lira, che, secondo l'anonima inter-
pretazione, sarebbe invece la Soavità; e chiama
Fecondità quella con la spiga, che sarebbe invece
la Beneficenza.
Il Passeri chiama Nobiltà quella che dovrebbe
essere la Divinità e fonde in una sola figura del-
ì'Eternità questa figura e quella della Nobiltà, as-
segnando alla prima, oltre il serpente, che vera-
mente tiene in mano, anche la corona, che invece
è l'attributo della seconda. Come Gerolamo Teti
chiama Armonia la fanciulla che tiene la lira, cioè
la Soavità, e chiama Fecondità la Beneficenza, con
la spiga.
È notevolissima la somiglianza fra la figura del-
l'Amore cavalcante il leone, dell'affresco barbe-
riniano, e quella che Domenichino dipinse a San
Carlo ai Catinari, nel pennacchio della cupola in
cui si vede l'allegoria della Fortezza.
Secondo il Serra,1 la pittura di questi pennacchi
è da assegnarsi agli anni 1628-1630.
Il fatto che nessuno degli storici, anche contem-
poranei del Sacchi, parli dell'ispiratore di quella
allegoria della Sapienza Divina, mentre è risaputo
che Francesco Bracciolini ideò la volta dipinta in
una sala poco lontana dal Cortonese, mi fa pensare
che il nostro pittore stesso fosse ideatore dello
affresco da lui eseguito.
Ma l'opposizione passiva del Sacchi ad eseguire
l'affresco della volta di S. Luigi dei Francesi, come
avrebbe voluto il Card. Antonio, si deve attribuire
alla coscienza che Andrea aveva della sua poca
attitudine alla grande pittura decorativa, sopra-
tutto alla pittura di volte. La bella composizione
della Sapienza Divina si sperde nell'azzurro del
1 Luigi Serra, // Domenichino, Roma, 1909, pag. 81.
GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA
All'incontro, nulla si oppone a che si tratti ve-
ramente della Sapienza Divina, che è affrescata
nella volta di una sala che faceva parte del Pa-
lazzo Sforza, comperato dai Barberini, e che do-
vette essere all'ordine prima della parte costruita
ex-novo.
In un manoscritto miscellaneo della Biblioteca
Barberiniana 1 esiste una curiosa spiegazione della
allegoria di questo affresco sacchiano. Essa si
stacca in più punti da quelle date da Gerolamo
Teti1 e da Q. B. Passeri2 e, perchè più precisa nel
citare la fonte d'ispirazione nel Libro della Sa-
pienza, possiamo crederla più vicina all'ideatore
della pittura, cioè al Sacchi medesimo. 3 Poiché mi
pare che possa aver qualche interesse, trascrivo
integralmente la breve nota, correggendo solo gli
errori evidenti e numerosi del copista e la punteg-
giatura secentesca:
« Perchè l'increata Sapienza, nel governo ammi-
rabile del mondo deve esser'amata, et temuta,
perciò dalla Pittura si rappresenta in atto di com-
mandare all'Amore et al Timore, suoi divini
Arcieri, che tirino di mira al bersaglio del Mondo,
per saettare et ferire salutevolm.te gli animi degli
homini. Si dipinge assisa in real'trono celeste, è
coronata come Regina, e moderatrice dell'Uni-
verso, è vestita di bianco, è circondata di luci,
essendo essa candor lucis aeternae. Tiene uno
specchio terso e chiaro, chiamandosi speculum
sine macula. Ha il sole in petto, acciò che appa-
risca speciosior soli. Regge con la destra uno
scettro o chiuso (sic), per segno del provido et
saggio reggimento.
« Le altre donne, che a torno stanno, rappre-
sentano gli attributi della Sapienza, conveniente-
mente divisati, con simboli di varie costellationi,
essendo quelli cosa divina e rappresentandosi in
cielo. Sono d.ti attributi in gran numero, chia-
ram.te espressi, nel settimo et ottavo capo del
libro della Sapienza, de' quali alcuni più princi-
pali ha scelto et rappresentato la Pittura.
« La Divinità col triangolo, chiaro simbolo del-
l'unità dell'essenza et trinità delle Persone.
« L'Eternità col serpe, segno di essa da tutti
conosciuto.
■ La Santità con l'altare.
« La Schiettezza, o Purità, col cigno candidis-
simo.
« La Perspicacità con l'Aquila.
« La Bellezza con la chioma di Berenice.
« La Soavità con la lira.
1 Cod. Barberini lat. 6529, misceli. V, foglio 5.!.
2 Aedes Barberinae ad Quiiinalem a. c. Hier. Tetio perus.
descriptae. Roma, Mascardi, 1642, pag. 83 e segg.
3 Vita d'Andrea Sacchi.
« La Fortezza con la clava.
« La Beneficenza con la spiga.
« La Giustizia con la bilancia.
« La Nobiltà con la corona d'Arianna.
« L'Amore, giovinetto generoso e di color vivace,
cavalcando il leone celeste, della sua generosità
proportionato geroglifico, avventa una frezza
d'oro, tra' metalli perfettissimo, per avviso della
perfettione et eccellenza dell'Amore.
i II Timore, meno perfetto, ne lancia uno d'ar-
gento, e, per esprimerlo con i suoi controsegni,
si dipinge pallido, et a sedere sopra la costella-
tione del lepre.
« Conveniva tal Pittura al maestoso Edefitio
della Casa Barberina, acciò che s'intendesse che, sì
come sì felice fameglia è nata et eletta in luogo
d'Iddio, per li primi governi della Chiesa, così,
con divina Sapienza, parimenti amata e riverita,
la governa ».
Il Teti chiama Armonia, a quanto pare, la
figura con la lira, che, secondo l'anonima inter-
pretazione, sarebbe invece la Soavità; e chiama
Fecondità quella con la spiga, che sarebbe invece
la Beneficenza.
Il Passeri chiama Nobiltà quella che dovrebbe
essere la Divinità e fonde in una sola figura del-
ì'Eternità questa figura e quella della Nobiltà, as-
segnando alla prima, oltre il serpente, che vera-
mente tiene in mano, anche la corona, che invece
è l'attributo della seconda. Come Gerolamo Teti
chiama Armonia la fanciulla che tiene la lira, cioè
la Soavità, e chiama Fecondità la Beneficenza, con
la spiga.
È notevolissima la somiglianza fra la figura del-
l'Amore cavalcante il leone, dell'affresco barbe-
riniano, e quella che Domenichino dipinse a San
Carlo ai Catinari, nel pennacchio della cupola in
cui si vede l'allegoria della Fortezza.
Secondo il Serra,1 la pittura di questi pennacchi
è da assegnarsi agli anni 1628-1630.
Il fatto che nessuno degli storici, anche contem-
poranei del Sacchi, parli dell'ispiratore di quella
allegoria della Sapienza Divina, mentre è risaputo
che Francesco Bracciolini ideò la volta dipinta in
una sala poco lontana dal Cortonese, mi fa pensare
che il nostro pittore stesso fosse ideatore dello
affresco da lui eseguito.
Ma l'opposizione passiva del Sacchi ad eseguire
l'affresco della volta di S. Luigi dei Francesi, come
avrebbe voluto il Card. Antonio, si deve attribuire
alla coscienza che Andrea aveva della sua poca
attitudine alla grande pittura decorativa, sopra-
tutto alla pittura di volte. La bella composizione
della Sapienza Divina si sperde nell'azzurro del
1 Luigi Serra, // Domenichino, Roma, 1909, pag. 81.