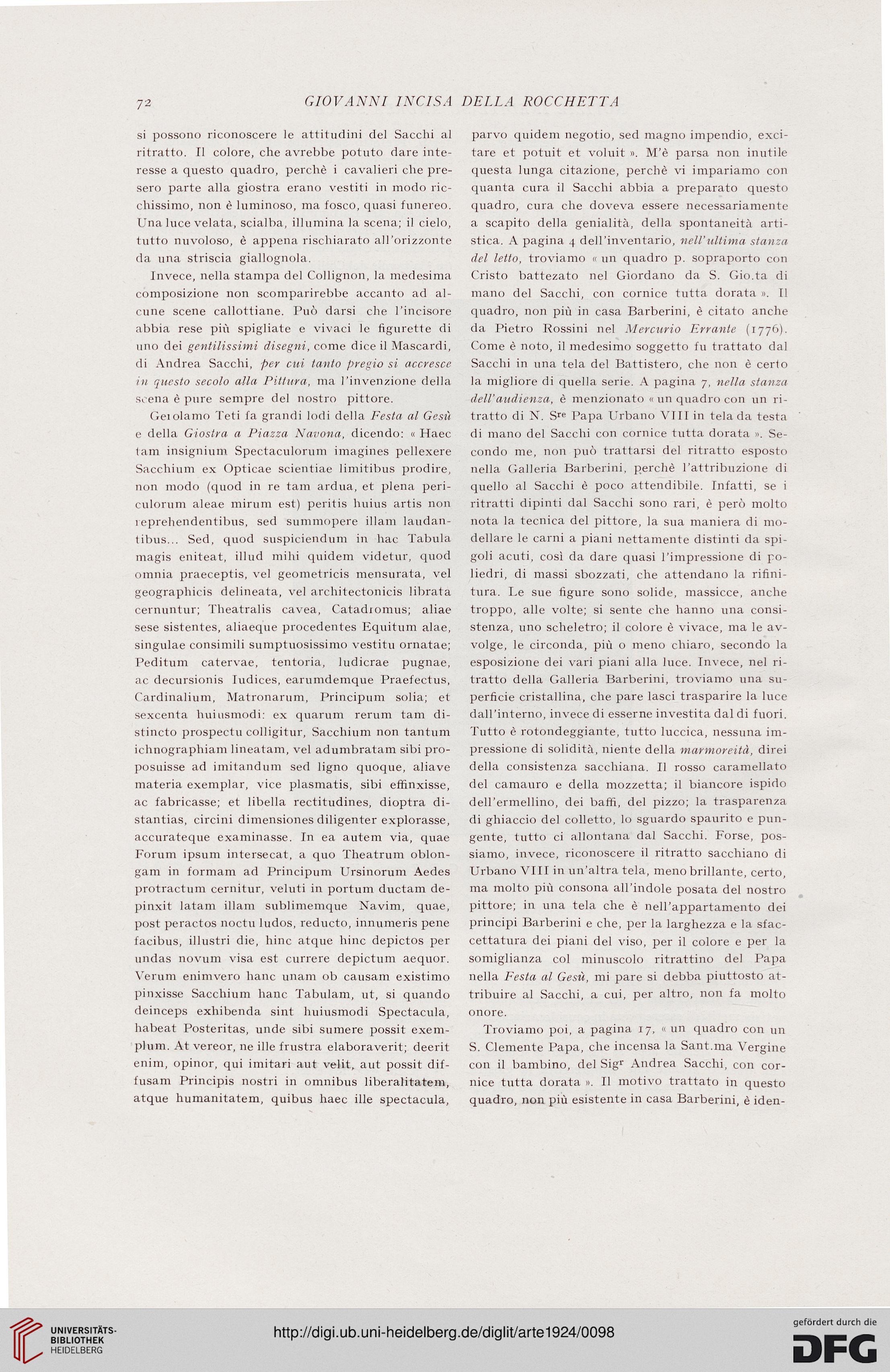72
GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA
si possono riconoscere le attitudini del Sacchi al
ritratto. [1 colore, che avrebbe potuto dare inte-
resse a questo quadro, perchè i cavalieri che pre-
sero parte alla giostra erano vestiti in modo ric-
chissimo, non è luminoso, ma fosco, quasi funereo.
Una luce velata, scialba, illumina la scena; il cielo,
tutto nuvoloso, è appena rischiarato all'orizzonte
da una striscia giallognola.
Invece, nella stampa del Collignon, la medesima
composizione non scomparirebbe accanto ad al-
cune scene callottiane. Può darsi che l'incisore
abbia rese più spigliate e vivaci le figurette di
uno dei gentilissimi disegni, come dice il Mascardi,
di Andrea Sacchi, per cui tanto pregio si accresce
in questo secolo alla Pittura, ma l'invenzione della
scena è pure sempre del nostro pittore.
Geiolamo Teti fa grandi lodi della Festa al Gesù
e della Giostra a Piazza Navona, dicendo: « Haec
(am insignium Spectaculorum imagines pellexere
Sacchium ex Opticae scientiae limitibus prodire,
non modo (quod in re tam ardua, et piena peri-
culorum aleae mirum est) peritis huius artis non
1 eprehendentibus, sed summopere illam laudan-
tibus... Sed, quod suspiciendum in hac Tabula
magis eniteat, illud mihi quidem videtur, quod
omnia praeceptis, vel geometricis mensurata, vel
geographicis delineata, vel architectonicis librata
cernuntur; Theatralis cavea, Catadiomus; aliae
sese sistentes, aliaeque procedentes Equitum alae,
singulae consimili sumptuosissimo vestitu ornatae;
Peditum catervae, tentoria, ludicrae pugnae,
ac decursionis Iudices, earumdemque Praefectus,
Cardinalium, Matronarum, Principum solia; et
sexcenta huiusmodi: ex quarum rerum tam di-
stincto prospectu colligitur, Sacchium non tantum
ichnographiam lineatam, vel adumbratam sibi pro-
posuisse ad imitandum sed ligno quoque, aliave
materia exemplar, vice plasmatis, sibi effinxisse,
ac fabricasse; et libella rectitudines, dioptra di-
stantias, circini dimensiones diligenter explorasse,
accurateque examinasse. In ea autem via, quae
Forum ipsum intersecat, a quo Theatrum oblon-
gam in formam ad Principum Ursinorum Aedes
protractum cernitur, veluti in portum ductam de-
pinxit latam illam sublimemque Navim, quae,
post peractos noctu ludos, reducto, innumeris pene
facibus, illustri die, hinc atque hinc depictos per
undas novum visa est currere depictum aequor.
Veruna enimvero hanc unam ob causam existimo
pinxisse Sacchium hanc Tabulam, ut, si quando
deinceps exhibenda sint huiusmodi Spectacula,
habeat Posteritas, unde sibi sumere possit exem-
plum. At vereor, ne ille frustra elaboraverit; deerit
enim, opinor, qui imitari aut velit, aut possit dif-
fusam Principis nostri in omnibus liberalitatem,
atque humanitatem, quibus haec ille spectacula,
parvo quidem negotio, sed magno impendio, exci-
tare et potuit et voluit ». M'è parsa non inutile
questa lunga citazione, perchè vi impariamo con
quanta cura il Sacchi abbia a preparato questo
quadro, cura che doveva essere necessariamente
a scapito della genialità, della spontaneità arti-
stica. A pagina 4 dell'inventario, nell'ultima stanza
del letto, troviamo « un quadro p. sopraporto con
Cristo battezato nel Giordano da S. Gio.ta di
mano del Sacchi, con cornice tutta dorata ». Il
quadro, non più in casa Barberini, è citato anche
da Pietro Rossini nel Mercurio Errante (1776).
Come è noto, il medesimo soggetto fu trattato dal
Sacchi in una tela del Battistero, che non è certo
la migliore di quella serie. A pagina 7, nella stanca
dell'audienza, è menzionato « un quadro con un ri-
tratto di N. Sre Papa Urbano VITI in tela da testa
di mano del Sacchi con cornice tutta dorata ». Se-
condo me, non può trattarsi del ritratto esposto
nella Galleria Barberini, perchè l'attribuzione di
quello al Sacchi è poco attendibile, rnfatti, se i
ritratti dipinti dal Sacchi sono rari, è però molto
nota la tecnica del pittore, la sua maniera di mo-
dellare le carni a piani nettamente distinti da spi-
goli acuti, così da dare quasi l'impressione di po-
liedri, di massi sbozzati, che attendano la rifini-
tura. Le sue figure sono solide, massicce, anche
troppo, alle volte; si sente che hanno una consi-
stenza, uno scheletro; il colore è vivace, ma le av-
volge, le circonda, più o meno chiaro, secondo la
esposizione dei vari piani alla luce. Invece, nel ri-
tratto della Galleria Barberini, troviamo una su-
perficie cristallina, che pare lasci trasparire la luce
dall'interno, invece di esserne investita dal di fuori.
Tutto è rotondeggiante, tutto luccica, nessuna im-
pressione di solidità, niente della marmoreità, direi
della consistenza sacchiana. Il rosso caramellato
del camauro e della mozzetta; il biancore ispido
dell'ermellino, dei baffi, del pizzo; la trasparenza
di ghiaccio del colletto, lo sguardo spaurito e pun-
gente, tutto ci allontana dal Sacchi. Forse, pos-
siamo, invece, riconoscere il ritratto sacchiano di
Urbano Vili in un'altra tela, meno brillante, certo,
ma molto più consona all'indole posata del nostro
pittore; in una tela che è nell'appartamento dei
principi Barberini e che, per la larghezza e la sfac-
cettatura dei piani del viso, per il colore e per la
somiglianza col minuscolo ritrattino del Papa
nella Festa al Gesù, mi pare si debba piuttosto at-
tribuire al Sacchi, a cui, per altro, non fa molto
onore.
Troviamo poi, a pagina 17, « un quadro con un
S. Clemente Papa, che incensa la Sant.ma Vergine
con il bambino, del Sigr Andrea Sacchi, con cor-
nice tutta dorata ». Il motivo trattato in questo
quadro, non più esistente in casa Barberini, è iden-
GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA
si possono riconoscere le attitudini del Sacchi al
ritratto. [1 colore, che avrebbe potuto dare inte-
resse a questo quadro, perchè i cavalieri che pre-
sero parte alla giostra erano vestiti in modo ric-
chissimo, non è luminoso, ma fosco, quasi funereo.
Una luce velata, scialba, illumina la scena; il cielo,
tutto nuvoloso, è appena rischiarato all'orizzonte
da una striscia giallognola.
Invece, nella stampa del Collignon, la medesima
composizione non scomparirebbe accanto ad al-
cune scene callottiane. Può darsi che l'incisore
abbia rese più spigliate e vivaci le figurette di
uno dei gentilissimi disegni, come dice il Mascardi,
di Andrea Sacchi, per cui tanto pregio si accresce
in questo secolo alla Pittura, ma l'invenzione della
scena è pure sempre del nostro pittore.
Geiolamo Teti fa grandi lodi della Festa al Gesù
e della Giostra a Piazza Navona, dicendo: « Haec
(am insignium Spectaculorum imagines pellexere
Sacchium ex Opticae scientiae limitibus prodire,
non modo (quod in re tam ardua, et piena peri-
culorum aleae mirum est) peritis huius artis non
1 eprehendentibus, sed summopere illam laudan-
tibus... Sed, quod suspiciendum in hac Tabula
magis eniteat, illud mihi quidem videtur, quod
omnia praeceptis, vel geometricis mensurata, vel
geographicis delineata, vel architectonicis librata
cernuntur; Theatralis cavea, Catadiomus; aliae
sese sistentes, aliaeque procedentes Equitum alae,
singulae consimili sumptuosissimo vestitu ornatae;
Peditum catervae, tentoria, ludicrae pugnae,
ac decursionis Iudices, earumdemque Praefectus,
Cardinalium, Matronarum, Principum solia; et
sexcenta huiusmodi: ex quarum rerum tam di-
stincto prospectu colligitur, Sacchium non tantum
ichnographiam lineatam, vel adumbratam sibi pro-
posuisse ad imitandum sed ligno quoque, aliave
materia exemplar, vice plasmatis, sibi effinxisse,
ac fabricasse; et libella rectitudines, dioptra di-
stantias, circini dimensiones diligenter explorasse,
accurateque examinasse. In ea autem via, quae
Forum ipsum intersecat, a quo Theatrum oblon-
gam in formam ad Principum Ursinorum Aedes
protractum cernitur, veluti in portum ductam de-
pinxit latam illam sublimemque Navim, quae,
post peractos noctu ludos, reducto, innumeris pene
facibus, illustri die, hinc atque hinc depictos per
undas novum visa est currere depictum aequor.
Veruna enimvero hanc unam ob causam existimo
pinxisse Sacchium hanc Tabulam, ut, si quando
deinceps exhibenda sint huiusmodi Spectacula,
habeat Posteritas, unde sibi sumere possit exem-
plum. At vereor, ne ille frustra elaboraverit; deerit
enim, opinor, qui imitari aut velit, aut possit dif-
fusam Principis nostri in omnibus liberalitatem,
atque humanitatem, quibus haec ille spectacula,
parvo quidem negotio, sed magno impendio, exci-
tare et potuit et voluit ». M'è parsa non inutile
questa lunga citazione, perchè vi impariamo con
quanta cura il Sacchi abbia a preparato questo
quadro, cura che doveva essere necessariamente
a scapito della genialità, della spontaneità arti-
stica. A pagina 4 dell'inventario, nell'ultima stanza
del letto, troviamo « un quadro p. sopraporto con
Cristo battezato nel Giordano da S. Gio.ta di
mano del Sacchi, con cornice tutta dorata ». Il
quadro, non più in casa Barberini, è citato anche
da Pietro Rossini nel Mercurio Errante (1776).
Come è noto, il medesimo soggetto fu trattato dal
Sacchi in una tela del Battistero, che non è certo
la migliore di quella serie. A pagina 7, nella stanca
dell'audienza, è menzionato « un quadro con un ri-
tratto di N. Sre Papa Urbano VITI in tela da testa
di mano del Sacchi con cornice tutta dorata ». Se-
condo me, non può trattarsi del ritratto esposto
nella Galleria Barberini, perchè l'attribuzione di
quello al Sacchi è poco attendibile, rnfatti, se i
ritratti dipinti dal Sacchi sono rari, è però molto
nota la tecnica del pittore, la sua maniera di mo-
dellare le carni a piani nettamente distinti da spi-
goli acuti, così da dare quasi l'impressione di po-
liedri, di massi sbozzati, che attendano la rifini-
tura. Le sue figure sono solide, massicce, anche
troppo, alle volte; si sente che hanno una consi-
stenza, uno scheletro; il colore è vivace, ma le av-
volge, le circonda, più o meno chiaro, secondo la
esposizione dei vari piani alla luce. Invece, nel ri-
tratto della Galleria Barberini, troviamo una su-
perficie cristallina, che pare lasci trasparire la luce
dall'interno, invece di esserne investita dal di fuori.
Tutto è rotondeggiante, tutto luccica, nessuna im-
pressione di solidità, niente della marmoreità, direi
della consistenza sacchiana. Il rosso caramellato
del camauro e della mozzetta; il biancore ispido
dell'ermellino, dei baffi, del pizzo; la trasparenza
di ghiaccio del colletto, lo sguardo spaurito e pun-
gente, tutto ci allontana dal Sacchi. Forse, pos-
siamo, invece, riconoscere il ritratto sacchiano di
Urbano Vili in un'altra tela, meno brillante, certo,
ma molto più consona all'indole posata del nostro
pittore; in una tela che è nell'appartamento dei
principi Barberini e che, per la larghezza e la sfac-
cettatura dei piani del viso, per il colore e per la
somiglianza col minuscolo ritrattino del Papa
nella Festa al Gesù, mi pare si debba piuttosto at-
tribuire al Sacchi, a cui, per altro, non fa molto
onore.
Troviamo poi, a pagina 17, « un quadro con un
S. Clemente Papa, che incensa la Sant.ma Vergine
con il bambino, del Sigr Andrea Sacchi, con cor-
nice tutta dorata ». Il motivo trattato in questo
quadro, non più esistente in casa Barberini, è iden-