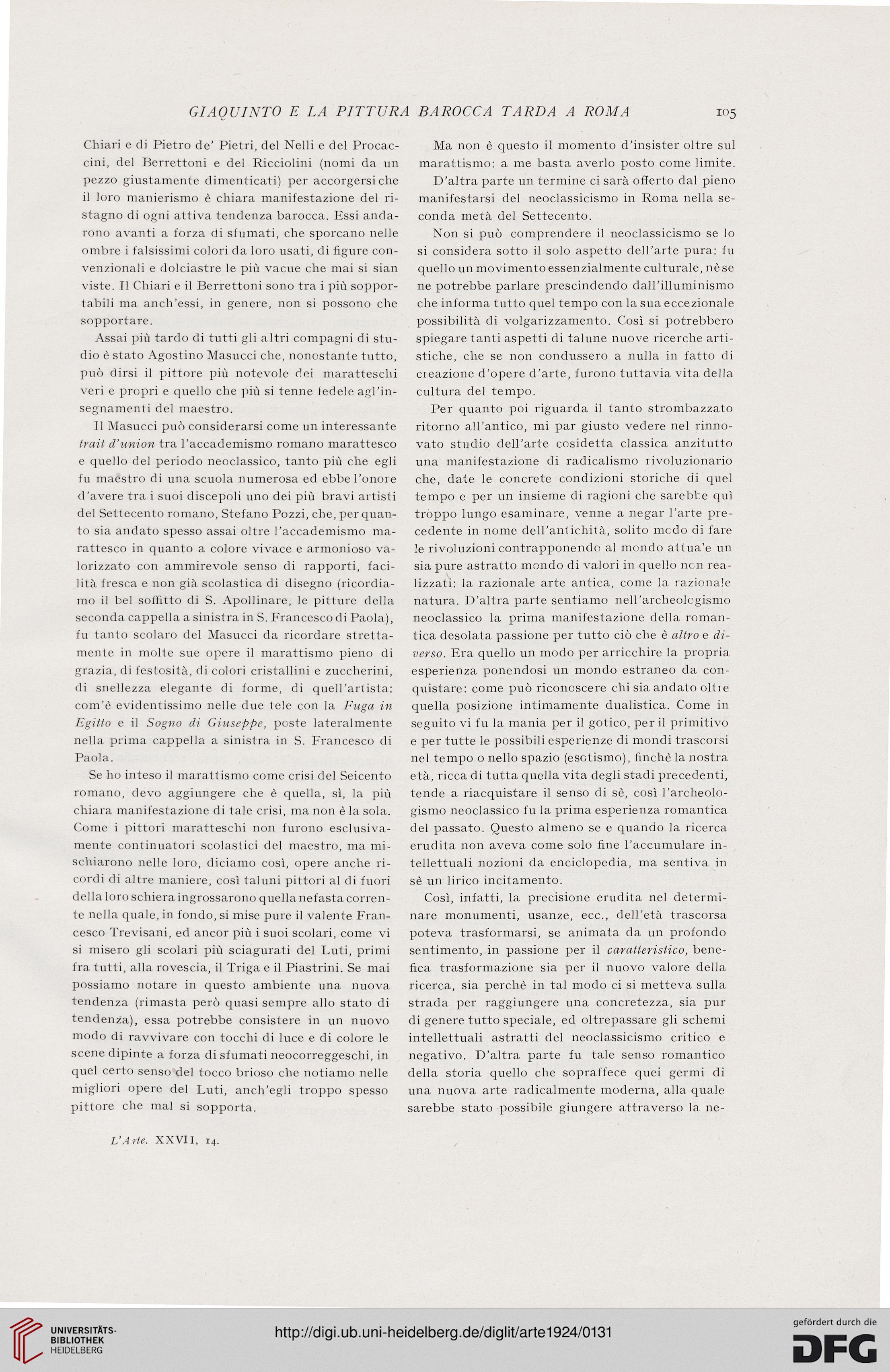GIAOUINTO E LA PITTURA BAROCCA TARDA A ROMA
i°5
Chiari e di Pietro de' Pietri, del Nelli e del Procac-
cini, del Berrettoni e del Ricciolini (nomi da un
pezzo giustamente dimenticati) per accorgersi che
il loro manierismo è chiara manifestazione del ri-
stagno di ogni attiva tendenza barocca. Essi anda-
rono avanti a forza di sfumati, che sporcano nelle
ombre i faìsissimi colori da loro usati, di figure con-
venzionali e dolciastre le più vacue che mai si sian
viste. TI Chiari e il Berrettoni sono tra i più soppor-
tabili ma anch'essi, in genere, non si possono che
sopportare.
Assai più tardo di tutti gli altri compagni di stu-
dio è stato Agostino Masucci che, nonostante tutto,
può dirsi il pittore più notevole dei maratteschi
veri e propri e quello che più si tenne fedele agl'in-
segnamenti del maestro.
Il Masucci può considerarsi come un interessante
trait d'union tra l'accademismo romano marattesco
e quello del periodo neoclassico, tanto più che egli
fu maestro di una scuola numerosa ed ebbe l'onore
d'avere tra i suoi discepoli uno dei più bravi artisti
del Settecento romano, Stefano Pozzi, che, per quan-
to sia andato spesso assai oltre l'accademismo ma-
rattesco in quanto a colore vivace e armonioso va-
lorizzato con ammirevole senso di rapporti, faci-
lità fresca e non già scolastica di disegno (ricordia-
mo il bel soffitto di S. Apollinare, le pitture della
seconda cappella a sinistra in S. Francesco di Paola),
fu tanto scolaro del Masucci da ricordare stretta-
mente in molte sue opere il marattismo pieno di
grazia, di festosità, di colori cristallini e zuccherini,
di snellezza elegante di forme, di quell'artista:
com'è evidentissimo nelle due tele con la Fuga in
Egitto e il Sogno di Giuseppe, poste lateralmente
nella prima cappella a sinistra in S. Francesco di
Paola.
Se ho inteso il marattismo come crisi del Seicento
romano, devo aggiungere che è quella, si, la più
chiara manifestazione di tale crisi, ma non è la sola.
Come i pittori maratteschi non furono esclusiva-
mente continuatori scolastici del maestro, ma mi-
schiarono nelle loro, diciamo così, opere anche ri-
cordi di altre maniere, cosi taluni pittori al di fuori
della loro schiera ingrossarono quella nefasta corren-
te nella quale, in fondo, si mise pure il valente Fran-
cesco Trevisani, ed ancor più i suoi scolari, come vi
si misero gli scolari più sciagurati del Luti, primi
fra tutti, alla rovescia, il Triga e il Piastrini. Se mai
possiamo notare in questo ambiente una nuova
tendenza (rimasta però quasi sempre allo stato di
tendenza), essa potrebbe consistere in un nuovo
modo di ravvivare con tocchi di luce e di colore le
scene dipinte a forza di sfumati neocorreggeschi, in
quel certo senso del tocco brioso che notiamo nelle
migliori opere del Luti, anch'egli troppo spesso
pittore che mal si sopporta.
Ma non è questo il momento d'insister oltre sul
marattismo: a me basta averlo posto come limite.
D'altra parte un termine ci sarà offerto dal pieno
manifestarsi del neoclassicismo in Roma nella se-
conda metà del Settecento.
Non si può comprendere il neoclassicismo se lo
si considera sotto il solo aspetto dell'arte pura: fu
quello un movimento essenzialmente culturale, nèse
ne potrebbe parlare prescindendo dall'illuminismo
che informa tutto quel tempo con la sua eccezionale
possibilità di volgarizzamento. Così si potrebbero
spiegare tanti aspetti di talune nuove ricerche arti-
stiche, che se non condussero a nulla in fatto di
creazione d'opere d'arte, furono tuttavia vita della
cultura del tempo.
Per quanto poi riguarda il tanto strombazzato
ritorno all'antico, mi par giusto vedere nel rinno-
vato studio dell'arte cosidetta classica anzitutto
una manifestazione di radicalismo rivoluzionario
che, date le concrete condizioni storiche di quel
tempo e per un insieme di ragioni che sarebbe qui
troppo lungo esaminare, venne a negar l'arte pre-
cedente in nome dell'antichità, solito mcdo di fare
le rivoluzioni contrapponendo al mondo attua'e un
sia pure astratto mondo di valori in quello non rea-
lizzati: la razionale arte antica, come la razionale
natura. D'altra parte sentiamo nell'archeologismo
neoclassico la prima manifestazione della roman-
tica desolata passione per tutto ciò che è altro e di-
verso. Era quello un modo per arricchire la propria
esperienza ponendosi un mondo estraneo da con-
quistare: come può riconoscere chi sia andato oltie
quella posizione intimamente dualistica. Come in
seguito vi fu la mania per il gotico, per il primitivo
e per tutte le possibili esperienze di mondi trascorsi
nel tempo o nello spazio (esotismo), finché la nostra
età, ricca di tutta quella vita degli stadi precedenti,
tende a riacquistare il senso di sè, così l'archeolo-
gismo neoclassico fu la prima esperienza romantica
del passato. Questo almeno se e quando la ricerca
erudita non aveva come solo fine l'accumulare in-
tellettuali nozioni da enciclopedia, ma sentiva in
sè un lirico incitamento.
Così, infatti, la precisione erudita nel determi-
nare monumenti, usanze, ecc., dell'età trascorsa
poteva trasformarsi, se animata da un profondo
sentimento, in passione per il caratteristico, bene-
fica trasformazione sia per il nuovo valore della
ricerca, sia perchè in tal modo ci si metteva sulla
strada per raggiungere una concretezza, sia pur
di genere tutto speciale, ed oltrepassare gli schemi
intellettuali astratti del neoclassicismo critico e
negativo. D'altra parte fu tale senso romantico
della storia quello che sopraffece quei germi di
una nuova arte radicalmente moderna, alla quale
sarebbe stato possibile giungere attraverso la ne-
L'Arte. XXVI1, 14.
i°5
Chiari e di Pietro de' Pietri, del Nelli e del Procac-
cini, del Berrettoni e del Ricciolini (nomi da un
pezzo giustamente dimenticati) per accorgersi che
il loro manierismo è chiara manifestazione del ri-
stagno di ogni attiva tendenza barocca. Essi anda-
rono avanti a forza di sfumati, che sporcano nelle
ombre i faìsissimi colori da loro usati, di figure con-
venzionali e dolciastre le più vacue che mai si sian
viste. TI Chiari e il Berrettoni sono tra i più soppor-
tabili ma anch'essi, in genere, non si possono che
sopportare.
Assai più tardo di tutti gli altri compagni di stu-
dio è stato Agostino Masucci che, nonostante tutto,
può dirsi il pittore più notevole dei maratteschi
veri e propri e quello che più si tenne fedele agl'in-
segnamenti del maestro.
Il Masucci può considerarsi come un interessante
trait d'union tra l'accademismo romano marattesco
e quello del periodo neoclassico, tanto più che egli
fu maestro di una scuola numerosa ed ebbe l'onore
d'avere tra i suoi discepoli uno dei più bravi artisti
del Settecento romano, Stefano Pozzi, che, per quan-
to sia andato spesso assai oltre l'accademismo ma-
rattesco in quanto a colore vivace e armonioso va-
lorizzato con ammirevole senso di rapporti, faci-
lità fresca e non già scolastica di disegno (ricordia-
mo il bel soffitto di S. Apollinare, le pitture della
seconda cappella a sinistra in S. Francesco di Paola),
fu tanto scolaro del Masucci da ricordare stretta-
mente in molte sue opere il marattismo pieno di
grazia, di festosità, di colori cristallini e zuccherini,
di snellezza elegante di forme, di quell'artista:
com'è evidentissimo nelle due tele con la Fuga in
Egitto e il Sogno di Giuseppe, poste lateralmente
nella prima cappella a sinistra in S. Francesco di
Paola.
Se ho inteso il marattismo come crisi del Seicento
romano, devo aggiungere che è quella, si, la più
chiara manifestazione di tale crisi, ma non è la sola.
Come i pittori maratteschi non furono esclusiva-
mente continuatori scolastici del maestro, ma mi-
schiarono nelle loro, diciamo così, opere anche ri-
cordi di altre maniere, cosi taluni pittori al di fuori
della loro schiera ingrossarono quella nefasta corren-
te nella quale, in fondo, si mise pure il valente Fran-
cesco Trevisani, ed ancor più i suoi scolari, come vi
si misero gli scolari più sciagurati del Luti, primi
fra tutti, alla rovescia, il Triga e il Piastrini. Se mai
possiamo notare in questo ambiente una nuova
tendenza (rimasta però quasi sempre allo stato di
tendenza), essa potrebbe consistere in un nuovo
modo di ravvivare con tocchi di luce e di colore le
scene dipinte a forza di sfumati neocorreggeschi, in
quel certo senso del tocco brioso che notiamo nelle
migliori opere del Luti, anch'egli troppo spesso
pittore che mal si sopporta.
Ma non è questo il momento d'insister oltre sul
marattismo: a me basta averlo posto come limite.
D'altra parte un termine ci sarà offerto dal pieno
manifestarsi del neoclassicismo in Roma nella se-
conda metà del Settecento.
Non si può comprendere il neoclassicismo se lo
si considera sotto il solo aspetto dell'arte pura: fu
quello un movimento essenzialmente culturale, nèse
ne potrebbe parlare prescindendo dall'illuminismo
che informa tutto quel tempo con la sua eccezionale
possibilità di volgarizzamento. Così si potrebbero
spiegare tanti aspetti di talune nuove ricerche arti-
stiche, che se non condussero a nulla in fatto di
creazione d'opere d'arte, furono tuttavia vita della
cultura del tempo.
Per quanto poi riguarda il tanto strombazzato
ritorno all'antico, mi par giusto vedere nel rinno-
vato studio dell'arte cosidetta classica anzitutto
una manifestazione di radicalismo rivoluzionario
che, date le concrete condizioni storiche di quel
tempo e per un insieme di ragioni che sarebbe qui
troppo lungo esaminare, venne a negar l'arte pre-
cedente in nome dell'antichità, solito mcdo di fare
le rivoluzioni contrapponendo al mondo attua'e un
sia pure astratto mondo di valori in quello non rea-
lizzati: la razionale arte antica, come la razionale
natura. D'altra parte sentiamo nell'archeologismo
neoclassico la prima manifestazione della roman-
tica desolata passione per tutto ciò che è altro e di-
verso. Era quello un modo per arricchire la propria
esperienza ponendosi un mondo estraneo da con-
quistare: come può riconoscere chi sia andato oltie
quella posizione intimamente dualistica. Come in
seguito vi fu la mania per il gotico, per il primitivo
e per tutte le possibili esperienze di mondi trascorsi
nel tempo o nello spazio (esotismo), finché la nostra
età, ricca di tutta quella vita degli stadi precedenti,
tende a riacquistare il senso di sè, così l'archeolo-
gismo neoclassico fu la prima esperienza romantica
del passato. Questo almeno se e quando la ricerca
erudita non aveva come solo fine l'accumulare in-
tellettuali nozioni da enciclopedia, ma sentiva in
sè un lirico incitamento.
Così, infatti, la precisione erudita nel determi-
nare monumenti, usanze, ecc., dell'età trascorsa
poteva trasformarsi, se animata da un profondo
sentimento, in passione per il caratteristico, bene-
fica trasformazione sia per il nuovo valore della
ricerca, sia perchè in tal modo ci si metteva sulla
strada per raggiungere una concretezza, sia pur
di genere tutto speciale, ed oltrepassare gli schemi
intellettuali astratti del neoclassicismo critico e
negativo. D'altra parte fu tale senso romantico
della storia quello che sopraffece quei germi di
una nuova arte radicalmente moderna, alla quale
sarebbe stato possibile giungere attraverso la ne-
L'Arte. XXVI1, 14.