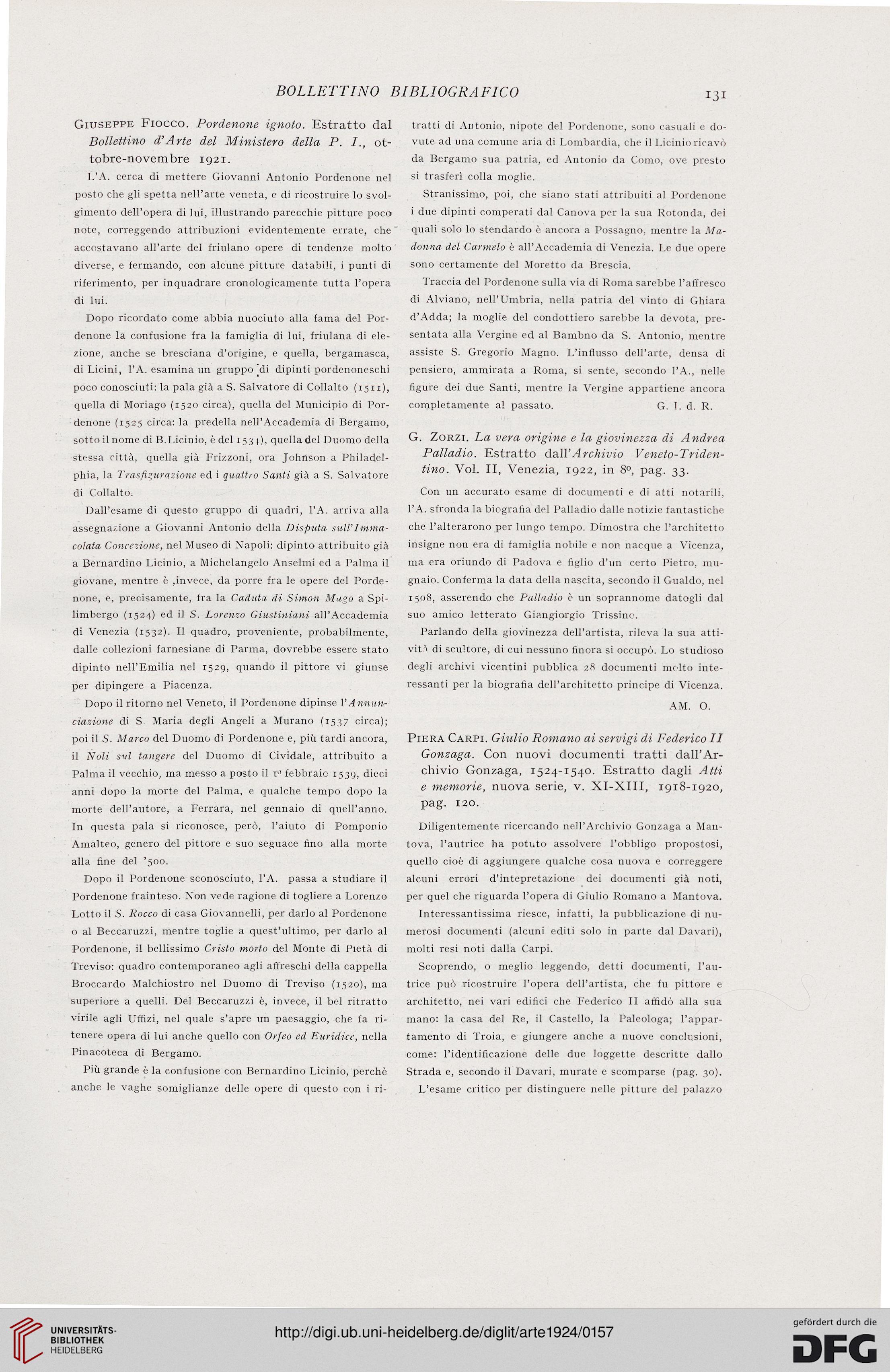BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Giuseppe Fiocco. Pordenone ignoto. Estratto dal
Bollettino d'Arte del Ministero della P. I., ot-
tobre-novembre 1921.
L'A. cerca di mettere Giovanni Antonio Pordenone nel
posto che gli spetta nell'arte veneta, e di ricostruire lo svol-
gimento dell'opera di lui, illustrando parecchie pitture poco
note, correggendo attribuzioni evidentemente errate, che
accostavano all'arte del friulano opere di tendenze molto
diverse, e fermando, con alcune pitture databili, i punti di
riferimento, per inquadrare cronologicamente tutta l'opera
di lui.
Dopo ricordato come abbia nuociuto alla fama del Por-
denone la confusione fra la famiglia di lui, friulana di ele-
zione, anche se bresciana d'origine, e quella, bergamasca,
di Licini, l'A. esamina un gruppo di dipinti pordenoneschi
poco conosciuti: la pala già a S. Salvatore di Collalto (1511),
quella di Moriago (1520 circa), quella del Municipio di Por-
denone (1525 circa: la predella nell'Accademia di Bergamo,
sotto il nome di B.Licinio, è del 1531), quella del Duomo della
stessa città, quella già Frizzoni, ora Johnson a Philadel-
phia, la Trasfigurazione ed i quattro Santi già a S. Salvatore
di Collalto.
Dall'esame di questo gruppo di quadri, l'A. arriva alla
assegnazione a Giovanni Antonio della Disputa sulVImma-
colata Concezione, nel Museo di Napoli: dipinto attribuito già
a Bernardino Licinio, a Michelangelo Anselmi ed a Palma il
giovane, mentre è ,invece, da porre fra le opere del Porde-
none, e, precisamente, fra la Caduta di Simon Mago a Spi-
limbergo (1524) ed il S. Lorenzo Giustiniani all'Accademia
di Venezia (1532). Il quadro, proveniente, probabilmente,
dalle collezioni farnesiane di Parma, dovrebbe essere stato
dipinto nell'Emilia nel 1529, quando il pittore vi giunse
per dipingere a Piacenza.
Dopo il ritorno nel Veneto, il Pordenone dipinse VAnnun-
ciazione di S. Maria degli Angeli a Murano (1537 circa);
poi il S. Marco del Duomo di Pordenone e, più tardi ancora,
il Noli sul tangere del Duomo di Cividale, attribuito a
Palma il vecchio, ma messo a posto il V febbraio 1539, dieci
anni dopo la morte del Palma, e qualche tempo dopo la
morte dell'autore, a Ferrara, nel gennaio di quell'anno.
In questa pala si riconosce, però, l'aiuto di Pomponio
Amalteo, genero del pittore e suo seguace fino alla morte
alla fine del '500.
Dopo il Pordenone sconosciuto, l'A. passa a studiare il
Pordenone frainteso. Non vede ragione di togliere a Lorenzo
Lotto il S. Rocco di casa Giovannelli, per darlo al Pordenone
o al Beccaruzzi, mentre toglie a quest'ultimo, per darlo al
Pordenone, il bellissimo Cristo morto del Monte di Pietà di
Treviso: quadro contemporaneo agli affreschi della cappella
Broccardo Malchiostro nel Duomo di Treviso (1520), ma
superiore a quelli. De] Beccaruzzi è, invece, il bel ritratto
virile agli Uffizi, nel quale s'apre un paesaggio, che fa ri-
tenere opera di lui anche quello con Orfeo ed Euridice, nella
Pinacoteca di Bergamo.
Più grande è la confusione con Bernardino Licinio, perchè
anche le vaghe somiglianze delle opere di questo con i ri-
tratti di Antonio, nipote del Pordenone, sono casuali e do-
vute ad una comune aria di Lombardia, che il Licinio ricavò
da Bergamo sua patria, ed Antonio da Como, ove presto
si trasferì colla moglie.
Stranissimo, poi, che siano stati attribuiti al Pordenone
i due dipinti comperati dal Canova per la sua Rotonda, dei
quali solo lo stendardo è ancora a Possagno, mentre la Ma-
donna del Carmelo è all'Accademia di Venezia. Le due opere
sono certamente del Moretto da Brescia.
Traccia del Pordenone sulla via di Roma sarebbe l'affresco
di Alviano, nell'Umbria, nella patria del vinto di Chiara
d'Adda; la moglie del condottiero sarebbe la devota, pre-
sentata alla Vergine ed al Bambno da S. Antonio, mentre
assiste S. Gregorio Magno. L'influsso dell'arte, densa di
pensiero, ammirata a Roma, si sente, secondo l'A., nelle
figure dei due Santi, mentre la Vergine appartiene ancora
completamente al passato. G. 1. d. R.
G. Zorzi. La vera origine e la giovinezza di Andrea
Palladio. Estratto dall' Archivio Veneto-Triden-
tino. Voi. II, Venezia, 1922, in 8°, pag. 33.
Con un accurato esame di documenti e di atti notarili,
l'A. sfronda la biografia del Palladio dalle notizie fantastiche
che l'alterarono per lungo tempo. Dimostra che l'architetto
insigne non era di famiglia nobile e non nacque a Vicenza,
ma era oriundo di Padova e figlio d'un certo Pietro, mu-
gnaio. Conferma la data della nascita, secondo il Gualdo, nel
1508, asserendo che Palladio è un soprannome datogli dal
suo amico letterato Giangiorgio Trissino.
Parlando della giovinezza dell'artista, rileva la sua atti-
viti di scultore, di cui nessuno finora si occupò. Lo studioso
degli archivi vicentini pubblica 28 documenti molto inte-
ressanti per la biografia dell'architetto principe di Vicenza.
AM. O.
Piera Carpi. Giulio Romano ai servigi di Federico II
Gonzaga. Con nuovi documenti tratti dall'Ar-
chivio Gonzaga, 1524-1540. Estratto dagli Atti
e memorie, nuova serie, v. XI-XIII, 1918-1920,
pag. 120.
Diligentemente ricercando nell'Archivio Gonzaga a Man-
tova, l'autrice ha potuto assolvere l'obbligo propostosi,
quello cioè di aggiungere qualche cosa nuova e correggere
alcuni errori d'intepretazione dei documenti già noti,
per quel che riguarda l'opera di Giulio Romano a Mantova.
Interessantissima riesce, infatti, la pubblicazione di nu-
merosi documenti (alcuni editi solo in parte dal Davari),
molti resi noti dalla Carpi.
Scoprendo, o meglio leggendo, detti documenti, l'au-
trice può ricostruire l'opera dell'artista, che fu pittore e
architetto, nei vari edifici che Federico II affidò alla sua
mano: la casa del Re, il Castello, la Paleoioga; l'appar-
tamento di Troia, e giungere anche a nuove conclusioni,
come: l'identificazione delle due loggette descritte dallo
Strada e, secondo il Davari, murate e scomparse, (pag. 30).
L'esame critico per distinguere nelle pitture del palazzo
Giuseppe Fiocco. Pordenone ignoto. Estratto dal
Bollettino d'Arte del Ministero della P. I., ot-
tobre-novembre 1921.
L'A. cerca di mettere Giovanni Antonio Pordenone nel
posto che gli spetta nell'arte veneta, e di ricostruire lo svol-
gimento dell'opera di lui, illustrando parecchie pitture poco
note, correggendo attribuzioni evidentemente errate, che
accostavano all'arte del friulano opere di tendenze molto
diverse, e fermando, con alcune pitture databili, i punti di
riferimento, per inquadrare cronologicamente tutta l'opera
di lui.
Dopo ricordato come abbia nuociuto alla fama del Por-
denone la confusione fra la famiglia di lui, friulana di ele-
zione, anche se bresciana d'origine, e quella, bergamasca,
di Licini, l'A. esamina un gruppo di dipinti pordenoneschi
poco conosciuti: la pala già a S. Salvatore di Collalto (1511),
quella di Moriago (1520 circa), quella del Municipio di Por-
denone (1525 circa: la predella nell'Accademia di Bergamo,
sotto il nome di B.Licinio, è del 1531), quella del Duomo della
stessa città, quella già Frizzoni, ora Johnson a Philadel-
phia, la Trasfigurazione ed i quattro Santi già a S. Salvatore
di Collalto.
Dall'esame di questo gruppo di quadri, l'A. arriva alla
assegnazione a Giovanni Antonio della Disputa sulVImma-
colata Concezione, nel Museo di Napoli: dipinto attribuito già
a Bernardino Licinio, a Michelangelo Anselmi ed a Palma il
giovane, mentre è ,invece, da porre fra le opere del Porde-
none, e, precisamente, fra la Caduta di Simon Mago a Spi-
limbergo (1524) ed il S. Lorenzo Giustiniani all'Accademia
di Venezia (1532). Il quadro, proveniente, probabilmente,
dalle collezioni farnesiane di Parma, dovrebbe essere stato
dipinto nell'Emilia nel 1529, quando il pittore vi giunse
per dipingere a Piacenza.
Dopo il ritorno nel Veneto, il Pordenone dipinse VAnnun-
ciazione di S. Maria degli Angeli a Murano (1537 circa);
poi il S. Marco del Duomo di Pordenone e, più tardi ancora,
il Noli sul tangere del Duomo di Cividale, attribuito a
Palma il vecchio, ma messo a posto il V febbraio 1539, dieci
anni dopo la morte del Palma, e qualche tempo dopo la
morte dell'autore, a Ferrara, nel gennaio di quell'anno.
In questa pala si riconosce, però, l'aiuto di Pomponio
Amalteo, genero del pittore e suo seguace fino alla morte
alla fine del '500.
Dopo il Pordenone sconosciuto, l'A. passa a studiare il
Pordenone frainteso. Non vede ragione di togliere a Lorenzo
Lotto il S. Rocco di casa Giovannelli, per darlo al Pordenone
o al Beccaruzzi, mentre toglie a quest'ultimo, per darlo al
Pordenone, il bellissimo Cristo morto del Monte di Pietà di
Treviso: quadro contemporaneo agli affreschi della cappella
Broccardo Malchiostro nel Duomo di Treviso (1520), ma
superiore a quelli. De] Beccaruzzi è, invece, il bel ritratto
virile agli Uffizi, nel quale s'apre un paesaggio, che fa ri-
tenere opera di lui anche quello con Orfeo ed Euridice, nella
Pinacoteca di Bergamo.
Più grande è la confusione con Bernardino Licinio, perchè
anche le vaghe somiglianze delle opere di questo con i ri-
tratti di Antonio, nipote del Pordenone, sono casuali e do-
vute ad una comune aria di Lombardia, che il Licinio ricavò
da Bergamo sua patria, ed Antonio da Como, ove presto
si trasferì colla moglie.
Stranissimo, poi, che siano stati attribuiti al Pordenone
i due dipinti comperati dal Canova per la sua Rotonda, dei
quali solo lo stendardo è ancora a Possagno, mentre la Ma-
donna del Carmelo è all'Accademia di Venezia. Le due opere
sono certamente del Moretto da Brescia.
Traccia del Pordenone sulla via di Roma sarebbe l'affresco
di Alviano, nell'Umbria, nella patria del vinto di Chiara
d'Adda; la moglie del condottiero sarebbe la devota, pre-
sentata alla Vergine ed al Bambno da S. Antonio, mentre
assiste S. Gregorio Magno. L'influsso dell'arte, densa di
pensiero, ammirata a Roma, si sente, secondo l'A., nelle
figure dei due Santi, mentre la Vergine appartiene ancora
completamente al passato. G. 1. d. R.
G. Zorzi. La vera origine e la giovinezza di Andrea
Palladio. Estratto dall' Archivio Veneto-Triden-
tino. Voi. II, Venezia, 1922, in 8°, pag. 33.
Con un accurato esame di documenti e di atti notarili,
l'A. sfronda la biografia del Palladio dalle notizie fantastiche
che l'alterarono per lungo tempo. Dimostra che l'architetto
insigne non era di famiglia nobile e non nacque a Vicenza,
ma era oriundo di Padova e figlio d'un certo Pietro, mu-
gnaio. Conferma la data della nascita, secondo il Gualdo, nel
1508, asserendo che Palladio è un soprannome datogli dal
suo amico letterato Giangiorgio Trissino.
Parlando della giovinezza dell'artista, rileva la sua atti-
viti di scultore, di cui nessuno finora si occupò. Lo studioso
degli archivi vicentini pubblica 28 documenti molto inte-
ressanti per la biografia dell'architetto principe di Vicenza.
AM. O.
Piera Carpi. Giulio Romano ai servigi di Federico II
Gonzaga. Con nuovi documenti tratti dall'Ar-
chivio Gonzaga, 1524-1540. Estratto dagli Atti
e memorie, nuova serie, v. XI-XIII, 1918-1920,
pag. 120.
Diligentemente ricercando nell'Archivio Gonzaga a Man-
tova, l'autrice ha potuto assolvere l'obbligo propostosi,
quello cioè di aggiungere qualche cosa nuova e correggere
alcuni errori d'intepretazione dei documenti già noti,
per quel che riguarda l'opera di Giulio Romano a Mantova.
Interessantissima riesce, infatti, la pubblicazione di nu-
merosi documenti (alcuni editi solo in parte dal Davari),
molti resi noti dalla Carpi.
Scoprendo, o meglio leggendo, detti documenti, l'au-
trice può ricostruire l'opera dell'artista, che fu pittore e
architetto, nei vari edifici che Federico II affidò alla sua
mano: la casa del Re, il Castello, la Paleoioga; l'appar-
tamento di Troia, e giungere anche a nuove conclusioni,
come: l'identificazione delle due loggette descritte dallo
Strada e, secondo il Davari, murate e scomparse, (pag. 30).
L'esame critico per distinguere nelle pitture del palazzo