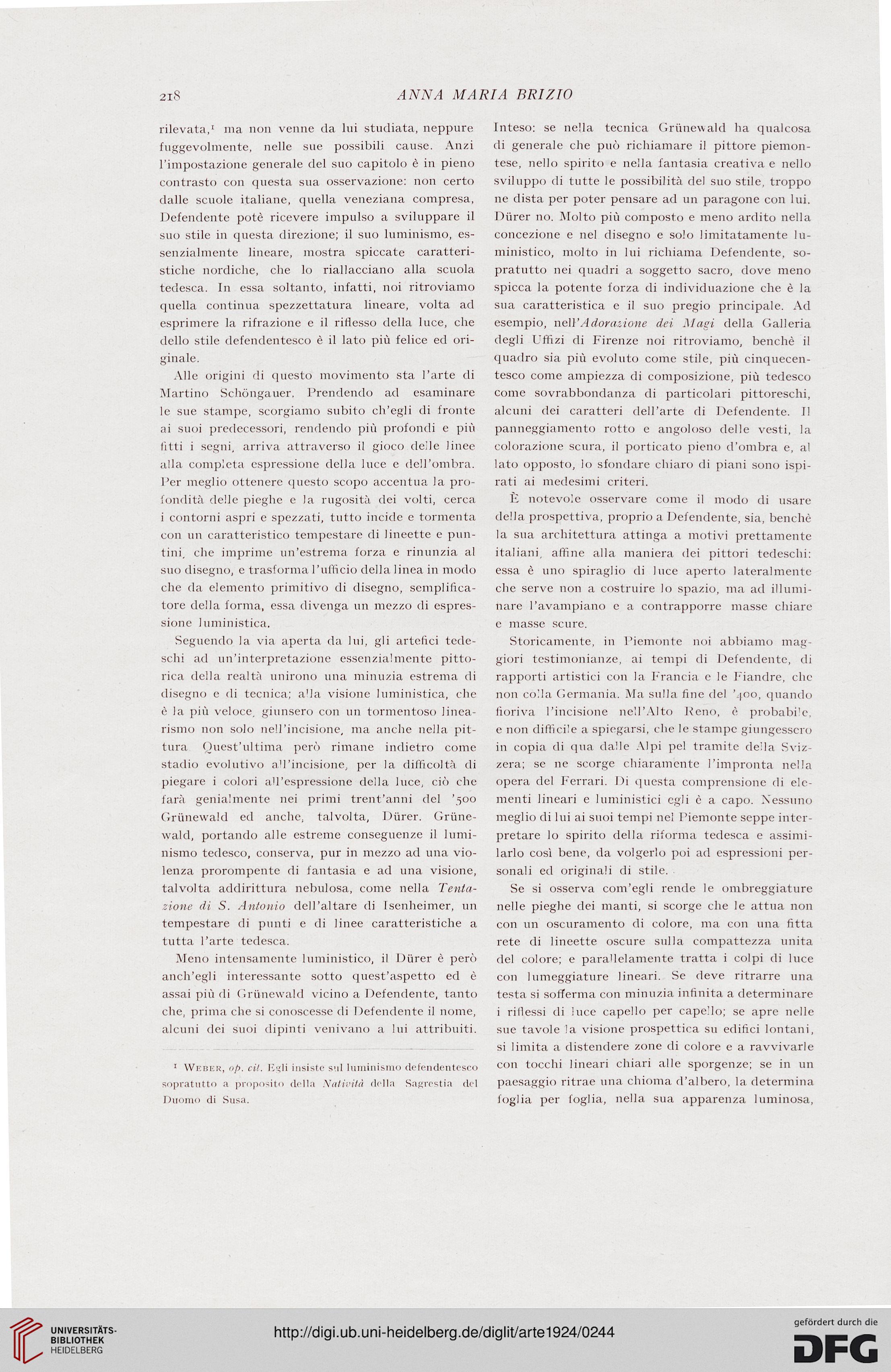2lS
ANNA MARIA BRI ZIO
rilevata,1 ma non venne da lui studiata, neppure
fuggevolmente, nelle sue possibili cause. Anzi
l'impostazione generale del suo capitolo è in pieno
contrasto con questa sua osservazione: non certo
dalle scuole italiane, quella veneziana compresa,
Defendente potè ricevere impulso a sviluppare il
suo stile in questa direzione; il suo luminismo, es-
senzialmente lineare, mostra spiccate caratteri-
stiche nordiche, che lo riallacciano alla scuola
tedesca. In essa soltanto, infatti, noi ritroviamo
quella continua spezzettatura lineare, volta ad
esprimere la rifrazione e il riflesso della luce, che
dello stile defendentesco è il lato più felice ed ori-
ginale.
Alle origini di questo movimento sta l'arte di
Martino Schòngauer, Prendendo ad esaminare
le sue stampe, scorgiamo subito ch'egli di fronte
ai suoi predecessori, rendendo più profondi e più
fitti i segni, arriva attraverso il gioco delle linee
alla completa espressione della luce e dell'timbra.
Per meglio ottenere questo scopo accentua la pro-
fondità delle pieghe e la rugosità dei volti, cerca
i contorni aspri e spezzati, tutto incide e tormenta
con un caratteristico tempestare di lineette e pun-
tini, che imprime un'estrema forza e rinunzia al
suo disegno, e trasforma l'ufficio della linea in modo
clic da elemento primitivo di disegno, semplifica-
tore della forma, essa divenga un mezzo di espres-
sione luministica.
Seguendo la via aperta da lui, gli artefici tede-
schi ad un'interpretazione essenzialmente pitto-
rica della realtà unirono una minuzia estrema di
disegno e di tecnica; a'Ja visione luministica, che
è la più veloce, giunsero con un tormentoso linea-
rismo non solo nell'incisione, ma anche nella pit-
tura Quest'ultima però rimane indietro come
stadio evolutivo a'l'incisione, per la difficoltà di
piegare i colori all'espressione della luce, ciò che
laià genialmente nei primi trent'anni del '.^oo
Griinewald ed anche, talvolta, J>ùrer. Grùne-
vyald, portando alle estreme conseguenze il lumi-
nismo tedesco, conserva, pur in mezzo ad una vio-
lenza prorompente di fantasia e ad una visione,
talvolta addirittura nebulosa, come nella Tenta-
zione di S. Antonio dell'altare di Isenheimer, un
tempestare di punti e di linee caratteristiche a
tutta l'arte tedesca.
.Meno intensamente luministico, il Dùrer è però
anch'egli interessante sotto quest'aspetto ed è
assai più di Griinewald vicino a Defendente, tanto
che, prima che si conoscesse di Defendente il nome,
alcuni dei suoi dipinti venivano a lui attribuiti.
1 Weber, <</>. cit. Egli insiste sul luminismo defendentesco
sopratutto a proposito della Natività della Sagrestia del
Duomo di Susa.
Inteso: se nella tecnica Griinewald ha qualcosa
di generale che può richiamare il pittore piemon-
tese, nello spirito e nella fantasia creativa e nello
sviluppo di tutte le possibilità del suo stile, troppo
ne dista per poter pensare ad un paragone con lui.
Dùrer no. Molto più composto e meno ardito nella
concezione e nel disegno e solo limitatamente lu-
ministico, molto in lui richiama Defendente, so-
pratutto nei quadri a soggetto sacro, dove meno
spicca la potente forza di individuazione che è la
sua caratteristica e il suo pregio principale. Ad
esempio, nel!'Adorazione dei Magi della Galleria
degli Uffizi di Firenze noi ritroviamo, benché il
quadro sia più evoluto come stile, più cinquecen-
tesco come ampiezza di composizione, più tedesco
come sovrabbondanza di particolari pittoreschi,
alcuni dei caratteri dell'arte di Defendente. 11
panneggiamento rotto e angoloso delle vesti, la
colorazione scura, il porticato pieno d'ombra e, al
lato opposto, lo sfondare chiaro di piani sono ispi-
rati ai medesimi criteri.
È notevole osservare come il modo di usare
della prospettiva, proprio a Defendente, sia, benché
la sua architettura attinga a motivi prettamente
italiani, affine alla maniera dei pittori tedeschi:
essa è uno spiraglio di luce aperto lateralmente
che serve non a costruire lo spazio, ma ad illumi-
nare l'avampiano e a contrapporre masse chiare
e masse scure.
Storicamente, in Piemonte noi abbiamo mag-
giori testimonianze, ai tempi di Defendente, di
rapporti artistici con la Francia e le Fiandre, che
non colla Germania. Ma sulla fine del '400, quando
fioriva l'incisione nell'Alto Reno, è probabile,
e non difficile a spiegarsi, che le stampe giungessero
in copia di (pia dalle Alpi pel tramite della Sviz
zera; se ne scorge chiaramente l'impronta nella
opera del Ferrari. Di questa comprensione di ele-
menti lineari e luministici egli e a capo. Nessuno
meglio di lui ai suoi tempi nel Piemonte seppe inter-
pretare lo spirito della riforma tedesca e assimi-
larlo cosi bene, da volgerlo poi ad espressioni per-
sonali ed originali di stile.
Se si osserva com'egli rende le ombreggiature
nelle pieghe dei manti, si scorge che le attua non
con un oscuramento di colore, ma con una fitta
rete di lineette oscure sulla compattezza unita
del colore; e parallelamente tratta i colpi di luce
con lumeggiature lineari. Se deve ritrarre una
testa si sofferma con minuzia infinita a determinare
i riflessi di luce capello per capello; se apre nelle
sue tavole la visione prospettica su edifici lontani,
si limita a distendere zone di colore e a ravvivarle
con tocchi lineari chiari alle sporgenze; se in un
paesaggio ritrae una chioma d'albero, la determina
foglia per foglia, nella sua apparenza luminosa,
ANNA MARIA BRI ZIO
rilevata,1 ma non venne da lui studiata, neppure
fuggevolmente, nelle sue possibili cause. Anzi
l'impostazione generale del suo capitolo è in pieno
contrasto con questa sua osservazione: non certo
dalle scuole italiane, quella veneziana compresa,
Defendente potè ricevere impulso a sviluppare il
suo stile in questa direzione; il suo luminismo, es-
senzialmente lineare, mostra spiccate caratteri-
stiche nordiche, che lo riallacciano alla scuola
tedesca. In essa soltanto, infatti, noi ritroviamo
quella continua spezzettatura lineare, volta ad
esprimere la rifrazione e il riflesso della luce, che
dello stile defendentesco è il lato più felice ed ori-
ginale.
Alle origini di questo movimento sta l'arte di
Martino Schòngauer, Prendendo ad esaminare
le sue stampe, scorgiamo subito ch'egli di fronte
ai suoi predecessori, rendendo più profondi e più
fitti i segni, arriva attraverso il gioco delle linee
alla completa espressione della luce e dell'timbra.
Per meglio ottenere questo scopo accentua la pro-
fondità delle pieghe e la rugosità dei volti, cerca
i contorni aspri e spezzati, tutto incide e tormenta
con un caratteristico tempestare di lineette e pun-
tini, che imprime un'estrema forza e rinunzia al
suo disegno, e trasforma l'ufficio della linea in modo
clic da elemento primitivo di disegno, semplifica-
tore della forma, essa divenga un mezzo di espres-
sione luministica.
Seguendo la via aperta da lui, gli artefici tede-
schi ad un'interpretazione essenzialmente pitto-
rica della realtà unirono una minuzia estrema di
disegno e di tecnica; a'Ja visione luministica, che
è la più veloce, giunsero con un tormentoso linea-
rismo non solo nell'incisione, ma anche nella pit-
tura Quest'ultima però rimane indietro come
stadio evolutivo a'l'incisione, per la difficoltà di
piegare i colori all'espressione della luce, ciò che
laià genialmente nei primi trent'anni del '.^oo
Griinewald ed anche, talvolta, J>ùrer. Grùne-
vyald, portando alle estreme conseguenze il lumi-
nismo tedesco, conserva, pur in mezzo ad una vio-
lenza prorompente di fantasia e ad una visione,
talvolta addirittura nebulosa, come nella Tenta-
zione di S. Antonio dell'altare di Isenheimer, un
tempestare di punti e di linee caratteristiche a
tutta l'arte tedesca.
.Meno intensamente luministico, il Dùrer è però
anch'egli interessante sotto quest'aspetto ed è
assai più di Griinewald vicino a Defendente, tanto
che, prima che si conoscesse di Defendente il nome,
alcuni dei suoi dipinti venivano a lui attribuiti.
1 Weber, <</>. cit. Egli insiste sul luminismo defendentesco
sopratutto a proposito della Natività della Sagrestia del
Duomo di Susa.
Inteso: se nella tecnica Griinewald ha qualcosa
di generale che può richiamare il pittore piemon-
tese, nello spirito e nella fantasia creativa e nello
sviluppo di tutte le possibilità del suo stile, troppo
ne dista per poter pensare ad un paragone con lui.
Dùrer no. Molto più composto e meno ardito nella
concezione e nel disegno e solo limitatamente lu-
ministico, molto in lui richiama Defendente, so-
pratutto nei quadri a soggetto sacro, dove meno
spicca la potente forza di individuazione che è la
sua caratteristica e il suo pregio principale. Ad
esempio, nel!'Adorazione dei Magi della Galleria
degli Uffizi di Firenze noi ritroviamo, benché il
quadro sia più evoluto come stile, più cinquecen-
tesco come ampiezza di composizione, più tedesco
come sovrabbondanza di particolari pittoreschi,
alcuni dei caratteri dell'arte di Defendente. 11
panneggiamento rotto e angoloso delle vesti, la
colorazione scura, il porticato pieno d'ombra e, al
lato opposto, lo sfondare chiaro di piani sono ispi-
rati ai medesimi criteri.
È notevole osservare come il modo di usare
della prospettiva, proprio a Defendente, sia, benché
la sua architettura attinga a motivi prettamente
italiani, affine alla maniera dei pittori tedeschi:
essa è uno spiraglio di luce aperto lateralmente
che serve non a costruire lo spazio, ma ad illumi-
nare l'avampiano e a contrapporre masse chiare
e masse scure.
Storicamente, in Piemonte noi abbiamo mag-
giori testimonianze, ai tempi di Defendente, di
rapporti artistici con la Francia e le Fiandre, che
non colla Germania. Ma sulla fine del '400, quando
fioriva l'incisione nell'Alto Reno, è probabile,
e non difficile a spiegarsi, che le stampe giungessero
in copia di (pia dalle Alpi pel tramite della Sviz
zera; se ne scorge chiaramente l'impronta nella
opera del Ferrari. Di questa comprensione di ele-
menti lineari e luministici egli e a capo. Nessuno
meglio di lui ai suoi tempi nel Piemonte seppe inter-
pretare lo spirito della riforma tedesca e assimi-
larlo cosi bene, da volgerlo poi ad espressioni per-
sonali ed originali di stile.
Se si osserva com'egli rende le ombreggiature
nelle pieghe dei manti, si scorge che le attua non
con un oscuramento di colore, ma con una fitta
rete di lineette oscure sulla compattezza unita
del colore; e parallelamente tratta i colpi di luce
con lumeggiature lineari. Se deve ritrarre una
testa si sofferma con minuzia infinita a determinare
i riflessi di luce capello per capello; se apre nelle
sue tavole la visione prospettica su edifici lontani,
si limita a distendere zone di colore e a ravvivarle
con tocchi lineari chiari alle sporgenze; se in un
paesaggio ritrae una chioma d'albero, la determina
foglia per foglia, nella sua apparenza luminosa,