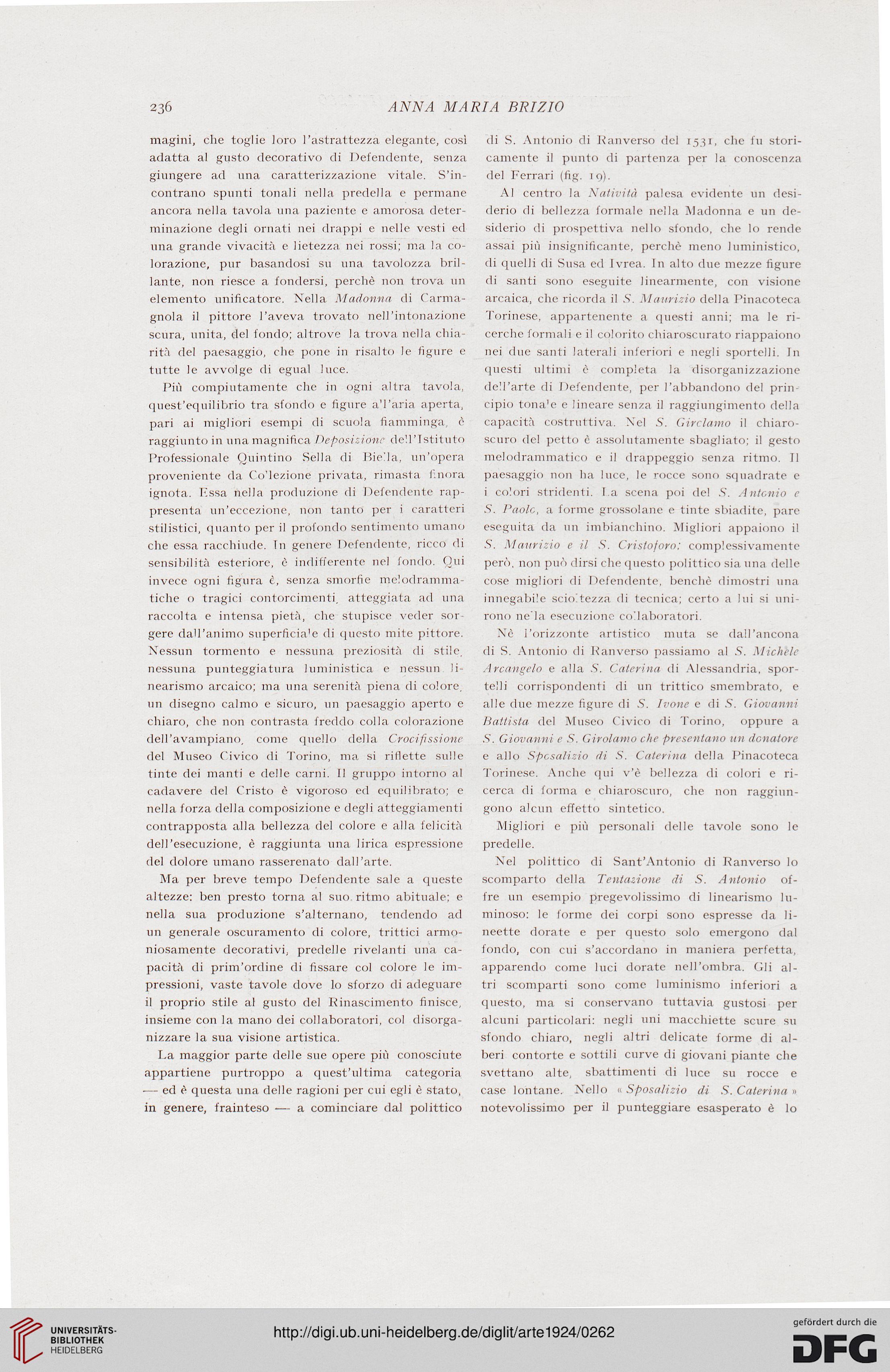236
ANNA MARIA BRI ZIO
magini, che toglie loro l'astrattezza elegante, cosi
adatta al gusto decorativo di Defendente, senza
giungere ad una caratterizzazione vitale. S'in-
contrano spunti tonali nella predella e permane
ancora nella tavola una paziente e amorosa deter-
minazione degli ornati nei drappi e nelle vesti ed
una grande vivacità e lietezza nei rossi; ma la co-
lorazione, pur basandosi su una tavolozza bril-
lante, non riesce a fondersi, perchè non trova un
elemento unificatore. Nella Madonna di Carma-
gnola il pittore l'aveva trovato nell'intonazione
scura, unita, del fondo; altrove la trova nella chia-
rità del paesaggio, che pone in risalto le figure e
tutte le avvolge di egual luce.
Più compiutamente che in ogni altra tavola,
quest'equilibrio tra sfondo e figure a'I'aria aperta,
pari ai migliori esempi di scuola fiamminga, è
raggiunto in una magnifica 'Deposizione dell'Istituto
Professionale Quintino Sella di Biella, un'opera
proveniente da Co'lezione privata, rimasta finora
ignota. Essa nella produzione di Defendente rap-
presenta un'eccezione, non tanto per i caratteri
stilistici, (pianto per il profondo sentimento umano
che essa racchiude. In genere Defendente, ricco di
sensibilità esteriore, è indifferente nel fondo. Cui
invece ogni figura è, senza smorfie melodramma-
tiche o tragici contorcimenti, atteggiata ad una
raccolta e intensa pietà, che stupisce veder sor-
gere dall'animo superficia'e di questo mite pittore.
Nessun tormento e nessuna preziosità di stile
nessuna punteggiatura luministica e nessun li-
nearismo arcaico; ma una serenità piena di colore,
un disegno calmo e sicuro, un paesaggio aperto e
chiaro, che non contrasta freddo colla, colorazione
dell'avampiano, come quello della Crocifissione
del Museo Civico di Torino, ma si ridette sulle
tinte dei manti e delle carni. 11 gruppo intorno al
cadavere del Cristo è vigoroso ed equilibrato; e
nella forza della composizione e degli atteggiamenti
contrapposta alla bellezza del colore e alla felicità
dell'esecuzione, è raggiunta una lirica espressione
del dolore umano rasserenato dall'arte.
Ma per breve tempo Defendente sale a queste
altezze: ben presto torna al suo ritmo abituale; e
nella sua produzione s'alternano, tendendo ad
un generale oscuramento di colore, trittici armo-
niosamente decorativi, predelle rivelanti una ca-
pacità di prim'ordine di fissare col colore le im-
pressioni, vaste tavole dove lo sforzo di adeguare
il proprio stile al gusto del Kinascimento finisce,
insieme con la mano dei collaboratori, col disorga-
nizzare la sua visione artistica.
La maggior parte delle sue opere più conosciute
appartiene purtroppo a quest'ultima categoria
-— ed è questa una delle ragioni per cui egli è stato,
in genere, frainteso — a cominciare dal polittico
di S. Antonio di Kanverso del 153r, che fu stori-
camente il punto di partenza per la conoscenza
del Ferrari (fig. 19).
Al centro la Natività palesa evidente un desi-
derio di bellezza formale nella Madonna e un de-
siderio di prospettiva nello sfondo, che lo rende
assai più insignificante, perchè meno luministico,
di quelli di Susa ed Ivrea. In alto due mezze figure
di santi sono eseguite linearmente, con visione
arcaica, che ricorda il S. Maurizio della Pinacoteca
Torinese, appartenente a questi anni; ma le ri-
cerche formali e il colorito chiaroscurato riappaiono
nei due santi laterali inferiori e negli sportelli. In
questi ultimi è completa la disorganizza/ione
dell'arte di Defendente, per l'abbandono del prin
cipio tona'e e lineare senza il raggiungimento della
capacità costruttiva. Nel .S'. Girolamo il chiaro-
scuro del petto è assolutamente sbagliato; il gesto
melodrammatico e il drappeggio senza ritmo. Il
paesaggio non ha luce, le rocce sono squadrate e
i colori stridenti. l a scena poi del ,S'. Antonio e
S. Paole, a forme grossolane e tinte sbiadite, pare
eseguita da un imbianchino. Migliori appaiono il
S. Maurizio e il S. Cristoforo; complessivamente
però, non può dirsi che questo polittico sia una delle
cose migliori di Defendente, benché dimostri una
innegabile scioltezza di tecnica; certo a lui si uni-
rono ne'la esecuzione collaboratori.
Né l'orizzonte artistico muta se dall'ancona
di S. Antonio di Kanverso passiamo al 5. Miche/e
Arcangelo e alla S. Caterina di Alessandria, spor-
telli corrispondenti di un trittico smembrato, e
alle due mezze figure di S. ìvone e di .S". Giovanni
Battista del Museo Civico di Torino, oppure a
5. Giovanni e S. Girolamo che presentano un donatore
e allo Sposalizio di S. Caterina della Pinacoteca
Torinese. Anche qui v'è bellezza di colori e ri-
cerca di forma e chiaroscuro, che non raggiun-
gono alcun effetto sintetico.
Migliori e più personali delle tavole sono le
predelle.
Nel polittico di Sant'Antonio di Kanverso lo
scomparto della Tentazione di S. Antonio of-
fre un esempio pregevolissimo di linearismo lu-
minoso: le forme dei corpi sono espresse da li-
neette dorate e per questo solo emergono dal
fondo, con cui s'accordano in maniera perfetta,
apparendo come luci dorate nell'ombra, fili al-
tri scomparti sono come luminismo inferiori a
questo, ma si conservano tuttavia gustosi per
alcuni particolari: negli uni macchiette scure su
sfondo chiaro, negli altri delicate forme di al-
beri contorte e sottili curve di giovani piante che
svettano alte, sbattimenti di luce su rocce e
case lontane. Nello ■< Sposalizio di S. Caterina »
notevolissimo per il punteggiare esasperato è lo
ANNA MARIA BRI ZIO
magini, che toglie loro l'astrattezza elegante, cosi
adatta al gusto decorativo di Defendente, senza
giungere ad una caratterizzazione vitale. S'in-
contrano spunti tonali nella predella e permane
ancora nella tavola una paziente e amorosa deter-
minazione degli ornati nei drappi e nelle vesti ed
una grande vivacità e lietezza nei rossi; ma la co-
lorazione, pur basandosi su una tavolozza bril-
lante, non riesce a fondersi, perchè non trova un
elemento unificatore. Nella Madonna di Carma-
gnola il pittore l'aveva trovato nell'intonazione
scura, unita, del fondo; altrove la trova nella chia-
rità del paesaggio, che pone in risalto le figure e
tutte le avvolge di egual luce.
Più compiutamente che in ogni altra tavola,
quest'equilibrio tra sfondo e figure a'I'aria aperta,
pari ai migliori esempi di scuola fiamminga, è
raggiunto in una magnifica 'Deposizione dell'Istituto
Professionale Quintino Sella di Biella, un'opera
proveniente da Co'lezione privata, rimasta finora
ignota. Essa nella produzione di Defendente rap-
presenta un'eccezione, non tanto per i caratteri
stilistici, (pianto per il profondo sentimento umano
che essa racchiude. In genere Defendente, ricco di
sensibilità esteriore, è indifferente nel fondo. Cui
invece ogni figura è, senza smorfie melodramma-
tiche o tragici contorcimenti, atteggiata ad una
raccolta e intensa pietà, che stupisce veder sor-
gere dall'animo superficia'e di questo mite pittore.
Nessun tormento e nessuna preziosità di stile
nessuna punteggiatura luministica e nessun li-
nearismo arcaico; ma una serenità piena di colore,
un disegno calmo e sicuro, un paesaggio aperto e
chiaro, che non contrasta freddo colla, colorazione
dell'avampiano, come quello della Crocifissione
del Museo Civico di Torino, ma si ridette sulle
tinte dei manti e delle carni. 11 gruppo intorno al
cadavere del Cristo è vigoroso ed equilibrato; e
nella forza della composizione e degli atteggiamenti
contrapposta alla bellezza del colore e alla felicità
dell'esecuzione, è raggiunta una lirica espressione
del dolore umano rasserenato dall'arte.
Ma per breve tempo Defendente sale a queste
altezze: ben presto torna al suo ritmo abituale; e
nella sua produzione s'alternano, tendendo ad
un generale oscuramento di colore, trittici armo-
niosamente decorativi, predelle rivelanti una ca-
pacità di prim'ordine di fissare col colore le im-
pressioni, vaste tavole dove lo sforzo di adeguare
il proprio stile al gusto del Kinascimento finisce,
insieme con la mano dei collaboratori, col disorga-
nizzare la sua visione artistica.
La maggior parte delle sue opere più conosciute
appartiene purtroppo a quest'ultima categoria
-— ed è questa una delle ragioni per cui egli è stato,
in genere, frainteso — a cominciare dal polittico
di S. Antonio di Kanverso del 153r, che fu stori-
camente il punto di partenza per la conoscenza
del Ferrari (fig. 19).
Al centro la Natività palesa evidente un desi-
derio di bellezza formale nella Madonna e un de-
siderio di prospettiva nello sfondo, che lo rende
assai più insignificante, perchè meno luministico,
di quelli di Susa ed Ivrea. In alto due mezze figure
di santi sono eseguite linearmente, con visione
arcaica, che ricorda il S. Maurizio della Pinacoteca
Torinese, appartenente a questi anni; ma le ri-
cerche formali e il colorito chiaroscurato riappaiono
nei due santi laterali inferiori e negli sportelli. In
questi ultimi è completa la disorganizza/ione
dell'arte di Defendente, per l'abbandono del prin
cipio tona'e e lineare senza il raggiungimento della
capacità costruttiva. Nel .S'. Girolamo il chiaro-
scuro del petto è assolutamente sbagliato; il gesto
melodrammatico e il drappeggio senza ritmo. Il
paesaggio non ha luce, le rocce sono squadrate e
i colori stridenti. l a scena poi del ,S'. Antonio e
S. Paole, a forme grossolane e tinte sbiadite, pare
eseguita da un imbianchino. Migliori appaiono il
S. Maurizio e il S. Cristoforo; complessivamente
però, non può dirsi che questo polittico sia una delle
cose migliori di Defendente, benché dimostri una
innegabile scioltezza di tecnica; certo a lui si uni-
rono ne'la esecuzione collaboratori.
Né l'orizzonte artistico muta se dall'ancona
di S. Antonio di Kanverso passiamo al 5. Miche/e
Arcangelo e alla S. Caterina di Alessandria, spor-
telli corrispondenti di un trittico smembrato, e
alle due mezze figure di S. ìvone e di .S". Giovanni
Battista del Museo Civico di Torino, oppure a
5. Giovanni e S. Girolamo che presentano un donatore
e allo Sposalizio di S. Caterina della Pinacoteca
Torinese. Anche qui v'è bellezza di colori e ri-
cerca di forma e chiaroscuro, che non raggiun-
gono alcun effetto sintetico.
Migliori e più personali delle tavole sono le
predelle.
Nel polittico di Sant'Antonio di Kanverso lo
scomparto della Tentazione di S. Antonio of-
fre un esempio pregevolissimo di linearismo lu-
minoso: le forme dei corpi sono espresse da li-
neette dorate e per questo solo emergono dal
fondo, con cui s'accordano in maniera perfetta,
apparendo come luci dorate nell'ombra, fili al-
tri scomparti sono come luminismo inferiori a
questo, ma si conservano tuttavia gustosi per
alcuni particolari: negli uni macchiette scure su
sfondo chiaro, negli altri delicate forme di al-
beri contorte e sottili curve di giovani piante che
svettano alte, sbattimenti di luce su rocce e
case lontane. Nello ■< Sposalizio di S. Caterina »
notevolissimo per il punteggiare esasperato è lo