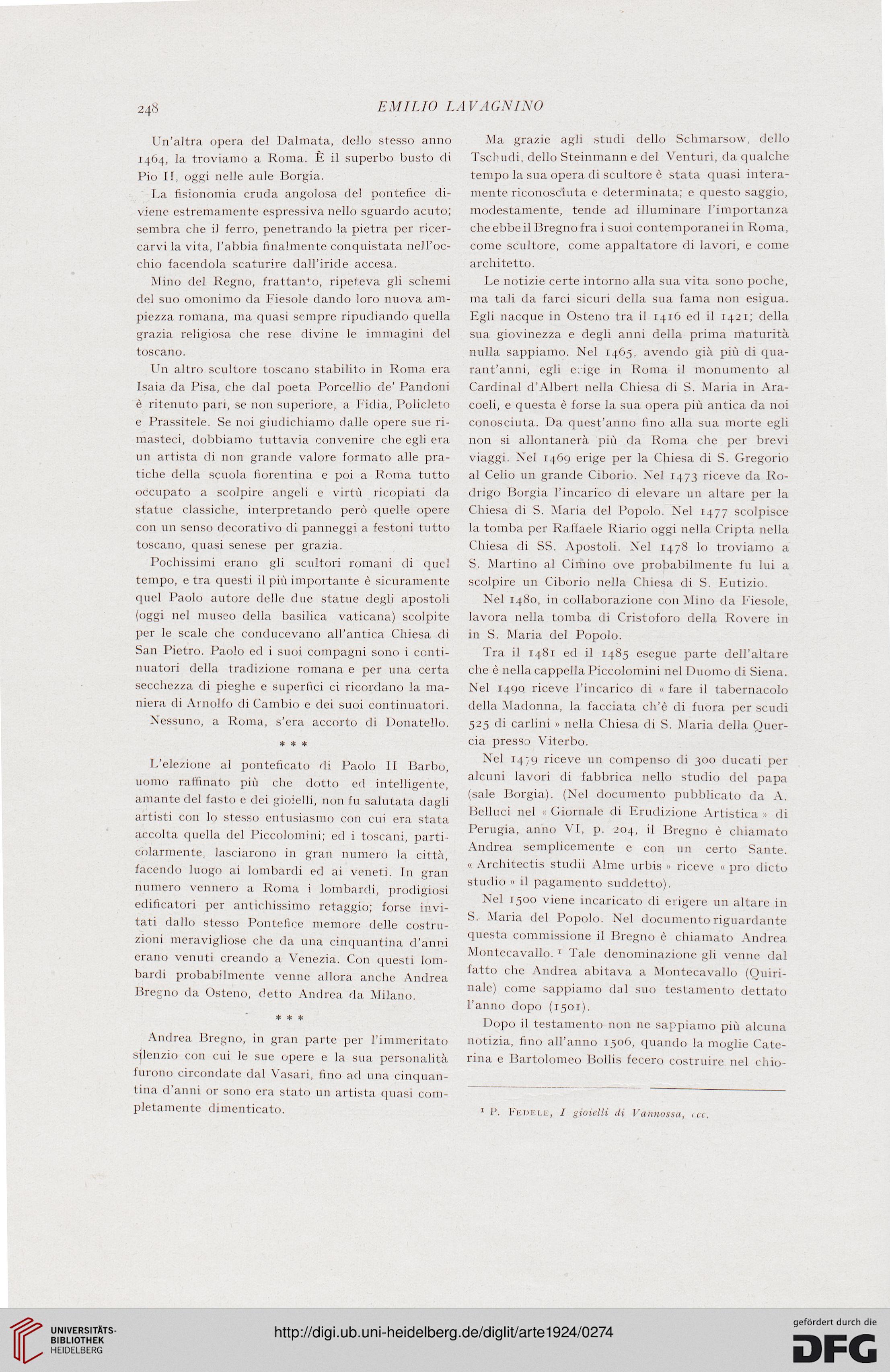24<S EMILIO L.
Un'altra opera del Dalmata, dello stesso anno
1464, la troviamo a Roma. È il superbo busto di
Pio II, oggi nelle aule Borgia.
I.a fisionomia cruda angolosa del pontefice di-
viene estremamente espressiva nello sguardo acuto;
sembra che il ferro, penetrando la pietra per ricer-
carvi la vita, l'abbia finalmente conquistata nell'oc-
chio facendola scaturire dall'iride accesa.
Mino del Regno, frattan+o, ripeteva gli schemi
dei suo omonimo da Fiesole dando loro nuova am-
piezza romana, ma quasi sempre ripudiando quella
grazia religiosa che rese divine le immagini del
toscano.
Un altro scultore toscano stabilito in Roma era
Isaia da Pisa, che dal poeta Porcellio de' Pandoni
è ritenuto pari, se non superiore, a Fidia, Policleto
e Prassitele. Se noi giudichiamo dalle opere sue ri-
masteci, dobbiamo tuttavia convenire che egli era
un artista di non grande valore formato alle pra-
tiche della scuola fiorentina e poi a Roma tutto
occupato a scolpire angeli e virtù ricopiati da
staine classiche, interpretando però quelle opere
con un senso decorativo di panneggi a festoni tutto
toscano, (piasi senese per grazia.
Pochissimi erano gli scultori romani di quel
tempo, e tra questi il più importante è sicuramente
quel Paolo autore delle due statue degli apostoli
(oggi nel museo della basilica vaticana) scolpite
per le scale che conducevano all'antica Chiesa di
San Pietro. Paolo ed i suoi compagni sono i conti-
nuatori della tradizione romana e per una certa
secchezza di pieghe e superfici ci ricordano la ma-
niera di Arnolfo di Cambio e dei suoi continuatori.
Nessuno, a Roma, s'era accorto di Donatello.
* * *
L'elezione al ponteficato di Paolo II Barbo,
uomo raffinato più che dotto ed intelligente,
amante del fasto e dei gioielli, non fu salutata dagli
artisti con lo stesso entusiasmo con cui era stata
accolta quella del Piccolomini; ed i toscani, parti-
colarmente, lasciarono in gran numero la città,
facendo luogo ai lombardi ed ai veneti. In gran
numero vennero a Roma i lombardi, prodigiosi
edificatori per antichissimo retaggio; forse invi-
tati dallo stesso Pontefice memore delle costru-
zioni meravigliose che da una cinquantina d'anni
erano venuti creando a Venezia. Con questi lom-
bardi probabilmente venne allora anche Andrea
Bregno da Osteno, detto Andrea da Milano.
* * *
Andrea Bregno, in gran parie per l'immeritato
silenzio con cui le sue opere e la sua personalità
furono circondate dal Vasari, fino ad una cinquan-
tina d'anni or sono era stato un artista quasi com-
pletamente dimenticato.
V AGNI NO
Ma grazie agli studi dello Schmarsow, dello
Tschudi, dello Steinmann e del Venturi, da qualche
tempo la sua opera di scultore è stata quasi intera-
mente riconosciuta e determinata; e questo saggio,
modestamente, tende ad illuminare l'importanza
che ebbe il Bregno fra i suoi contemporanei in Roma,
come scultore, come appaltatore di lavori, e come
architetto.
Le notizie certe intorno alla sua vita sono poche,
ma tali da farci sicuri della sua fama non esigua.
Kgli nacque in Osteno tra il 1416 ed il 1421; della
sua giovinezza e degli anni della prima maturità
nulla sappiamo. Nel 1465, avendo già più di qua-
rant'anni, egli e.ige in Roma il monumento al
Cardinal d'Albert nella Chiesa di S. Maria in Ara-
coeli, e questa è forse la sua opera più antica da noi
conosciuta. Da quest'anno fino alla sua morte egli
non si allontanerà più da Roma che per brevi
viaggi. Nel 1469 erige per la Chiesa di S. Gregorio
al Celio un grande Ciborio. Nel 1473 riceve da Ro-
drigo Borgia l'incarico di elevare un altare per la
( liiesa di S. Maria del Popolo. Nel 1477 scolpisce
la tomba per Raffaele Riario oggi nella Cripta nella
Chiesa di SS. Apostoli. Nel 1478 lo troviamo a
S. Martino al Cimino ove probabilmente fu lui a
scolpire un Ciborio nella Chiesa di S, Eutizio.
Nel 1480, in collaborazione con Mino da Fiesole,
lavora nella tomba di Cristoforo della Rovere in
in S. Maria del Popolo.
Tra il 1481 ed il 1485 esegue parte dell'altare
che è nella cappella Piccolomini nel Duomo di Siena.
Nel 1490 riceve l'incarico di « fare il tabernacolo
della Madonna, la facciata ch'è di lucra per scudi
525 di carlini » nella Chiesa di S. Maria della Quer-
cia presso Viterbo.
Nel 14^9 riceve un compenso di 300 ducati per
alcuni lavori di fabbrica nello studio del papa
(sale Borgia). (Nel documento pubblicato da A.
Delinei nel » Giornale di Erudizione Artistica » di
Perugia, anno VI, p. 204, il Bregno è chiamato
Andrea semplicemente e con un certo Sante.
« Architectis stridii Alme urbis » riceve « prò dicto
studio » il pagamento suddetto).
Nel 1500 viene incaricato di erigere un altare in
S. Maria del Popolo. Nel documento riguardante
questa commissione il Bregno è chiamato Andrea
Montecavallo. 1 Tale denominazione gli venne dal
fatto che Andrea abitava a Montecavallo (Quiri-
nale) come sappiamo dal suo testamento dettato
l'anno dopo (1501).
Dopo il testamento non ne sappiamo più alcuna
notizia, fino all'anno 150!), (piando la moglie Cate-
rina e Bartolomeo Bollis fecero costruire nel chio-
1 P, FciUELB, / gioielli ili Vannossa, ice.
Un'altra opera del Dalmata, dello stesso anno
1464, la troviamo a Roma. È il superbo busto di
Pio II, oggi nelle aule Borgia.
I.a fisionomia cruda angolosa del pontefice di-
viene estremamente espressiva nello sguardo acuto;
sembra che il ferro, penetrando la pietra per ricer-
carvi la vita, l'abbia finalmente conquistata nell'oc-
chio facendola scaturire dall'iride accesa.
Mino del Regno, frattan+o, ripeteva gli schemi
dei suo omonimo da Fiesole dando loro nuova am-
piezza romana, ma quasi sempre ripudiando quella
grazia religiosa che rese divine le immagini del
toscano.
Un altro scultore toscano stabilito in Roma era
Isaia da Pisa, che dal poeta Porcellio de' Pandoni
è ritenuto pari, se non superiore, a Fidia, Policleto
e Prassitele. Se noi giudichiamo dalle opere sue ri-
masteci, dobbiamo tuttavia convenire che egli era
un artista di non grande valore formato alle pra-
tiche della scuola fiorentina e poi a Roma tutto
occupato a scolpire angeli e virtù ricopiati da
staine classiche, interpretando però quelle opere
con un senso decorativo di panneggi a festoni tutto
toscano, (piasi senese per grazia.
Pochissimi erano gli scultori romani di quel
tempo, e tra questi il più importante è sicuramente
quel Paolo autore delle due statue degli apostoli
(oggi nel museo della basilica vaticana) scolpite
per le scale che conducevano all'antica Chiesa di
San Pietro. Paolo ed i suoi compagni sono i conti-
nuatori della tradizione romana e per una certa
secchezza di pieghe e superfici ci ricordano la ma-
niera di Arnolfo di Cambio e dei suoi continuatori.
Nessuno, a Roma, s'era accorto di Donatello.
* * *
L'elezione al ponteficato di Paolo II Barbo,
uomo raffinato più che dotto ed intelligente,
amante del fasto e dei gioielli, non fu salutata dagli
artisti con lo stesso entusiasmo con cui era stata
accolta quella del Piccolomini; ed i toscani, parti-
colarmente, lasciarono in gran numero la città,
facendo luogo ai lombardi ed ai veneti. In gran
numero vennero a Roma i lombardi, prodigiosi
edificatori per antichissimo retaggio; forse invi-
tati dallo stesso Pontefice memore delle costru-
zioni meravigliose che da una cinquantina d'anni
erano venuti creando a Venezia. Con questi lom-
bardi probabilmente venne allora anche Andrea
Bregno da Osteno, detto Andrea da Milano.
* * *
Andrea Bregno, in gran parie per l'immeritato
silenzio con cui le sue opere e la sua personalità
furono circondate dal Vasari, fino ad una cinquan-
tina d'anni or sono era stato un artista quasi com-
pletamente dimenticato.
V AGNI NO
Ma grazie agli studi dello Schmarsow, dello
Tschudi, dello Steinmann e del Venturi, da qualche
tempo la sua opera di scultore è stata quasi intera-
mente riconosciuta e determinata; e questo saggio,
modestamente, tende ad illuminare l'importanza
che ebbe il Bregno fra i suoi contemporanei in Roma,
come scultore, come appaltatore di lavori, e come
architetto.
Le notizie certe intorno alla sua vita sono poche,
ma tali da farci sicuri della sua fama non esigua.
Kgli nacque in Osteno tra il 1416 ed il 1421; della
sua giovinezza e degli anni della prima maturità
nulla sappiamo. Nel 1465, avendo già più di qua-
rant'anni, egli e.ige in Roma il monumento al
Cardinal d'Albert nella Chiesa di S. Maria in Ara-
coeli, e questa è forse la sua opera più antica da noi
conosciuta. Da quest'anno fino alla sua morte egli
non si allontanerà più da Roma che per brevi
viaggi. Nel 1469 erige per la Chiesa di S. Gregorio
al Celio un grande Ciborio. Nel 1473 riceve da Ro-
drigo Borgia l'incarico di elevare un altare per la
( liiesa di S. Maria del Popolo. Nel 1477 scolpisce
la tomba per Raffaele Riario oggi nella Cripta nella
Chiesa di SS. Apostoli. Nel 1478 lo troviamo a
S. Martino al Cimino ove probabilmente fu lui a
scolpire un Ciborio nella Chiesa di S, Eutizio.
Nel 1480, in collaborazione con Mino da Fiesole,
lavora nella tomba di Cristoforo della Rovere in
in S. Maria del Popolo.
Tra il 1481 ed il 1485 esegue parte dell'altare
che è nella cappella Piccolomini nel Duomo di Siena.
Nel 1490 riceve l'incarico di « fare il tabernacolo
della Madonna, la facciata ch'è di lucra per scudi
525 di carlini » nella Chiesa di S. Maria della Quer-
cia presso Viterbo.
Nel 14^9 riceve un compenso di 300 ducati per
alcuni lavori di fabbrica nello studio del papa
(sale Borgia). (Nel documento pubblicato da A.
Delinei nel » Giornale di Erudizione Artistica » di
Perugia, anno VI, p. 204, il Bregno è chiamato
Andrea semplicemente e con un certo Sante.
« Architectis stridii Alme urbis » riceve « prò dicto
studio » il pagamento suddetto).
Nel 1500 viene incaricato di erigere un altare in
S. Maria del Popolo. Nel documento riguardante
questa commissione il Bregno è chiamato Andrea
Montecavallo. 1 Tale denominazione gli venne dal
fatto che Andrea abitava a Montecavallo (Quiri-
nale) come sappiamo dal suo testamento dettato
l'anno dopo (1501).
Dopo il testamento non ne sappiamo più alcuna
notizia, fino all'anno 150!), (piando la moglie Cate-
rina e Bartolomeo Bollis fecero costruire nel chio-
1 P, FciUELB, / gioielli ili Vannossa, ice.