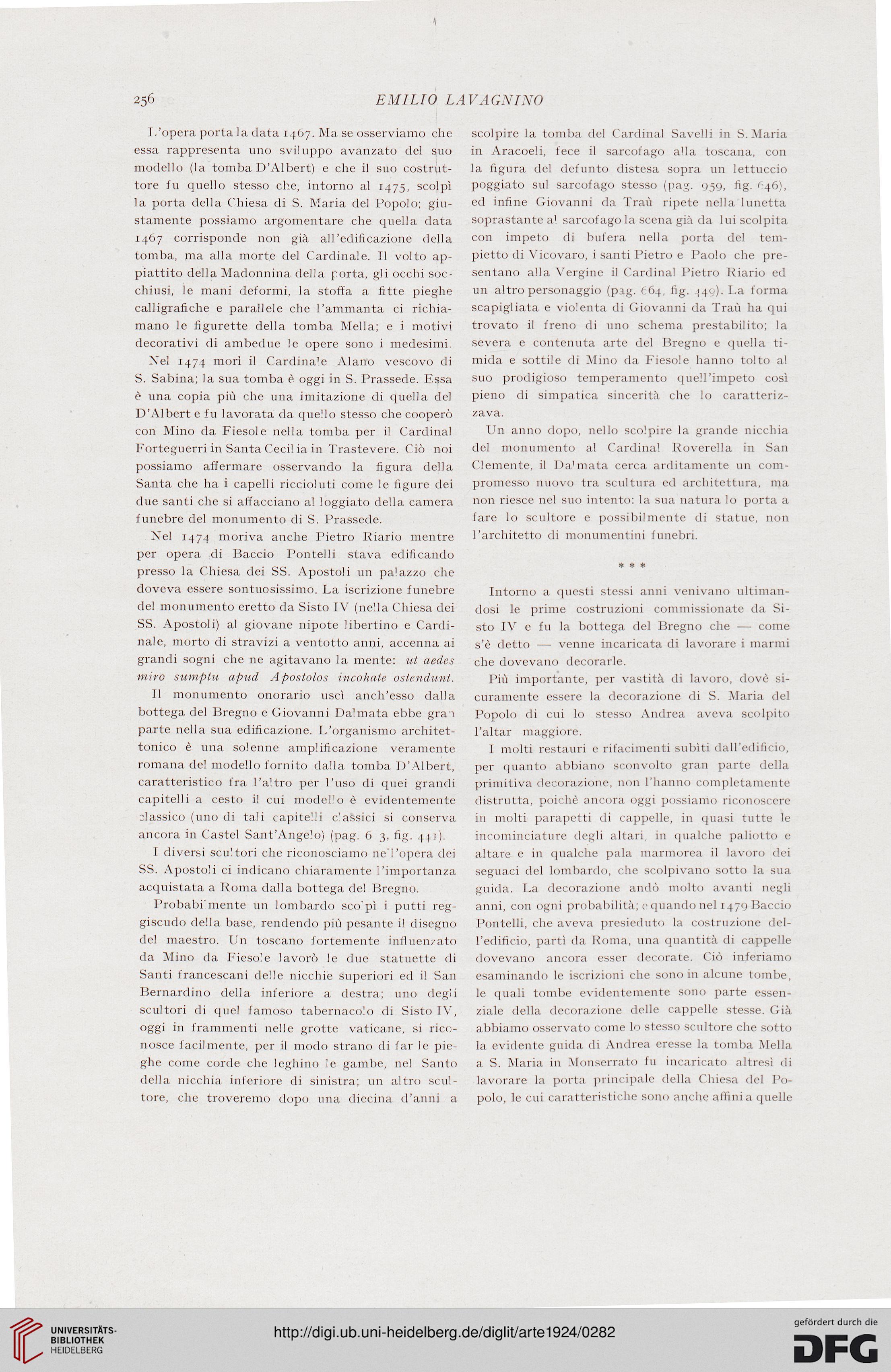EMILIO LAVAGNINO
256
L'opera porta la data 1467. Ma se osserviamo che
essa rappresenta uno sviluppo avanzato del suo
modello (la tomba D'Albert) e che il suo costrut-
tore fu quello stesso che, intorno al 1475, scolpì
la porta della Chiesa di S. Maria del Popolo; giu-
stamente possiamo argomentare che quella data
1467 corrisponde non già all'edificazione della
tomba, ma alla morte del Cardinale, fi volto ap-
piattito della Madonnina della porta, gli occhi soc-
chiusi, le mani deformi, la stoffa a fitte pieghe
calligrafiche e parallele che l'ammanta ci richia-
mano le figurette della tomba Mella; e i motivi
decorativi di ambedue le opere sono i medesimi.
Nel 1474 morì il Cardina'e Alano vescovo di
S. Sabina; la sua tomba è oggi in S. Prassede. Essa
è una copia più che una imitazione di quella del
D'Albert e fu lavorata da quello stesso che cooperò
con Mino da Fiesole nella tomba per il Cardinal
Forteguerri in Santa Cecil ia in Trastevere. Ciò noi
possiamo affermare osservando la figura della
Santa che ha i capelli riccioluti come le figure dei
due santi che si affacciano al loggiato della camera
funebre del monumento di S. Prassede.
Nel 1474 moriva anche Pietro Riario mentre
per opera di Baccio Pontelli stava edificando
presso la Chiesa dei SS. Apostoli un palazzo che
doveva essere sontuosissimo. La iscrizione funebre
del monumento eretto da Sisto IV (nella Chiesa dei
SS. Apostoli) al giovane nipote libertino e Cardi-
nale, morto di stravizi a ventotto anni, accenna ai
grandi sogni che ne agitavano la mente: ut aedes
miro sumptu apud Apostolos incollate ostendunt.
Il monumento onorario uscì anch'esso dalla
bottega del Bregno e Giovanni Dalmata ebbe grai
parte nella sua edificazione. L'organismo architet-
tonico è una solenne amplificazione veramente
romana del modello fornito dalla tomba D'Albert,
caratteristico fra l'altro per l'uso di quei grandi
capitelli a cesto il cui modello è evidentemente
classico (uno di tali capitelli c'assici si conserva
ancora in Castel Sant'Angelo) (pag. 6 3, fig. 441).
I diversi scultori che riconosciamo ne l'opera dei
SS. Apostoli ci indicano chiaramente l'importanza
acquistata a Roma dalla bottega del Bregno,
I'robabi'mente un lombardo sco'pì i putti reg-
giscudo della base, rendendo più pesante il disegno
del maestro. Un toscano fortemente influenzato
da Mino da Fiesole lavorò le due statuette di
Santi francescani delle nicchie superiori ed il San
Bernardino della inferiore a destra; uno degli
scultori di quel famoso tabernacolo di Sisto IV,
oggi in frammenti nelle grotte vaticane, si rico-
nosce facilmente, per il modo strano di far le pie-
ghe come corde che leghino le gambe, nel Santo
della nicchia inferiore di sinistra; un altro scul-
tore, che troveremo dopo una diecina d'anni a
scolpire la tomba del Cardinal Savelli in S. Maria
in Aracoeli, fece il sarcofago alla toscana, con
la figura del defunto distesa sopra un lettuccio
poggiato sul sarcofago stesso (pag. 059, fig- ''46),
ed infine Giovanni da Traù ripete nella lunetta
soprastante a' sarcofago la scena già da lui scolpita
con impeto di bufera nella porta del tem-
pietto di Vicovaro, i santi Pietro e Paolo che pre-
sentano alla Vergine il Cardinal Pietro Riario ed
un altro personaggio (pag. C64, fig. .(40). La forma
scapigliata e violenta di Giovanni da Traù ha qui
trovato il freno di uno schema prestabilito; la
severa e contenuta arte del Bregno e quella ti-
mida e sottile di Mino da Fiesole hanno tolto al
suo prodigioso temperamento ([nell'impeto così
pieno di simpatica sincerità che lo caratteriz-
zava.
Un anno dopo, nello scolpire la grande nicchia
del monumento al Cardinal Roverella in San
Clemente, il Da'mata cerca arditamente un com-
promesso nuovo tra scultura ed architettura, ma
non riesce nel suo intento; la sua natura lo porta a
fare lo scultore e possibilmente di statue, non
l'architetto di monumentini funebri.
* * *
Intorno a questi stessi anni venivano ultiman-
dosi le prime costruzioni commissionate da Si-
sto IV e fu la bottega del Bregno che — come
s'è detto — venne incaricata di lavorare i marmi
che dovevano decorarle.
Più importante, per vastità di lavoro, dovè si-
curamente essere la decorazione di S. Maria del
Popolo di cui lo stesso Andrea aveva scolpito
l'aitar maggiore.
I molti restauri e rifacimenti subiti dall'edificio,
per quanto abbiano sconvolto gran parte della
primitiva decorazione, non l'hanno completamente
distrutta, poiché ancora oggi possiamo riconoscere
in molti parapetti di cappelle, in quasi tutte le
incominciature degli altari, in qualche paliotto e
altare e in qualche pala marmorea il lavoro dei
seguaci del lombardo, che scolpivano sotto la sua
guida, ha decorazione andò molto avanti negli
anni, con ogni probabilità; e quando nel 1 470 Baccio
Pontelli, che aveva presieduto la costruzione del-
l'edificio, partì da Roma, una quantità di cappelle
dovevano ancora esser decorate. Ciò inferiamo
esaminando le iscrizioni che sono in alcune tombe,
le quali tombe evidentemente sono parte essen-
ziale della decorazione delle cappelle stesse. Già
abbiamo osservato come lo stesso scultore che sotto
la evidente guida di Andrea eresse la tomba Mella
a S. Maria in Monserrato fu incaricato altresì di
lavorare la porta principale della Chiesa del Po-
polo, le cui caratteristiche sono anche affini a quelle
256
L'opera porta la data 1467. Ma se osserviamo che
essa rappresenta uno sviluppo avanzato del suo
modello (la tomba D'Albert) e che il suo costrut-
tore fu quello stesso che, intorno al 1475, scolpì
la porta della Chiesa di S. Maria del Popolo; giu-
stamente possiamo argomentare che quella data
1467 corrisponde non già all'edificazione della
tomba, ma alla morte del Cardinale, fi volto ap-
piattito della Madonnina della porta, gli occhi soc-
chiusi, le mani deformi, la stoffa a fitte pieghe
calligrafiche e parallele che l'ammanta ci richia-
mano le figurette della tomba Mella; e i motivi
decorativi di ambedue le opere sono i medesimi.
Nel 1474 morì il Cardina'e Alano vescovo di
S. Sabina; la sua tomba è oggi in S. Prassede. Essa
è una copia più che una imitazione di quella del
D'Albert e fu lavorata da quello stesso che cooperò
con Mino da Fiesole nella tomba per il Cardinal
Forteguerri in Santa Cecil ia in Trastevere. Ciò noi
possiamo affermare osservando la figura della
Santa che ha i capelli riccioluti come le figure dei
due santi che si affacciano al loggiato della camera
funebre del monumento di S. Prassede.
Nel 1474 moriva anche Pietro Riario mentre
per opera di Baccio Pontelli stava edificando
presso la Chiesa dei SS. Apostoli un palazzo che
doveva essere sontuosissimo. La iscrizione funebre
del monumento eretto da Sisto IV (nella Chiesa dei
SS. Apostoli) al giovane nipote libertino e Cardi-
nale, morto di stravizi a ventotto anni, accenna ai
grandi sogni che ne agitavano la mente: ut aedes
miro sumptu apud Apostolos incollate ostendunt.
Il monumento onorario uscì anch'esso dalla
bottega del Bregno e Giovanni Dalmata ebbe grai
parte nella sua edificazione. L'organismo architet-
tonico è una solenne amplificazione veramente
romana del modello fornito dalla tomba D'Albert,
caratteristico fra l'altro per l'uso di quei grandi
capitelli a cesto il cui modello è evidentemente
classico (uno di tali capitelli c'assici si conserva
ancora in Castel Sant'Angelo) (pag. 6 3, fig. 441).
I diversi scultori che riconosciamo ne l'opera dei
SS. Apostoli ci indicano chiaramente l'importanza
acquistata a Roma dalla bottega del Bregno,
I'robabi'mente un lombardo sco'pì i putti reg-
giscudo della base, rendendo più pesante il disegno
del maestro. Un toscano fortemente influenzato
da Mino da Fiesole lavorò le due statuette di
Santi francescani delle nicchie superiori ed il San
Bernardino della inferiore a destra; uno degli
scultori di quel famoso tabernacolo di Sisto IV,
oggi in frammenti nelle grotte vaticane, si rico-
nosce facilmente, per il modo strano di far le pie-
ghe come corde che leghino le gambe, nel Santo
della nicchia inferiore di sinistra; un altro scul-
tore, che troveremo dopo una diecina d'anni a
scolpire la tomba del Cardinal Savelli in S. Maria
in Aracoeli, fece il sarcofago alla toscana, con
la figura del defunto distesa sopra un lettuccio
poggiato sul sarcofago stesso (pag. 059, fig- ''46),
ed infine Giovanni da Traù ripete nella lunetta
soprastante a' sarcofago la scena già da lui scolpita
con impeto di bufera nella porta del tem-
pietto di Vicovaro, i santi Pietro e Paolo che pre-
sentano alla Vergine il Cardinal Pietro Riario ed
un altro personaggio (pag. C64, fig. .(40). La forma
scapigliata e violenta di Giovanni da Traù ha qui
trovato il freno di uno schema prestabilito; la
severa e contenuta arte del Bregno e quella ti-
mida e sottile di Mino da Fiesole hanno tolto al
suo prodigioso temperamento ([nell'impeto così
pieno di simpatica sincerità che lo caratteriz-
zava.
Un anno dopo, nello scolpire la grande nicchia
del monumento al Cardinal Roverella in San
Clemente, il Da'mata cerca arditamente un com-
promesso nuovo tra scultura ed architettura, ma
non riesce nel suo intento; la sua natura lo porta a
fare lo scultore e possibilmente di statue, non
l'architetto di monumentini funebri.
* * *
Intorno a questi stessi anni venivano ultiman-
dosi le prime costruzioni commissionate da Si-
sto IV e fu la bottega del Bregno che — come
s'è detto — venne incaricata di lavorare i marmi
che dovevano decorarle.
Più importante, per vastità di lavoro, dovè si-
curamente essere la decorazione di S. Maria del
Popolo di cui lo stesso Andrea aveva scolpito
l'aitar maggiore.
I molti restauri e rifacimenti subiti dall'edificio,
per quanto abbiano sconvolto gran parte della
primitiva decorazione, non l'hanno completamente
distrutta, poiché ancora oggi possiamo riconoscere
in molti parapetti di cappelle, in quasi tutte le
incominciature degli altari, in qualche paliotto e
altare e in qualche pala marmorea il lavoro dei
seguaci del lombardo, che scolpivano sotto la sua
guida, ha decorazione andò molto avanti negli
anni, con ogni probabilità; e quando nel 1 470 Baccio
Pontelli, che aveva presieduto la costruzione del-
l'edificio, partì da Roma, una quantità di cappelle
dovevano ancora esser decorate. Ciò inferiamo
esaminando le iscrizioni che sono in alcune tombe,
le quali tombe evidentemente sono parte essen-
ziale della decorazione delle cappelle stesse. Già
abbiamo osservato come lo stesso scultore che sotto
la evidente guida di Andrea eresse la tomba Mella
a S. Maria in Monserrato fu incaricato altresì di
lavorare la porta principale della Chiesa del Po-
polo, le cui caratteristiche sono anche affini a quelle