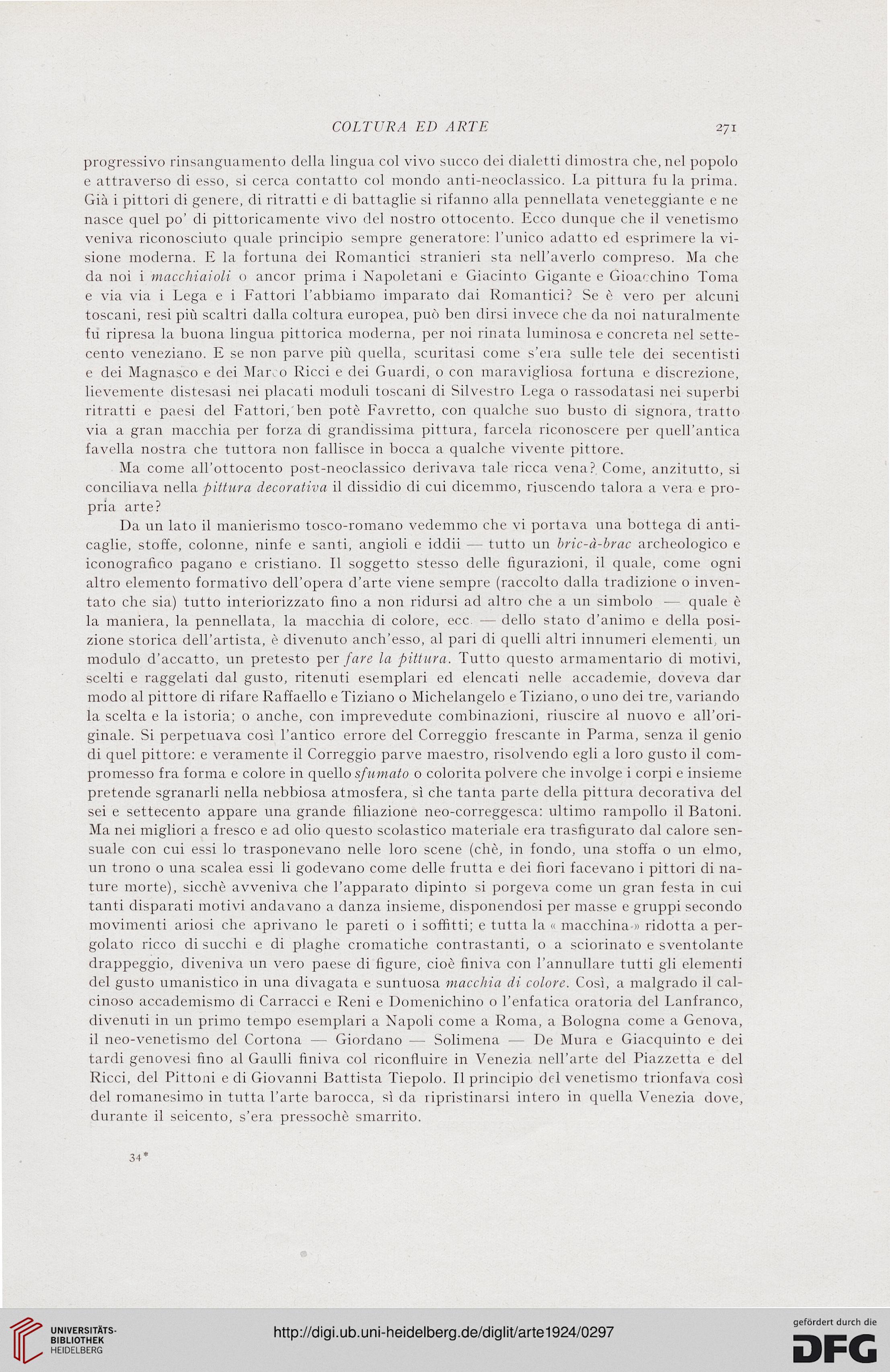COLTURA ED ARTE
271
progressivo rinsanguamento della lingua col vivo succo dei dialetti dimostra che, nel popolo
e attraverso di esso, si cerca contatto col mondo anti-neoclassico. La pittura fu la prima.
Già i pittori di genere, di ritratti e di battaglie si rifanno alla pennellata veneteggiante e ne
nasce quel po' di pittoricamente vivo del nostro ottocento. Ecco dunque che il venetismo
veniva riconosciuto quale principio sempre generatore: l'unico adatto ed esprimere la vi-
sione moderna. E la fortuna dei Romantici stranieri sta nell'averlo compreso. Ma che
da noi i macchiaioli o ancor prima i Napoletani e Giacinto Gigante e Gioacchino Toma
e via via i Lega e i Fattori l'abbiamo imparato dai Romantici? Se è vero per alcuni
toscani, resi più scaltri dalla coltura europea, può ben dirsi invece che da noi naturalmente
fu ripresa la buona lingua pittorica moderna, per noi rinata luminosa e concreta nel sette-
cento veneziano. E se non parve più quella, scuritasi come s'era sulle tele dei secentisti
e dei Magnasco e dei Mano Ricci e dei Guardi, o con maravigliosa fortuna e discrezione,
lievemente distesasi nei placati moduli toscani di Silvestro Lega o rassodatasi nei superbi
ritratti e paesi del Fattori, ben potè Favretto, con qualche suo busto di signora, tratto
via a gran macchia per forza di grandissima pittura, farcela riconoscere per quell'antica
favella nostra che tuttora non fallisce in bocca a qualche vivente pittore.
Ma come all'ottocento post-neoclassico derivava tale ricca vena?. Come, anzitutto, si
conciliava nella pittura decorativa il dissidio di cui dicemmo, riuscendo talora a vera e pro-
pria arte?
Da un lato il manierismo tosco-romano vedemmo che vi portava una bottega di anti-
caglie, stoffe, colonne, ninfe e santi, angioli e iddii — tutto un bric-à-brac archeologico e
iconografico pagano e cristiano. Il soggetto stesso delle figurazioni, il quale, come ogni
altro elemento formativo dell'opera d'arte viene sempre (raccolto dalla tradizione o inven-
tato che sia) tutto interiorizzato fino a non ridursi ad altro che a un simbolo — quale è
la maniera, la pennellata, la macchia di colore, ecc. — dello stato d'animo e della posi-
zione storica dell'artista, è divenuto anch'esso, al pari di quelli altri innumeri elementi, un
modulo d'accatto, un pretesto per fare la pittura. Tutto questo armamentario di motivi,
scelti e raggelati dal gusto, ritenuti esemplari ed elencati nelle accademie, doveva dar
modo al pittore di rifare Raffaello e Tiziano o Michelangelo e Tiziano, o uno dei tre, variando
la scelta e la istoria; o anche, con imprevedute combinazioni, riuscire al nuovo e all'ori-
ginale. Si perpetuava così l'antico errore del Correggio frescante in Parma, senza il genio
di quel pittore: e veramente il Correggio parve maestro, risolvendo egli a loro gusto il com-
promesso fra forma e colore in quello sfumato o colorita polvere che involge i corpi e insieme
pretende sgranarli nella nebbiosa atmosfera, sì che tanta parte della pittura decorativa del
sei e settecento appare una grande filiazione neo-correggesca: ultimo rampollo il Batoni.
Ma nei migliori a fresco e ad olio questo scolastico materiale era trasfigurato dal calore sen-
suale con cui essi lo trasponevano nelle loro scene (che, in fondo, una stoffa o un elmo,
un trono o una scalea essi li godevano come delle frutta e dei fiori facevano i pittori di na-
ture morte), sicché avveniva che l'apparato dipinto si porgeva come un gran festa in cui
tanti disparati motivi andavano a danza insieme, disponendosi per masse e gruppi secondo
movimenti ariosi che aprivano le pareti o i soffitti; e tutta la « macchina » ridotta a per-
golato ricco di succhi e di plaghe cromatiche contrastanti, o a sciorinato e sventolante
drappeggio, diveniva un vero paese di figure, cioè finiva con l'annullare tutti gli elementi
del gusto umanistico in una divagata e suntuosa macchia di colore. Così, a malgrado il cal-
cinoso accademismo di Carracci e Reni e Domenichino o l'enfatica oratoria del Lanfranco,
divenuti in un primo tempo esemplari a Napoli come a Roma, a Bologna come a Genova,
il neo-venetismo del Cortona — Giordano — Solimena - - De Mura e Giacquinto e dei
tardi genovesi fino al Gaudi finiva col riconfluire in Venezia nell'arte del Piazzetta e del
Ricci, del Pittoni e di Giovanni Battista Tiepolo. Il principio del venetismo trionfava così
del romanesimo in tutta l'arte barocca, sì da ripristinarsi intero in quella Venezia dove,
durante il seicento, s'era pressoché smarrito.
34*
271
progressivo rinsanguamento della lingua col vivo succo dei dialetti dimostra che, nel popolo
e attraverso di esso, si cerca contatto col mondo anti-neoclassico. La pittura fu la prima.
Già i pittori di genere, di ritratti e di battaglie si rifanno alla pennellata veneteggiante e ne
nasce quel po' di pittoricamente vivo del nostro ottocento. Ecco dunque che il venetismo
veniva riconosciuto quale principio sempre generatore: l'unico adatto ed esprimere la vi-
sione moderna. E la fortuna dei Romantici stranieri sta nell'averlo compreso. Ma che
da noi i macchiaioli o ancor prima i Napoletani e Giacinto Gigante e Gioacchino Toma
e via via i Lega e i Fattori l'abbiamo imparato dai Romantici? Se è vero per alcuni
toscani, resi più scaltri dalla coltura europea, può ben dirsi invece che da noi naturalmente
fu ripresa la buona lingua pittorica moderna, per noi rinata luminosa e concreta nel sette-
cento veneziano. E se non parve più quella, scuritasi come s'era sulle tele dei secentisti
e dei Magnasco e dei Mano Ricci e dei Guardi, o con maravigliosa fortuna e discrezione,
lievemente distesasi nei placati moduli toscani di Silvestro Lega o rassodatasi nei superbi
ritratti e paesi del Fattori, ben potè Favretto, con qualche suo busto di signora, tratto
via a gran macchia per forza di grandissima pittura, farcela riconoscere per quell'antica
favella nostra che tuttora non fallisce in bocca a qualche vivente pittore.
Ma come all'ottocento post-neoclassico derivava tale ricca vena?. Come, anzitutto, si
conciliava nella pittura decorativa il dissidio di cui dicemmo, riuscendo talora a vera e pro-
pria arte?
Da un lato il manierismo tosco-romano vedemmo che vi portava una bottega di anti-
caglie, stoffe, colonne, ninfe e santi, angioli e iddii — tutto un bric-à-brac archeologico e
iconografico pagano e cristiano. Il soggetto stesso delle figurazioni, il quale, come ogni
altro elemento formativo dell'opera d'arte viene sempre (raccolto dalla tradizione o inven-
tato che sia) tutto interiorizzato fino a non ridursi ad altro che a un simbolo — quale è
la maniera, la pennellata, la macchia di colore, ecc. — dello stato d'animo e della posi-
zione storica dell'artista, è divenuto anch'esso, al pari di quelli altri innumeri elementi, un
modulo d'accatto, un pretesto per fare la pittura. Tutto questo armamentario di motivi,
scelti e raggelati dal gusto, ritenuti esemplari ed elencati nelle accademie, doveva dar
modo al pittore di rifare Raffaello e Tiziano o Michelangelo e Tiziano, o uno dei tre, variando
la scelta e la istoria; o anche, con imprevedute combinazioni, riuscire al nuovo e all'ori-
ginale. Si perpetuava così l'antico errore del Correggio frescante in Parma, senza il genio
di quel pittore: e veramente il Correggio parve maestro, risolvendo egli a loro gusto il com-
promesso fra forma e colore in quello sfumato o colorita polvere che involge i corpi e insieme
pretende sgranarli nella nebbiosa atmosfera, sì che tanta parte della pittura decorativa del
sei e settecento appare una grande filiazione neo-correggesca: ultimo rampollo il Batoni.
Ma nei migliori a fresco e ad olio questo scolastico materiale era trasfigurato dal calore sen-
suale con cui essi lo trasponevano nelle loro scene (che, in fondo, una stoffa o un elmo,
un trono o una scalea essi li godevano come delle frutta e dei fiori facevano i pittori di na-
ture morte), sicché avveniva che l'apparato dipinto si porgeva come un gran festa in cui
tanti disparati motivi andavano a danza insieme, disponendosi per masse e gruppi secondo
movimenti ariosi che aprivano le pareti o i soffitti; e tutta la « macchina » ridotta a per-
golato ricco di succhi e di plaghe cromatiche contrastanti, o a sciorinato e sventolante
drappeggio, diveniva un vero paese di figure, cioè finiva con l'annullare tutti gli elementi
del gusto umanistico in una divagata e suntuosa macchia di colore. Così, a malgrado il cal-
cinoso accademismo di Carracci e Reni e Domenichino o l'enfatica oratoria del Lanfranco,
divenuti in un primo tempo esemplari a Napoli come a Roma, a Bologna come a Genova,
il neo-venetismo del Cortona — Giordano — Solimena - - De Mura e Giacquinto e dei
tardi genovesi fino al Gaudi finiva col riconfluire in Venezia nell'arte del Piazzetta e del
Ricci, del Pittoni e di Giovanni Battista Tiepolo. Il principio del venetismo trionfava così
del romanesimo in tutta l'arte barocca, sì da ripristinarsi intero in quella Venezia dove,
durante il seicento, s'era pressoché smarrito.
34*