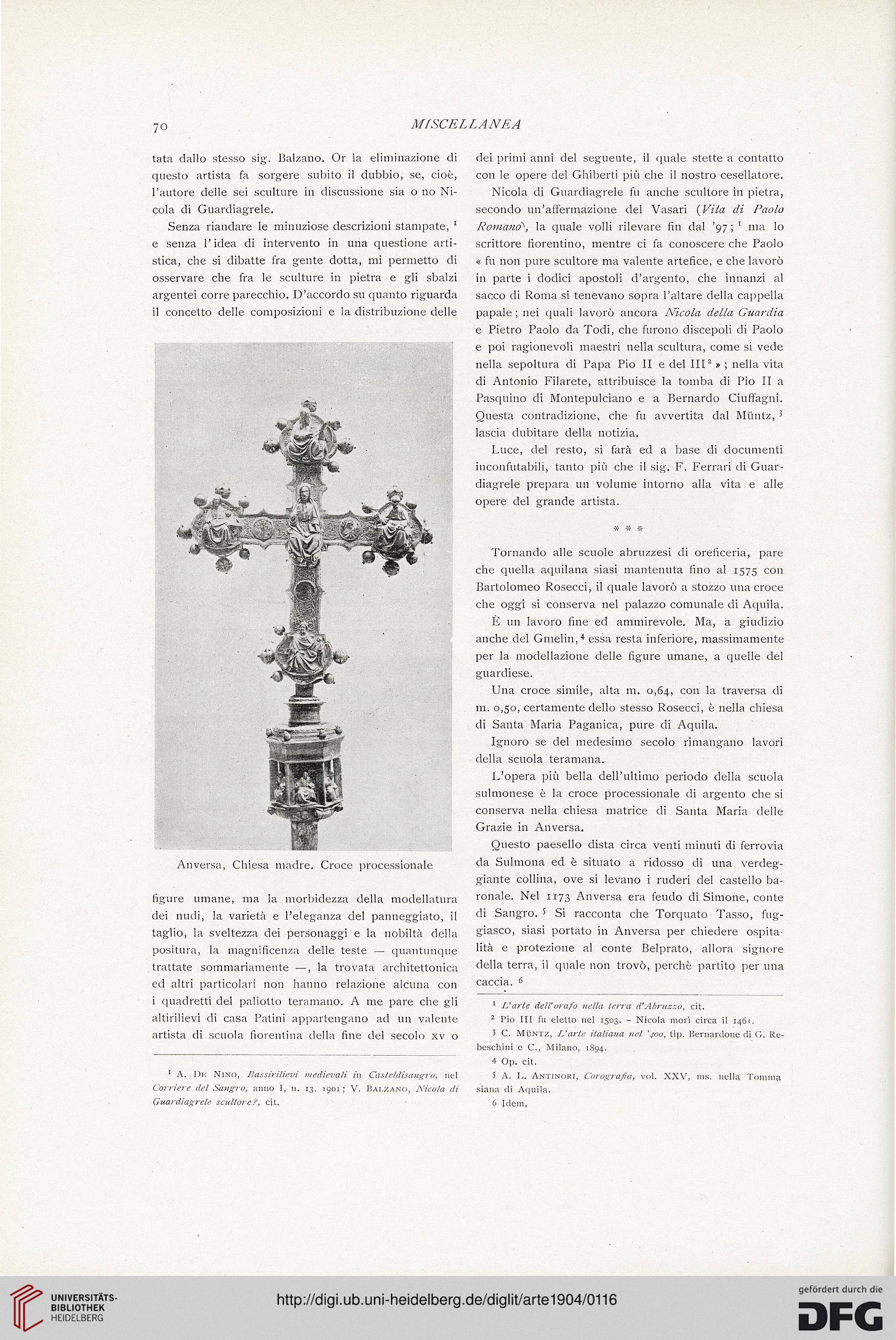70
MISCELLANEA
tata dallo stesso sig. Balzano. Or la eliminazione di
questo artista fa sorgere subito il dubbio, se, cioè,
l’autore delle sei sculture in discussione sia o no Ni-
cola di Guardiagrele.
Senza riandare le minuziose descrizioni stampate, 1 1
e senza l’idea di intervento in una questione arti-
stica, che si dibatte fra gente dotta, mi permetto di
osservare che fra le sculture in pietra e gli sbalzi
argentei corre parecchio. D’accordo su quanto riguarda
il concetto delle composizioni e la distribuzione delle
Anversa, Chiesa madre. Croce processionale
figure umane, ma la morbidezza della modellatura
dei nudi, la varietà e l’eleganza del panneggiato, il
taglio, la sveltezza dei personaggi e la nobiltà della
positura, la magnificenza delle teste — quantunque
trattate sommariamente —, la trovata architettonica
ed altri particolari non hanno relazione alcuna con
i quadretti del paliotto teramano. A me pare che gli
altirilievi di casa Patini appartengano ad un valente
artista di scuola fiorentina della fine del secolo xv o
1 A. ])k Nino, Jtassirilievi medievali in Casteldisangvo, nel
Corriere del Sangro, anno I, il. 13, 1901; V. Balzano, Nicola di
Guardiagrele scultore f, cit,
dei primi anni del seguente, il quale stette a contatto
con le opere del Ghiberti più che il nostro cesellatore.
Nicola di Guardiagrele fu anche scultore in pietra,
secondo un’affermazione del Vasari (Vita di Paolo
Romano\ la quale volli rilevare fin dal '97 ; 1 ma lo
scrittore fiorentino, mentre ci fa conoscere che Paolo
« fu non pure scultore ma valente artefice, e che lavorò
in parte i dodici apostoli d’argento, che innanzi al
sacco di Roma si tenevano sopra l’altare della cappella
papale; nei quali lavorò ancora Nicola della Guardia
e Pietro Paolo da Todi, che furono discepoli di Paolo
e poi ragionevoli maestri nella scultura, come si vede
nella sepoltura di Papa Pio II e del III2 » ; nella vita
di Antonio Filarete, attribuisce la tomba di Pio II a
Pasquino di Montepulciano e a Bernardo Ciuffagni.
Questa contradizione, che fu avvertita dal Muntz, 3
lascia dubitare della notizia.
Luce, del resto, si farà ed a base di documenti
inconfutabili, tanto più che il sig. F. Ferrari di Guar-
diagrele prepara un volume intorno alla vita e alle
opere del grande artista.
* * *
Tornando alle scuole abruzzesi di oreficeria, pare
che quella aquilana siasi mantenuta fino al 1575 con
Bartolomeo Rosecci, il quale lavorò a stozzo una croce
che oggi si conserva nel palazzo comunale di Aquila.
È un lavoro fine ed ammirevole. Ma, a giudizio
anche del Gmelin,4essa resta inferiore, massimamente
per la modellazione delle figure umane, a quelle del
guardiese.
Una croce simile, alta m. 0,64, con la traversa di
m. 0,50, certamente dello stesso Rosecci, è nella chiesa
di Santa Maria Paganica, pure di Aquila.
Ignoro se del medesimo secolo rimangano lavori
della scuola teramana.
L’opera più bella dell’ultimo periodo della scuola
sulmonese è la croce processionale di argento che si
conserva nella chiesa matrice di Santa Maria delle
Grazie in Anversa.
Questo paesello dista circa venti minuti di ferrovia
da Sulmona ed è situato à ridosso di una verdeg-
giante collina, ove si levano i ruderi del castello ba-
ronale. Nel 1173 Anversa era feudo di Simone, conte
di Sangro. 5 Si racconta che Torquato Tasso, fug-
giasco, siasi portato in Anversa per chiedere ospita-
lità e protezione al conte Belprato, allora signore
della terra, il quale non trovò, perchè partito per una
caccia. 6
1 L'arte dell'orafo nella terra d'Abruzzo, cit.
2 Pio III fu eletto nel 1503. - Nicola morì circa il 1461.
3 C. Muntz, L’arte italiana nel '400, tip. Bernardone di G. Re-
beschini e C., Milano, 1894.
4 Op. cit.
5 A. L. Antinori, Corografia, voi. XXV, ms. nella Tomma
siana di Aquila.
6 Idem,
MISCELLANEA
tata dallo stesso sig. Balzano. Or la eliminazione di
questo artista fa sorgere subito il dubbio, se, cioè,
l’autore delle sei sculture in discussione sia o no Ni-
cola di Guardiagrele.
Senza riandare le minuziose descrizioni stampate, 1 1
e senza l’idea di intervento in una questione arti-
stica, che si dibatte fra gente dotta, mi permetto di
osservare che fra le sculture in pietra e gli sbalzi
argentei corre parecchio. D’accordo su quanto riguarda
il concetto delle composizioni e la distribuzione delle
Anversa, Chiesa madre. Croce processionale
figure umane, ma la morbidezza della modellatura
dei nudi, la varietà e l’eleganza del panneggiato, il
taglio, la sveltezza dei personaggi e la nobiltà della
positura, la magnificenza delle teste — quantunque
trattate sommariamente —, la trovata architettonica
ed altri particolari non hanno relazione alcuna con
i quadretti del paliotto teramano. A me pare che gli
altirilievi di casa Patini appartengano ad un valente
artista di scuola fiorentina della fine del secolo xv o
1 A. ])k Nino, Jtassirilievi medievali in Casteldisangvo, nel
Corriere del Sangro, anno I, il. 13, 1901; V. Balzano, Nicola di
Guardiagrele scultore f, cit,
dei primi anni del seguente, il quale stette a contatto
con le opere del Ghiberti più che il nostro cesellatore.
Nicola di Guardiagrele fu anche scultore in pietra,
secondo un’affermazione del Vasari (Vita di Paolo
Romano\ la quale volli rilevare fin dal '97 ; 1 ma lo
scrittore fiorentino, mentre ci fa conoscere che Paolo
« fu non pure scultore ma valente artefice, e che lavorò
in parte i dodici apostoli d’argento, che innanzi al
sacco di Roma si tenevano sopra l’altare della cappella
papale; nei quali lavorò ancora Nicola della Guardia
e Pietro Paolo da Todi, che furono discepoli di Paolo
e poi ragionevoli maestri nella scultura, come si vede
nella sepoltura di Papa Pio II e del III2 » ; nella vita
di Antonio Filarete, attribuisce la tomba di Pio II a
Pasquino di Montepulciano e a Bernardo Ciuffagni.
Questa contradizione, che fu avvertita dal Muntz, 3
lascia dubitare della notizia.
Luce, del resto, si farà ed a base di documenti
inconfutabili, tanto più che il sig. F. Ferrari di Guar-
diagrele prepara un volume intorno alla vita e alle
opere del grande artista.
* * *
Tornando alle scuole abruzzesi di oreficeria, pare
che quella aquilana siasi mantenuta fino al 1575 con
Bartolomeo Rosecci, il quale lavorò a stozzo una croce
che oggi si conserva nel palazzo comunale di Aquila.
È un lavoro fine ed ammirevole. Ma, a giudizio
anche del Gmelin,4essa resta inferiore, massimamente
per la modellazione delle figure umane, a quelle del
guardiese.
Una croce simile, alta m. 0,64, con la traversa di
m. 0,50, certamente dello stesso Rosecci, è nella chiesa
di Santa Maria Paganica, pure di Aquila.
Ignoro se del medesimo secolo rimangano lavori
della scuola teramana.
L’opera più bella dell’ultimo periodo della scuola
sulmonese è la croce processionale di argento che si
conserva nella chiesa matrice di Santa Maria delle
Grazie in Anversa.
Questo paesello dista circa venti minuti di ferrovia
da Sulmona ed è situato à ridosso di una verdeg-
giante collina, ove si levano i ruderi del castello ba-
ronale. Nel 1173 Anversa era feudo di Simone, conte
di Sangro. 5 Si racconta che Torquato Tasso, fug-
giasco, siasi portato in Anversa per chiedere ospita-
lità e protezione al conte Belprato, allora signore
della terra, il quale non trovò, perchè partito per una
caccia. 6
1 L'arte dell'orafo nella terra d'Abruzzo, cit.
2 Pio III fu eletto nel 1503. - Nicola morì circa il 1461.
3 C. Muntz, L’arte italiana nel '400, tip. Bernardone di G. Re-
beschini e C., Milano, 1894.
4 Op. cit.
5 A. L. Antinori, Corografia, voi. XXV, ms. nella Tomma
siana di Aquila.
6 Idem,