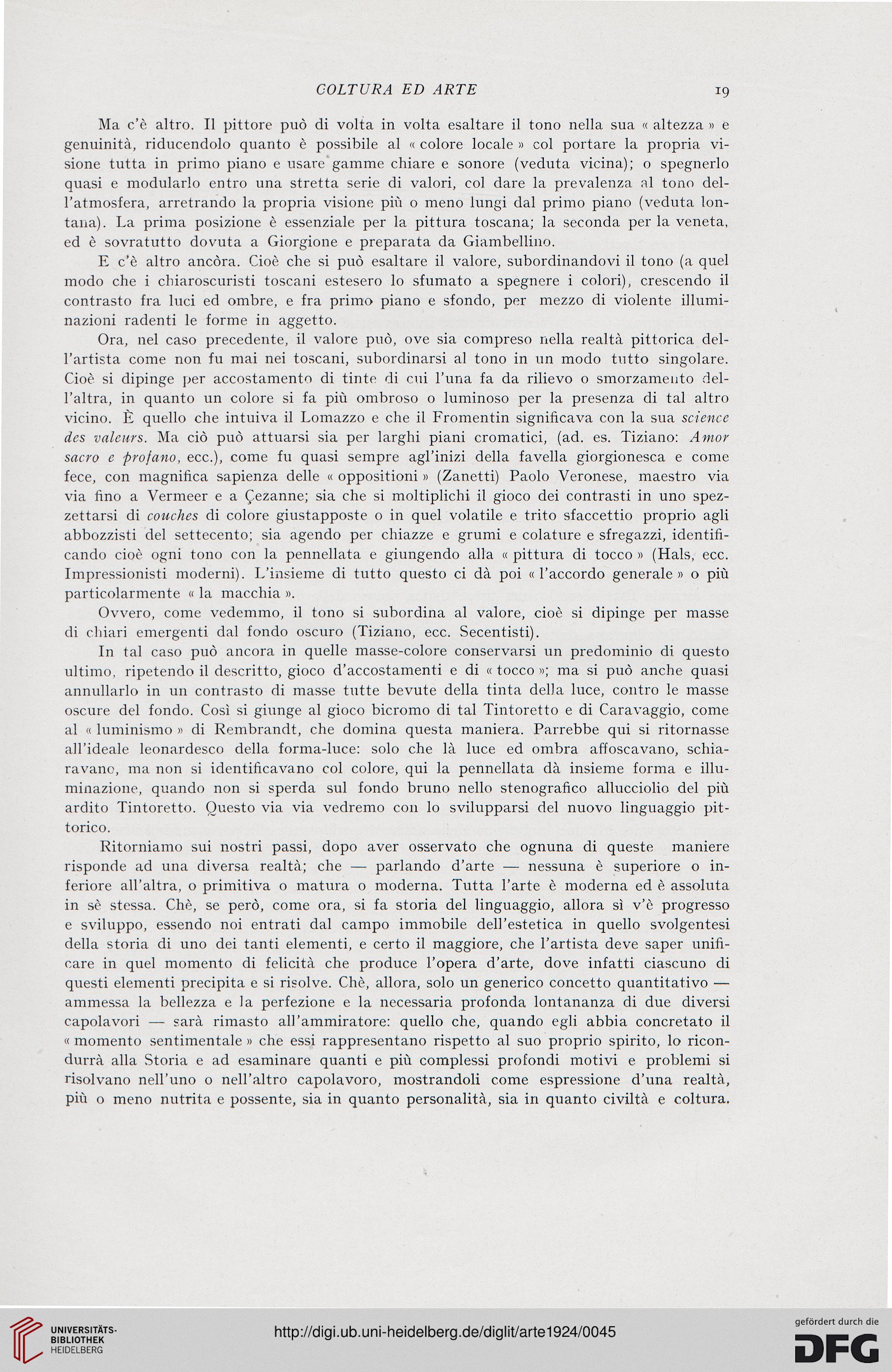COLTURA ED ARTE
tg
Ma c'è altro. Il pittore può di volta in volta esaltare il tono nella sua « altezza » e
genuinità, riducendolo quanto è possibile al « colore locale » col portare la propria vi-
sione tutta in primo piano e usare'gamme chiare e sonore (veduta vicina); o spegnerlo
quasi e modularlo entro una stretta serie di valori, col dare la prevalenza al tono del-
l'atmosfera, arretrando la propria visione più o meno lungi dal primo piano (veduta lon-
tana). La prima posizione è essenziale per la pittura toscana; la seconda per la veneta,
ed è sovratutto dovuta a Giorgione e preparata da Giambellino.
E c'è altro ancóra. Cioè che si può esaltare il valore, subordinandovi il tono (a quel
modo che i chiaroscuristi toscani estesero lo sfumato a spegnere i colori), crescendo il
contrasto fra luci ed ombre, e fra primo piano e sfondo, per mezzo di violente illumi-
nazioni radenti le forme in aggetto.
Ora, nel caso precedente, il valore può, ove sia compreso nella realtà pittorica del-
l'artista come non fu mai nei toscani, subordinarsi al tono in un modo tutto singolare.
Cioè si dipinge per accostamento di tinte di cui l'una fa da rilievo o smorzamento del-
l'altra, in quanto un colore si fa più ombroso o luminoso per la presenza di tal altro
vicino. È quello che intuiva il Lomazzo e che il Fromentin significava con la sua science
des valeurs. Ma ciò può attuarsi sia per larghi piani cromatici, (ad. es. Tiziano: Amor
sacro e profano, ecc.), come fu quasi sempre agl'inizi della favella giorgionesca e come
fece, con magnifica sapienza delle « oppositioni » (Zanetti) Paolo Veronese, maestro via
via fino a Vermeer e a Cezanne; sia che si moltiplichi il gioco dei contrasti in uno spez-
zettarsi di couch.es di colore giustapposte o in quel volatile e trito sfaccettio proprio agli
abbozzisti del settecento; sia agendo per chiazze e grumi e colature e sfregazzi, identifi-
cando cioè ogni tono con la pennellata e giungendo alla « pittura di tocco » (Hals, ecc.
Impressionisti moderni). L'insieme di tutto questo ci dà poi «l'accordo generale» o più
particolarmente « la macchia ».
Ovvero, come vedemmo, il tono si subordina al valore, cioè si dipinge per masse
di ciliari emergenti dal fondo oscuro (Tiziano, ecc. Secentisti).
In tal caso può ancora in quelle masse-colore conservarsi un predominio di questo
ultimo, ripetendo il descritto, gioco d'accostamenti e di « tocco »; ma si può anche quasi
annullarlo in un contrasto di masse tutte bevute della tinta della luce, contro le masse
oscure del fondo. Così si giunge al gioco bicromo di tal Tintoretto e di Caravaggio, come
al « luminismo » di Rembrandt, che domina questa maniera. Parrebbe qui si ritornasse
all'ideale leonardesco della forma-luce: solo che là luce ed ombra affoscavano, schia-
ravano, ma non si identificavano col colore, qui la pennellata dà insieme forma e illu-
minazione, quando non si sperda sul fondo bruno nello stenografico allucciolio del più
ardito Tintoretto. Questo via via vedremo con lo svilupparsi del nuovo linguaggio pit-
torico.
Ritorniamo sui nostri passi, dopo aver osservato che ognuna di queste maniere
risponde ad una diversa realtà; che — parlando d'arte — nessuna è superiore o in-
feriore all'altra, o primitiva o matura o moderna. Tutta l'arte è moderna ed è assoluta
in sè stessa. Che, se però, come ora, si fa storia del linguaggio, allora sì v'è progresso
e sviluppo, essendo noi entrati dal campo immobile dell'estetica in quello svolgentesi
della storia di uno dei tanti elementi, e certo il maggiore, che l'artista deve saper unifi-
care in quel momento di felicità che produce l'opera d'arte, dove infatti ciascuno di
questi elementi precipita e si risolve. Che, allora, solo un generico concetto quantitativo —
ammessa la bellezza e la perfezione e la necessaria profonda lontananza di due diversi
capolavori — sarà rimasto all'ammiratore: quello che, quando egli abbia concretato il
« momento sentimentale » che essi rappresentano rispetto al suo proprio spirito, lo ricon-
durrà alla Storia e ad esaminare quanti e più complessi profondi motivi e problemi si
risolvano nell'uno o nell'altro capolavoro, mostrandoli come espressione d'una realtà,
più o meno nutrita e possente, sia in quanto personalità, sia in quanto civiltà e coltura.
tg
Ma c'è altro. Il pittore può di volta in volta esaltare il tono nella sua « altezza » e
genuinità, riducendolo quanto è possibile al « colore locale » col portare la propria vi-
sione tutta in primo piano e usare'gamme chiare e sonore (veduta vicina); o spegnerlo
quasi e modularlo entro una stretta serie di valori, col dare la prevalenza al tono del-
l'atmosfera, arretrando la propria visione più o meno lungi dal primo piano (veduta lon-
tana). La prima posizione è essenziale per la pittura toscana; la seconda per la veneta,
ed è sovratutto dovuta a Giorgione e preparata da Giambellino.
E c'è altro ancóra. Cioè che si può esaltare il valore, subordinandovi il tono (a quel
modo che i chiaroscuristi toscani estesero lo sfumato a spegnere i colori), crescendo il
contrasto fra luci ed ombre, e fra primo piano e sfondo, per mezzo di violente illumi-
nazioni radenti le forme in aggetto.
Ora, nel caso precedente, il valore può, ove sia compreso nella realtà pittorica del-
l'artista come non fu mai nei toscani, subordinarsi al tono in un modo tutto singolare.
Cioè si dipinge per accostamento di tinte di cui l'una fa da rilievo o smorzamento del-
l'altra, in quanto un colore si fa più ombroso o luminoso per la presenza di tal altro
vicino. È quello che intuiva il Lomazzo e che il Fromentin significava con la sua science
des valeurs. Ma ciò può attuarsi sia per larghi piani cromatici, (ad. es. Tiziano: Amor
sacro e profano, ecc.), come fu quasi sempre agl'inizi della favella giorgionesca e come
fece, con magnifica sapienza delle « oppositioni » (Zanetti) Paolo Veronese, maestro via
via fino a Vermeer e a Cezanne; sia che si moltiplichi il gioco dei contrasti in uno spez-
zettarsi di couch.es di colore giustapposte o in quel volatile e trito sfaccettio proprio agli
abbozzisti del settecento; sia agendo per chiazze e grumi e colature e sfregazzi, identifi-
cando cioè ogni tono con la pennellata e giungendo alla « pittura di tocco » (Hals, ecc.
Impressionisti moderni). L'insieme di tutto questo ci dà poi «l'accordo generale» o più
particolarmente « la macchia ».
Ovvero, come vedemmo, il tono si subordina al valore, cioè si dipinge per masse
di ciliari emergenti dal fondo oscuro (Tiziano, ecc. Secentisti).
In tal caso può ancora in quelle masse-colore conservarsi un predominio di questo
ultimo, ripetendo il descritto, gioco d'accostamenti e di « tocco »; ma si può anche quasi
annullarlo in un contrasto di masse tutte bevute della tinta della luce, contro le masse
oscure del fondo. Così si giunge al gioco bicromo di tal Tintoretto e di Caravaggio, come
al « luminismo » di Rembrandt, che domina questa maniera. Parrebbe qui si ritornasse
all'ideale leonardesco della forma-luce: solo che là luce ed ombra affoscavano, schia-
ravano, ma non si identificavano col colore, qui la pennellata dà insieme forma e illu-
minazione, quando non si sperda sul fondo bruno nello stenografico allucciolio del più
ardito Tintoretto. Questo via via vedremo con lo svilupparsi del nuovo linguaggio pit-
torico.
Ritorniamo sui nostri passi, dopo aver osservato che ognuna di queste maniere
risponde ad una diversa realtà; che — parlando d'arte — nessuna è superiore o in-
feriore all'altra, o primitiva o matura o moderna. Tutta l'arte è moderna ed è assoluta
in sè stessa. Che, se però, come ora, si fa storia del linguaggio, allora sì v'è progresso
e sviluppo, essendo noi entrati dal campo immobile dell'estetica in quello svolgentesi
della storia di uno dei tanti elementi, e certo il maggiore, che l'artista deve saper unifi-
care in quel momento di felicità che produce l'opera d'arte, dove infatti ciascuno di
questi elementi precipita e si risolve. Che, allora, solo un generico concetto quantitativo —
ammessa la bellezza e la perfezione e la necessaria profonda lontananza di due diversi
capolavori — sarà rimasto all'ammiratore: quello che, quando egli abbia concretato il
« momento sentimentale » che essi rappresentano rispetto al suo proprio spirito, lo ricon-
durrà alla Storia e ad esaminare quanti e più complessi profondi motivi e problemi si
risolvano nell'uno o nell'altro capolavoro, mostrandoli come espressione d'una realtà,
più o meno nutrita e possente, sia in quanto personalità, sia in quanto civiltà e coltura.