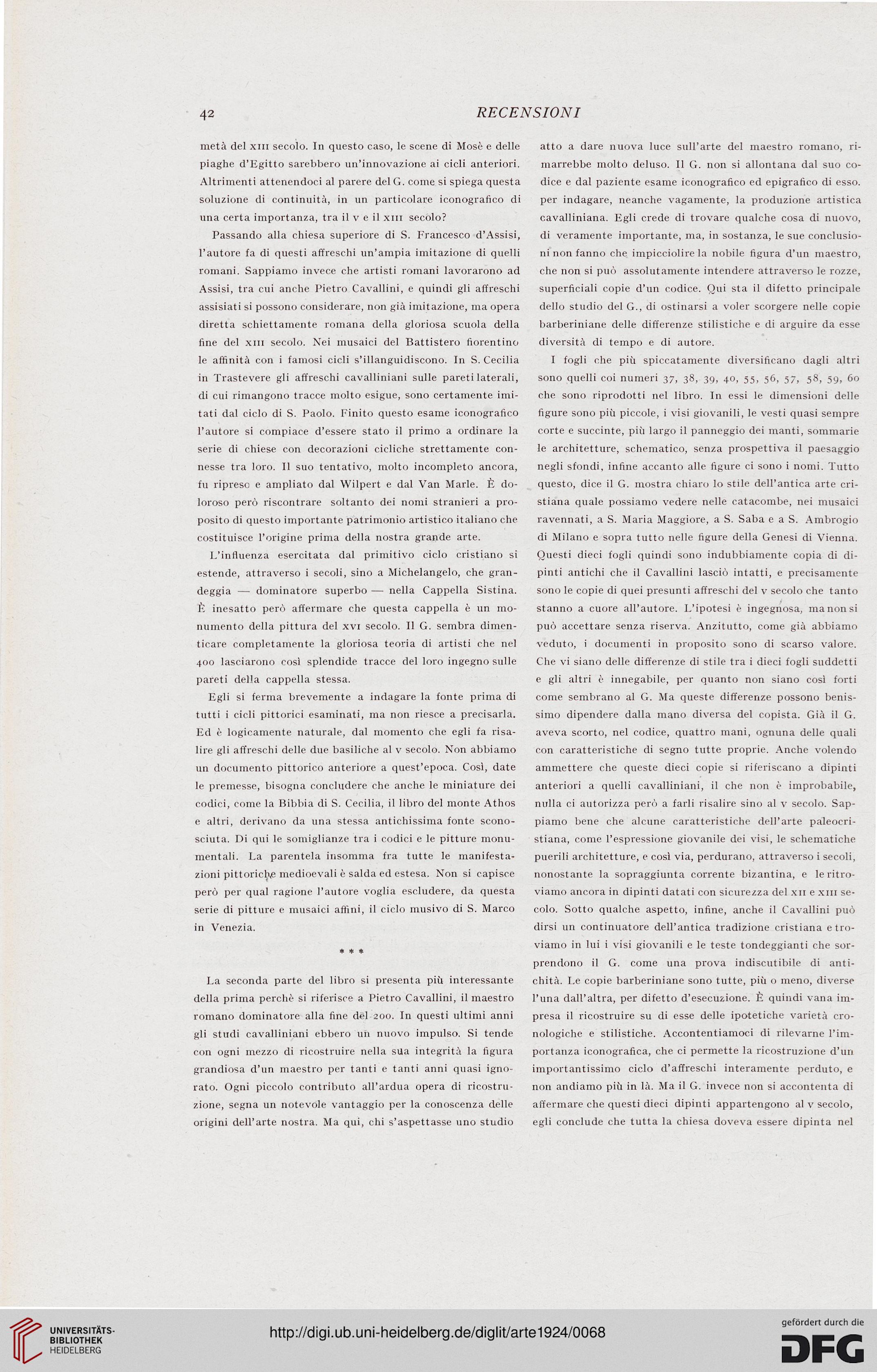42
RECENSIONI
metà del xm secolo. In questo caso, le scene di Mose e delle
piaghe d'Egitto sarebbero un'innovazione ai cicli anteriori.
Altrimenti attenendoci al parere del G. come si spiega questa
soluzione di continuità, in un particolare iconografico di
una certa importanza, tra il v e il xm secolo?
Passando alla chiesa superiore di S. Francesco d'Assisi,
l'autore fa di questi affreschi un'ampia imitazione di quelli
romani. Sappiamo invece che artisti romani lavorarono ad
Assisi, tra cui anche Pietro Cavallini, e quindi gli affreschi
assisiati si possono considerare, non già imitazione, ma opera
diretta schiettamente romana della gloriosa scuola della
fine del xm secolo. Nei musaici del Battistero fiorentino
le affinità con i famosi cicli s'illanguidiscono. In S. Cecilia
in Trastevere gli affreschi cavalliniani sulle pareti laterali,
di cui rimangono tracce molto esigue, sono certamente imi-
tati dal ciclo di S. Paolo. Finito questo esame iconografico
l'autore si compiace d'essere stato il primo a ordinare la
serie di chiese con decorazioni cicliche strettamente con-
nesse tra loro. Il suo tentativo, molto incompleto ancora,
fu ripreso e ampliato dal Wilpert e dal Van Marie. È do-
loroso però riscontrare soltanto dei nomi stranieri a pro-
posito di questo importante patrimonio artistico italiano che
costituisce l'origine prima della nostra grande arte.
L'influenza esercitata dal primitivo ciclo cristiano si
estende, attraverso i secoli, sino a Michelangelo, che gran-
deggia — dominatore superbo — nella Cappella Sistina.
P. inesatto però affermare che questa cappella è un mo-
numento della pittura del xvi secolo. Il G. sembra dimen-
ticare completamente la gloriosa teoria di artisti che nel
400 lasciarono cosi splendide tracce del loro ingegno sulle
pareti della cappella stessa.
Egli si ferma brevemente a indagare la fonte prima di
tutti i cicli pittorici esaminati, ma non riesce a precisarla.
Ed è logicamente naturale, dal momento che egli fa risa-
lire gli affreschi delle due basiliche al v secolo. Non abbiamo
un documento pittorico anteriore a quest'epoca. Cosi, date
le premesse, bisogna concludere che anche le miniature dei
codici, come la Bibbia di S. Cecilia, il libro del monte Athos
e altri, derivano da una stessa antichissima fonte scono-
sciuta. Di qui le somiglianze tra i codici e le pitture monu-
mentali. La parentela insomma fra tutte le manifesta-
zioni pittoriche medioevali è salda ed estesa. Non si capisce
però per qual ragione l'autore voglia escludere, da questa
serie di pitture e musaici affini, il ciclo musivo di S. Marco
in Venezia.
* * »
La seconda parte del libro si presenta più interessante
della prima perchè si riferisce a Pietro Cavallini, il maestro
romano dominatore alla fine del 200. In questi ultimi anni
gli studi cavalliniani ebbero uh nuovo impulso. Si tende
con ogni mezzo di ricostruire nella sua integrità la figura
grandiosa d'un maestro per tanti e tanti anni quasi igno-
rato. Ogni piccolo contributo all'ardua opera di ricostru-
zione, segna un notevole vantaggio per la conoscenza delle
origini dell'arte nostra. Ma qui, chi s'aspettasse uno studio
atto a dare nuova luce sull'arte del maestro romano, ri-
marrebbe molto deluso. Il G. non si allontana dal suo co-
dice e dal paziente esame iconografico ed epigrafico di esso,
per indagare, neanche vagamente, la produzione artistica
cavalliniana. Egli crede di trovare qualche cosa di nuovo,
di veramente importante, ma, in sostanza, le sue conclusio-
ni non fanno che impicciolire la nobile figura d'un maestro,
che non si può assolutamente intendere attraverso le rozze,
superficiali copie d'un codice. Qui sta il difetto principale
dello studio del G., di ostinarsi a voler scorgere nelle copie
barberiniane delle differenze stilistiche e di arguire da esse
diversità di tempo e di autore.
I fogli che più spiccatamente diversificano dagli altri
sono quelli coi numeri 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 59, 60
che sono riprodotti nel libro. In essi le dimensioni delle
figure sono più piccole, i visi giovanili, le vesti quasi sempre
corte e succinte, più largo il panneggio dei manti, sommarie
le architetture, schematico, senza prospettiva il paesaggio
negli sfondi, infine accanto alle figure ci sono i nomi. Tutto
questo, dice il G. mostra chiaro lo stile dell'antica arte cri-
stiana quale possiamo vedere nelle catacombe, nei musaici
ravennati, a S. Maria Maggiore, a S. Saba e a S. Ambrogio
di Milano e sopra tutto nelle figure della Genesi di Vienna.
Questi dieci fogli quindi sono indubbiamente copia di di-
pinti antichi che il Cavallini lasciò intatti, e precisamente
sono le copie di quei presunti affreschi del v secolo che tanto
stanno a cuore all'autore. L'ipotesi è ingegnosa, ma non si
può accettare senza riserva. Anzitutto, come già abbiamo
veduto, i documenti in proposito sono di scarso valore.
Che vi siano delle differenze di stile tra i dieci fogli suddetti
e gli altri è innegabile, per quanto non siano cosi forti
come sembrano al G. Ma queste differenze possono benis-
simo dipendere dalla mano diversa del copista. Già il G.
aveva scorto, nel codice, quattro mani, ognuna delle quali
con caratteristiche di segno tutte proprie. Anche volendo
ammettere che queste dieci copie si riferiscano a dipinti
anteriori a quelli cavalliniani, il che non è improbabile,
nulla ci autorizza però a farli risalire sino al v secolo. Sap-
piamo bene che alcune caratteristiche dell'arte paleocri-
stiana, come l'espressione giovanile dei visi, le schematiche
puerili architetture, e cosi via, perdurano, attraverso i secoli,
nonostante la sopraggiunta corrente bizantina, e le ritro-
viamo ancora in dipinti datati con sicurezza del xn e xm se-
colo. Sotto qualche aspetto, infine, anche il Cavallini può
dirsi un continuatore dell'antica tradizione cristiana e tro-
viamo in lui i visi giovanili e le teste tondeggianti che sor-
prendono il G. come una prova indiscutibile di anti-
chità. Le copie barberiniane sono tutte, più o meno, diverse
l'una dall'altra, per difetto d'esecuzione. È quindi vana im-
presa il ricostruire su di esse delle ipotetiche varietà cro-
nologiche e stilistiche. Accontentiamoci di rilevarne l'im-
portanza iconografica, che ci permette la ricostruzione d'un
importantissimo ciclo d'affreschi interamente perduto, e
non andiamo più in là. Ma il G. invece non si accontenta di
affermare che questi dieci dipinti appartengono al y secolo,
egli conclude che tutta la chiesa doveva essere dipinta nel
RECENSIONI
metà del xm secolo. In questo caso, le scene di Mose e delle
piaghe d'Egitto sarebbero un'innovazione ai cicli anteriori.
Altrimenti attenendoci al parere del G. come si spiega questa
soluzione di continuità, in un particolare iconografico di
una certa importanza, tra il v e il xm secolo?
Passando alla chiesa superiore di S. Francesco d'Assisi,
l'autore fa di questi affreschi un'ampia imitazione di quelli
romani. Sappiamo invece che artisti romani lavorarono ad
Assisi, tra cui anche Pietro Cavallini, e quindi gli affreschi
assisiati si possono considerare, non già imitazione, ma opera
diretta schiettamente romana della gloriosa scuola della
fine del xm secolo. Nei musaici del Battistero fiorentino
le affinità con i famosi cicli s'illanguidiscono. In S. Cecilia
in Trastevere gli affreschi cavalliniani sulle pareti laterali,
di cui rimangono tracce molto esigue, sono certamente imi-
tati dal ciclo di S. Paolo. Finito questo esame iconografico
l'autore si compiace d'essere stato il primo a ordinare la
serie di chiese con decorazioni cicliche strettamente con-
nesse tra loro. Il suo tentativo, molto incompleto ancora,
fu ripreso e ampliato dal Wilpert e dal Van Marie. È do-
loroso però riscontrare soltanto dei nomi stranieri a pro-
posito di questo importante patrimonio artistico italiano che
costituisce l'origine prima della nostra grande arte.
L'influenza esercitata dal primitivo ciclo cristiano si
estende, attraverso i secoli, sino a Michelangelo, che gran-
deggia — dominatore superbo — nella Cappella Sistina.
P. inesatto però affermare che questa cappella è un mo-
numento della pittura del xvi secolo. Il G. sembra dimen-
ticare completamente la gloriosa teoria di artisti che nel
400 lasciarono cosi splendide tracce del loro ingegno sulle
pareti della cappella stessa.
Egli si ferma brevemente a indagare la fonte prima di
tutti i cicli pittorici esaminati, ma non riesce a precisarla.
Ed è logicamente naturale, dal momento che egli fa risa-
lire gli affreschi delle due basiliche al v secolo. Non abbiamo
un documento pittorico anteriore a quest'epoca. Cosi, date
le premesse, bisogna concludere che anche le miniature dei
codici, come la Bibbia di S. Cecilia, il libro del monte Athos
e altri, derivano da una stessa antichissima fonte scono-
sciuta. Di qui le somiglianze tra i codici e le pitture monu-
mentali. La parentela insomma fra tutte le manifesta-
zioni pittoriche medioevali è salda ed estesa. Non si capisce
però per qual ragione l'autore voglia escludere, da questa
serie di pitture e musaici affini, il ciclo musivo di S. Marco
in Venezia.
* * »
La seconda parte del libro si presenta più interessante
della prima perchè si riferisce a Pietro Cavallini, il maestro
romano dominatore alla fine del 200. In questi ultimi anni
gli studi cavalliniani ebbero uh nuovo impulso. Si tende
con ogni mezzo di ricostruire nella sua integrità la figura
grandiosa d'un maestro per tanti e tanti anni quasi igno-
rato. Ogni piccolo contributo all'ardua opera di ricostru-
zione, segna un notevole vantaggio per la conoscenza delle
origini dell'arte nostra. Ma qui, chi s'aspettasse uno studio
atto a dare nuova luce sull'arte del maestro romano, ri-
marrebbe molto deluso. Il G. non si allontana dal suo co-
dice e dal paziente esame iconografico ed epigrafico di esso,
per indagare, neanche vagamente, la produzione artistica
cavalliniana. Egli crede di trovare qualche cosa di nuovo,
di veramente importante, ma, in sostanza, le sue conclusio-
ni non fanno che impicciolire la nobile figura d'un maestro,
che non si può assolutamente intendere attraverso le rozze,
superficiali copie d'un codice. Qui sta il difetto principale
dello studio del G., di ostinarsi a voler scorgere nelle copie
barberiniane delle differenze stilistiche e di arguire da esse
diversità di tempo e di autore.
I fogli che più spiccatamente diversificano dagli altri
sono quelli coi numeri 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 59, 60
che sono riprodotti nel libro. In essi le dimensioni delle
figure sono più piccole, i visi giovanili, le vesti quasi sempre
corte e succinte, più largo il panneggio dei manti, sommarie
le architetture, schematico, senza prospettiva il paesaggio
negli sfondi, infine accanto alle figure ci sono i nomi. Tutto
questo, dice il G. mostra chiaro lo stile dell'antica arte cri-
stiana quale possiamo vedere nelle catacombe, nei musaici
ravennati, a S. Maria Maggiore, a S. Saba e a S. Ambrogio
di Milano e sopra tutto nelle figure della Genesi di Vienna.
Questi dieci fogli quindi sono indubbiamente copia di di-
pinti antichi che il Cavallini lasciò intatti, e precisamente
sono le copie di quei presunti affreschi del v secolo che tanto
stanno a cuore all'autore. L'ipotesi è ingegnosa, ma non si
può accettare senza riserva. Anzitutto, come già abbiamo
veduto, i documenti in proposito sono di scarso valore.
Che vi siano delle differenze di stile tra i dieci fogli suddetti
e gli altri è innegabile, per quanto non siano cosi forti
come sembrano al G. Ma queste differenze possono benis-
simo dipendere dalla mano diversa del copista. Già il G.
aveva scorto, nel codice, quattro mani, ognuna delle quali
con caratteristiche di segno tutte proprie. Anche volendo
ammettere che queste dieci copie si riferiscano a dipinti
anteriori a quelli cavalliniani, il che non è improbabile,
nulla ci autorizza però a farli risalire sino al v secolo. Sap-
piamo bene che alcune caratteristiche dell'arte paleocri-
stiana, come l'espressione giovanile dei visi, le schematiche
puerili architetture, e cosi via, perdurano, attraverso i secoli,
nonostante la sopraggiunta corrente bizantina, e le ritro-
viamo ancora in dipinti datati con sicurezza del xn e xm se-
colo. Sotto qualche aspetto, infine, anche il Cavallini può
dirsi un continuatore dell'antica tradizione cristiana e tro-
viamo in lui i visi giovanili e le teste tondeggianti che sor-
prendono il G. come una prova indiscutibile di anti-
chità. Le copie barberiniane sono tutte, più o meno, diverse
l'una dall'altra, per difetto d'esecuzione. È quindi vana im-
presa il ricostruire su di esse delle ipotetiche varietà cro-
nologiche e stilistiche. Accontentiamoci di rilevarne l'im-
portanza iconografica, che ci permette la ricostruzione d'un
importantissimo ciclo d'affreschi interamente perduto, e
non andiamo più in là. Ma il G. invece non si accontenta di
affermare che questi dieci dipinti appartengono al y secolo,
egli conclude che tutta la chiesa doveva essere dipinta nel