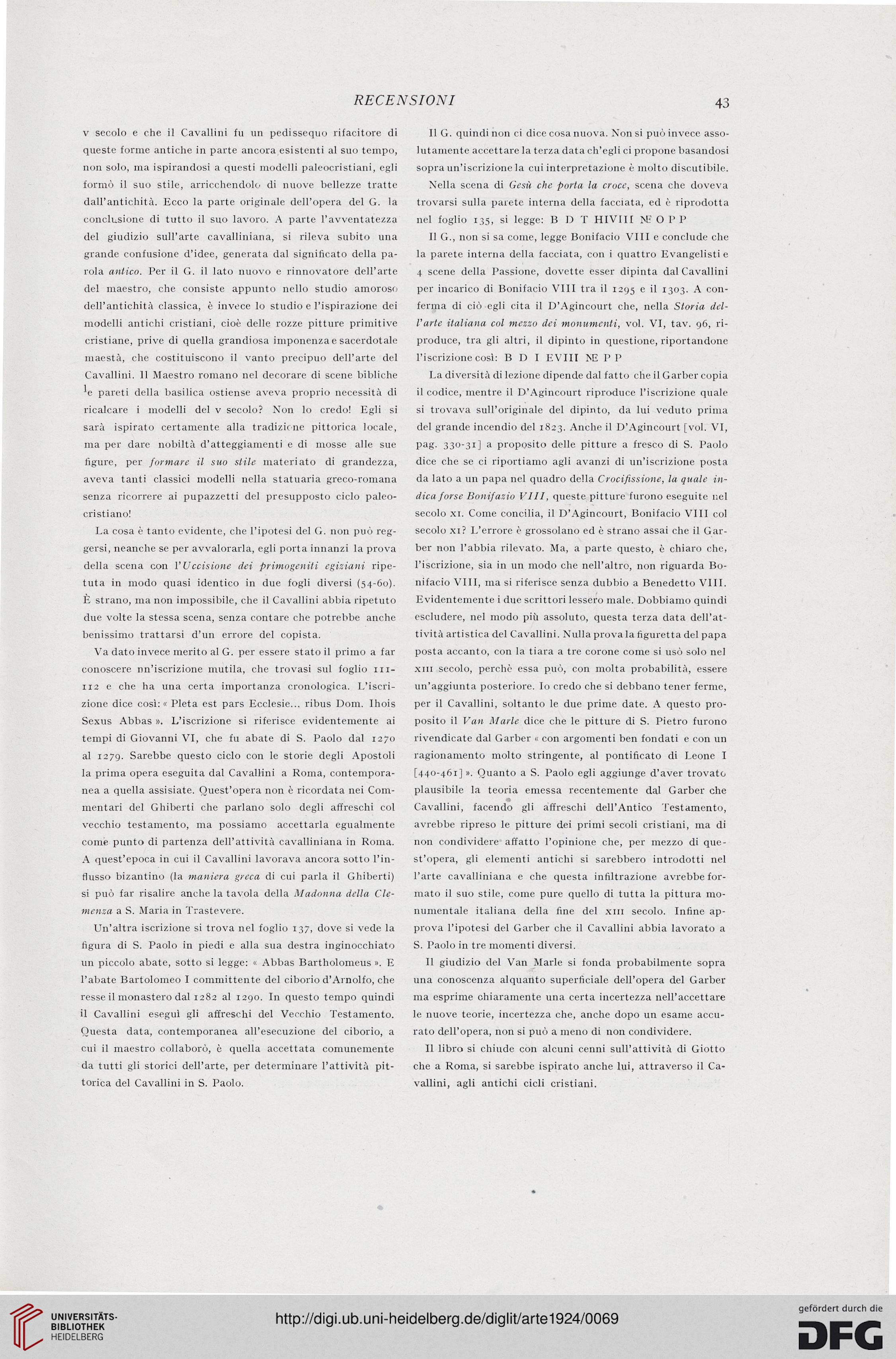RECENSIONI
4.;
v secolo e che il Cavallini fu un pedissequo rifacitore di
queste forme antiche in parte ancora esistenti al suo tempo,
non solo, ma ispirandosi a questi modelli paleocristiani, egli
formò il suo stile, arricchendolo di nuove bellezze tratte
dall'antichità. Ecco la parte originale dell'opera del G. la
conclusione di tutto il suo lavoro. A parte l'avventatezza
del giudizio sull'arte cavalliniana, si rileva subito una
grande confusione d'idee, generata dal significato della pa-
rola antico. Per il G. il lato nuovo e rinnovatore dell'arte
del maestro, che consiste appunto nello studio amorosi!
dell'antichità classica, è invece lo studio e l'ispirazione dei
modelli antichi cristiani, cioè delle rozze pitture primitive
cristiane, prive di quella grandiosa imponenza e sacerdotale
maestà, che costituiscono il vanto precipuo dell'arte del
Cavallini. 11 Maestro romano nel decorare di scene bibliche
'e pareti della basilica ostiense aveva proprio necessità di
ricalcare i modelli del v secolo? Non lo credo! Egli si
sarà ispirato certamente alla tradizione pittorica locale,
ma per dare nobiltà d'atteggiamenti e di mosse alle sue
figure, per formare il suo stile materiato di grandezza,
aveva tanti classici modelli nella statuaria greco-romana
senza ricorrere ai pupazzetti del presupposto ciclo paleo-
cristiano!
La cosa è tanto evidente, che l'ipotesi del (1. non può reg-
gersi, neanche se per avvalorarla, egli porta innanzi la prova
della scena con VVccisione dei primogeniti egiziani ripe-
tuta in modo quasi identico in due fogli diversi (54-60).
È strano, ma non impossibile, che il Cavallini abbia ripetuto
due volte la stessa scena, senza contare che potrebbe anche
benissimo trattarsi d'un errore del copista.
Va dato invece merito al G. per essere stato il primo a far
conoscere nn'iscrizione mutila, che trovasi sul foglio 111-
112 e che ha una certa importanza cronologica. L'iscri-
zione dice cosi: « Pietà est pars Ecclesie... ribus Dom. Ihois
Sexus Abbas ». L'iscrizione si riferisce evidentemente ai
tempi di Giovanni VI, che fu abate di S. Paolo dal 1270
al 1279. Sarebbe questo ciclo con le storie degli Apostoli
la prima opera eseguita dal Cavallini a Roma, contempora-
nea a quella assisiate. Quest'opera non è ricordata nei Com-
mentari del Ghiberti che parlano solo degli affreschi col
vecchio testamento, ma possiamo accettarla egualmente
coinè punto di partenza dell'attività cavalliniana in Roma.
A quest'epoca in cui il Cavallini lavorava ancora sotto l'in-
flusso bizantino (la maniera greca di cui parla il Ghiberti)
si può far risalire anche la tavola della Madonna della Cle-
menza a S. Maria in Trastevere.
Un'altra iscrizione si trova nel foglio 137, dove si vede la
figura di S. Paolo in piedi e alla sua destra inginocchiato
un piccolo abate, sotto si legge: « Abbas Bartholomeus ». E
l'abate Bartolomeo I committente del ciborio d'Arnolfo, che
resse il monastero dal 1282 al 1290. In questo tempo quindi
il Cavallini esegui gli affreschi del Vecchio Testamento.
Questa data, contemporanea all'esecuzione del ciborio, a
cui il maestro collaborò, è quella accettata comunemente
da tutti gli storici dell'arte, per determinare l'attività pit-
torica del Cavallini in S. Paolo.
Il G. quindi non ci dice cosa nuova. Non si può invece asso-
lutamente accettare la terza data ch'egli ci propone basandosi
sopra un'iscrizione la cui interpretazione è molto discutibile.
Nella scena di Gesù che porta la croce, scena che doveva
trovarsi sulla parete interna della facciata, ed è riprodotta
nel foglio 135, si legge: B D T HIVIII >f O P P
11 G., non si sa come, legge Bonifacio VIII e conclude che
la parete interna della facciata, con i quattro Evangelisti e
4 scene della Passione, dovette esser dipinta dal Cavallini
per incarico di Bonifacio Vili tra il 1295 e il 1303. A con-
ferma di ciò egli cita il D'Agincourt che, nella Storia dcl-
Varte italiana col mezzo dei monumenti, voi. VI, tav. 96, ri-
produce, tra gli altri, il dipinto in questione, riportandone
l'iscrizione così: B D I KVIII MI PP
La diversità di lezione dipende dal fatto che il Garber copia
il codice, mentre il D'Agincourt riproduce l'iscrizione quale
si trovava sull'originale del dipinto, da lui veduto prima
del grande incendio del 1823. Anche il D'Agincourt [voi. VI,
pag. 330-31] a proposito delle pitture a fresco di S. Paolo
dice che se ci riportiamo agli avanzi di un'iscrizione posta
da iato a un papa nel quadro della Crocifissione, la quale in-
dica forse Bonifazio Vili, queste pitture furono eseguite nel
secolo xi. Come concilia, il D'Agincourt, Bonifacio Vili col
secolo xi? L'errore è grossolano ed è strano assai che il Gar-
ber non l'abbia rilevato. Ma, a parte questo, è chiaro che,
l'iscrizione, sia in un modo che nell'altro, non riguarda Bo-
nifacio Vili, ma si riferisce senza dubbio a Benedetto Vili.
Evidentemente i due scrittori lessero male. Dobbiamo quindi
escludere, nel modo più assoluto, questa terza data dell'at-
tività artistica del Cavallini. Nulla prova la figuretta del papa
posta accanto, con la tiara a tre corone come si usò solo nel
xiii secolo, perchè essa può, con molta probabilità, essere
un'aggiunta posteriore. Io credo che si debbano tener ferini',
per il Cavallini, soltanto le due prime date. A questo pro-
posito il Van Marie dice che le pitture di S. Pietro furono
rivendicate dal Garber « con argomenti ben fondati e con un
ragionamento molto stringente, al pontificato di Leone I
[440-461] ». Quanto a S. Paolo egli aggiunge d'aver trovato
plausibile la teoria emessa recentemente dal Garber che
Cavallini, facendo gli affreschi dell'Antico Testamento,
avrebbe ripreso le pitture dei primi secoli cristiani, ma di
non condividere affatto l'opinione che, per mezzo di que-
st'opera, gli elementi antichi si sarebbero introdotti nel
l'arte cavalliniana e che questa infiltrazione avrebbe for-
mato il suo stile, come pure quello di tutta la pittura mo-
numentale italiana della fine del xm secolo. Infine ap-
prova l'ipotesi del Garber che il Cavallini abbia lavorato a
S. Paolo in tre momenti diversi.
11 giudizio del Van Marie si fonda probabilmente sopra
una conoscenza alquanto superficiale dell'opera del Garber
ma esprime chiaramente una certa incertezza nell'accettare
le nuove teorie, incertezza che, anche dopo un esame accu-
rato dell'opera, non si può a meno di non condividere.
Il libro si chiude con alcuni cenni sull'attività di Giotto
che a Roma, si sarebbe ispirato anche lui, attraverso il Ca-
vallini, agli antichi cicli cristiani.
4.;
v secolo e che il Cavallini fu un pedissequo rifacitore di
queste forme antiche in parte ancora esistenti al suo tempo,
non solo, ma ispirandosi a questi modelli paleocristiani, egli
formò il suo stile, arricchendolo di nuove bellezze tratte
dall'antichità. Ecco la parte originale dell'opera del G. la
conclusione di tutto il suo lavoro. A parte l'avventatezza
del giudizio sull'arte cavalliniana, si rileva subito una
grande confusione d'idee, generata dal significato della pa-
rola antico. Per il G. il lato nuovo e rinnovatore dell'arte
del maestro, che consiste appunto nello studio amorosi!
dell'antichità classica, è invece lo studio e l'ispirazione dei
modelli antichi cristiani, cioè delle rozze pitture primitive
cristiane, prive di quella grandiosa imponenza e sacerdotale
maestà, che costituiscono il vanto precipuo dell'arte del
Cavallini. 11 Maestro romano nel decorare di scene bibliche
'e pareti della basilica ostiense aveva proprio necessità di
ricalcare i modelli del v secolo? Non lo credo! Egli si
sarà ispirato certamente alla tradizione pittorica locale,
ma per dare nobiltà d'atteggiamenti e di mosse alle sue
figure, per formare il suo stile materiato di grandezza,
aveva tanti classici modelli nella statuaria greco-romana
senza ricorrere ai pupazzetti del presupposto ciclo paleo-
cristiano!
La cosa è tanto evidente, che l'ipotesi del (1. non può reg-
gersi, neanche se per avvalorarla, egli porta innanzi la prova
della scena con VVccisione dei primogeniti egiziani ripe-
tuta in modo quasi identico in due fogli diversi (54-60).
È strano, ma non impossibile, che il Cavallini abbia ripetuto
due volte la stessa scena, senza contare che potrebbe anche
benissimo trattarsi d'un errore del copista.
Va dato invece merito al G. per essere stato il primo a far
conoscere nn'iscrizione mutila, che trovasi sul foglio 111-
112 e che ha una certa importanza cronologica. L'iscri-
zione dice cosi: « Pietà est pars Ecclesie... ribus Dom. Ihois
Sexus Abbas ». L'iscrizione si riferisce evidentemente ai
tempi di Giovanni VI, che fu abate di S. Paolo dal 1270
al 1279. Sarebbe questo ciclo con le storie degli Apostoli
la prima opera eseguita dal Cavallini a Roma, contempora-
nea a quella assisiate. Quest'opera non è ricordata nei Com-
mentari del Ghiberti che parlano solo degli affreschi col
vecchio testamento, ma possiamo accettarla egualmente
coinè punto di partenza dell'attività cavalliniana in Roma.
A quest'epoca in cui il Cavallini lavorava ancora sotto l'in-
flusso bizantino (la maniera greca di cui parla il Ghiberti)
si può far risalire anche la tavola della Madonna della Cle-
menza a S. Maria in Trastevere.
Un'altra iscrizione si trova nel foglio 137, dove si vede la
figura di S. Paolo in piedi e alla sua destra inginocchiato
un piccolo abate, sotto si legge: « Abbas Bartholomeus ». E
l'abate Bartolomeo I committente del ciborio d'Arnolfo, che
resse il monastero dal 1282 al 1290. In questo tempo quindi
il Cavallini esegui gli affreschi del Vecchio Testamento.
Questa data, contemporanea all'esecuzione del ciborio, a
cui il maestro collaborò, è quella accettata comunemente
da tutti gli storici dell'arte, per determinare l'attività pit-
torica del Cavallini in S. Paolo.
Il G. quindi non ci dice cosa nuova. Non si può invece asso-
lutamente accettare la terza data ch'egli ci propone basandosi
sopra un'iscrizione la cui interpretazione è molto discutibile.
Nella scena di Gesù che porta la croce, scena che doveva
trovarsi sulla parete interna della facciata, ed è riprodotta
nel foglio 135, si legge: B D T HIVIII >f O P P
11 G., non si sa come, legge Bonifacio VIII e conclude che
la parete interna della facciata, con i quattro Evangelisti e
4 scene della Passione, dovette esser dipinta dal Cavallini
per incarico di Bonifacio Vili tra il 1295 e il 1303. A con-
ferma di ciò egli cita il D'Agincourt che, nella Storia dcl-
Varte italiana col mezzo dei monumenti, voi. VI, tav. 96, ri-
produce, tra gli altri, il dipinto in questione, riportandone
l'iscrizione così: B D I KVIII MI PP
La diversità di lezione dipende dal fatto che il Garber copia
il codice, mentre il D'Agincourt riproduce l'iscrizione quale
si trovava sull'originale del dipinto, da lui veduto prima
del grande incendio del 1823. Anche il D'Agincourt [voi. VI,
pag. 330-31] a proposito delle pitture a fresco di S. Paolo
dice che se ci riportiamo agli avanzi di un'iscrizione posta
da iato a un papa nel quadro della Crocifissione, la quale in-
dica forse Bonifazio Vili, queste pitture furono eseguite nel
secolo xi. Come concilia, il D'Agincourt, Bonifacio Vili col
secolo xi? L'errore è grossolano ed è strano assai che il Gar-
ber non l'abbia rilevato. Ma, a parte questo, è chiaro che,
l'iscrizione, sia in un modo che nell'altro, non riguarda Bo-
nifacio Vili, ma si riferisce senza dubbio a Benedetto Vili.
Evidentemente i due scrittori lessero male. Dobbiamo quindi
escludere, nel modo più assoluto, questa terza data dell'at-
tività artistica del Cavallini. Nulla prova la figuretta del papa
posta accanto, con la tiara a tre corone come si usò solo nel
xiii secolo, perchè essa può, con molta probabilità, essere
un'aggiunta posteriore. Io credo che si debbano tener ferini',
per il Cavallini, soltanto le due prime date. A questo pro-
posito il Van Marie dice che le pitture di S. Pietro furono
rivendicate dal Garber « con argomenti ben fondati e con un
ragionamento molto stringente, al pontificato di Leone I
[440-461] ». Quanto a S. Paolo egli aggiunge d'aver trovato
plausibile la teoria emessa recentemente dal Garber che
Cavallini, facendo gli affreschi dell'Antico Testamento,
avrebbe ripreso le pitture dei primi secoli cristiani, ma di
non condividere affatto l'opinione che, per mezzo di que-
st'opera, gli elementi antichi si sarebbero introdotti nel
l'arte cavalliniana e che questa infiltrazione avrebbe for-
mato il suo stile, come pure quello di tutta la pittura mo-
numentale italiana della fine del xm secolo. Infine ap-
prova l'ipotesi del Garber che il Cavallini abbia lavorato a
S. Paolo in tre momenti diversi.
11 giudizio del Van Marie si fonda probabilmente sopra
una conoscenza alquanto superficiale dell'opera del Garber
ma esprime chiaramente una certa incertezza nell'accettare
le nuove teorie, incertezza che, anche dopo un esame accu-
rato dell'opera, non si può a meno di non condividere.
Il libro si chiude con alcuni cenni sull'attività di Giotto
che a Roma, si sarebbe ispirato anche lui, attraverso il Ca-
vallini, agli antichi cicli cristiani.