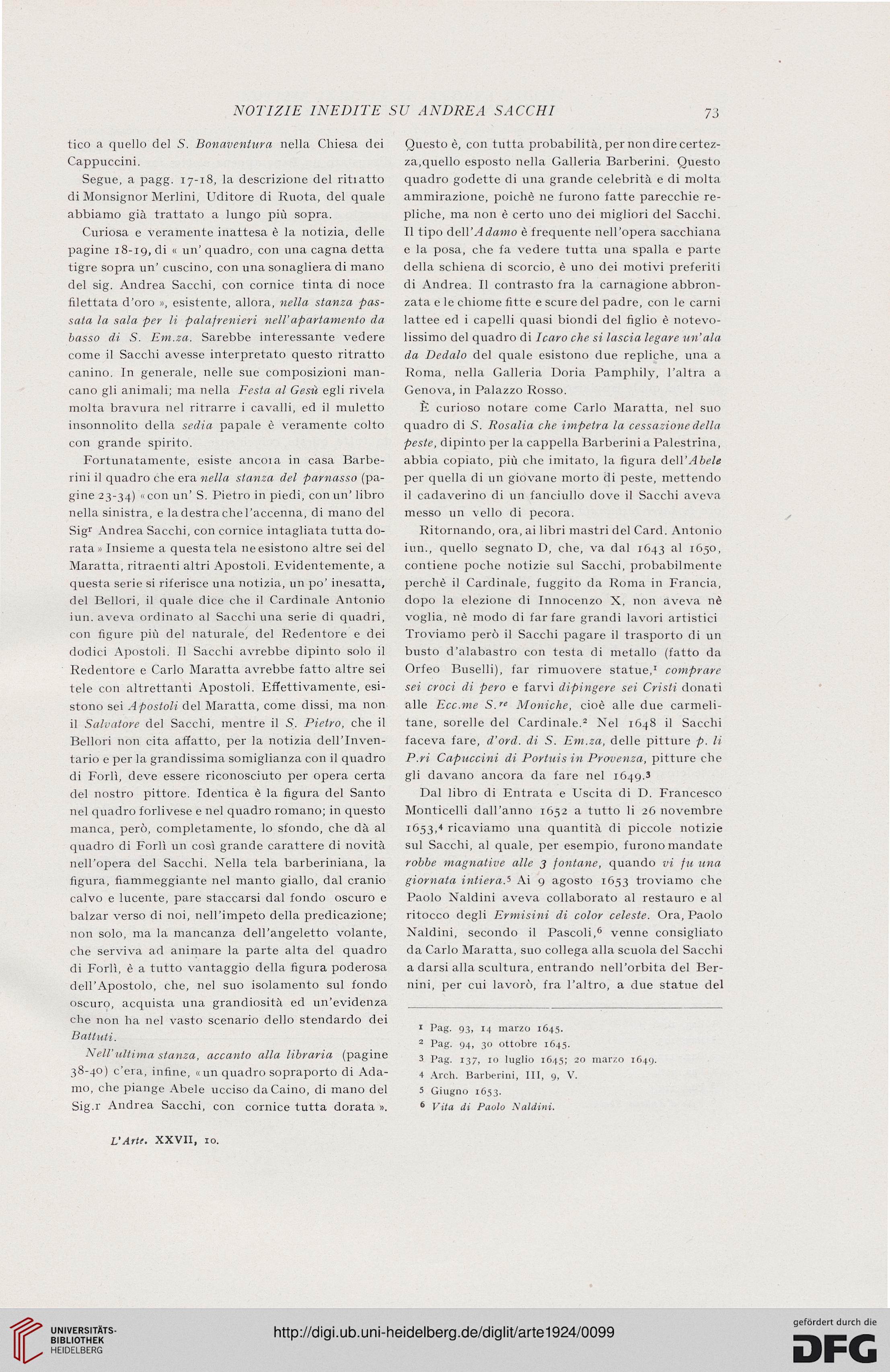NOTIZIE INEDITE SU ANDREA SACCHI
73
tico a quello del S. Bonaventura nella Chiesa dei
Cappuccini.
Segue, a pagg. 17-18, la descrizione del ritiatto
di Monsignor Merlini, Uditore di Ruota, del quale
abbiamo già trattato a lungo più sopra.
Curiosa e veramente inattesa è la notizia, delle
pagine 18-19, di « un' quadro, con una cagna detta
tigre sopra un' cuscino, con una sonagliera di mano
del sig. Andrea Sacchi, con cornice tinta di noce
filettata d'oro », esistente, allora, nella stanza pas-
sata la sala per li palafrenieri nell'apartamento da
basso di S. Em.za. Sarebbe interessante vedere
come il Sacchi avesse interpretato questo ritratto
canino. In generale, nelle sue composizioni man-
cano gli animali; ma nella Festa al Gesù egli rivela
molta bravura nel ritrarre i cavalli, ed il muletto
insonnolito della sedia papale è veramente colto
con grande spirito.
Fortunatamente, esiste ancoia in casa Barbe-
rini il quadro che era nella stanza del parnasso (pa-
gine 23-34) "con un' S. Pietro in piedi, con un' libro
nella sinistra, e la destra che l'accenna, di mano del
Sigr Andrea Sacchi, con cornice intagliata tutta do-
rata » Insieme a questa tela ne esistono altre sei del
Maratta, ritraenti altri Apostoli. Evidentemente, a
questa serie si riferisce una notizia, un po' inesatta,
del Bellori, il quale dice che il Cardinale Antonio
iun. aveva ordinato al Sacchi una serie di quadri,
con figure più del naturale, del Redentore e dei
dodici Apostoli. Il Sacchi avrebbe dipinto solo il
Redentore e Carlo Maratta avrebbe fatto altre sei
tele con altrettanti Apostoli. Effettivamente, esi-
stono sei Apostoli del Maratta, come dissi, ma non
il Salvatore del Sacchi, mentre il S. Pietro, che il
Bellori non cita affatto, per la notizia dell'Inven-
tario e per la grandissima somiglianza con il quadro
di Forlì, deve essere riconosciuto per opera certa
del nostro pittore. Identica è la figura del Santo
nel quadro forlivese e nel quadro romano; in questo
manca, però, completamente, lo sfondo, che dà al
quadro di Forlì un così grande carattere di novità
nell'opera del Sacchi. Nella tela barberiniana, la
figura, fiammeggiante nel manto giallo, dal cranio
calvo e lucente, pare staccarsi dal fondo oscuro e
balzar verso di noi, nell'impeto della predicazione;
non solo, ma la mancanza dell'angeletto volante,
che serviva ad animare la parte alta del quadro
di Forlì, è a tutto vantaggio della figura poderosa
dell'Apostolo, che, nel suo isolamento sul fondo
oscuro, acquista una grandiosità ed un'evidenza
che non ha nel vasto scenario dello stendardo dei
Battuti.
Nell'ultima stanza, accanto alla libraria (pagine
38-40) c'era, infine, « un quadro sopraporto di Ada-
mo, che piange Abele ucciso da Caino, di mano del
Sig.r Andrea Sacchi, con cornice tutta dorata ».
Questo è, con tutta probabilità, per non dire certez-
za,quello esposto nella Galleria Barberini. Questo
quadro godette di una grande celebrità e di molta
ammirazione, poiché ne furono fatte parecchie re-
pliche, ma non è certo uno dei migliori del Sacchi.
Il tipo dell' Adamo è frequente nell'opera sacchiana
e la posa, che fa vedere tutta una spalla e parte
della schiena di scorcio, è uno dei motivi preferiti
di Andrea. Il contrasto fra la carnagione abbron-
zata e le chiome fitte e scure del padre, con le carni
lattee ed i capelli quasi biondi del figlio è notevo-
lissimo del quadro di Icaro che si lascia legare un'ala
da Dedalo del quale esistono due repliche, una a
Roma, nella Galleria Doria Pamphily, l'altra a
Genova, in Palazzo Rosso.
È curioso notare come Carlo Maratta, nel suo
quadro di S. Rosalia che impetra la cessazione del Ut
peste, dipinto per la cappella Barberini a Palestrina,
abbia copiato, più che imitato, la figura dell' Abele
per quella di un giovane morto di peste, mettendo
il cadaverino di un fanciullo dove il Sacchi aveva
messo un vello di pecora.
Ritornando, ora, ai libri mastri del Card. Antonio
iun., quello segnato D, che, va dal 1643 al 1650,
contiene poche notizie sul Sacchi, probabilmente
perchè il Cardinale, fuggito da Roma in Francia,
dopo la elezione di Innocenzo X, non aveva nè
voglia, nè modo di farfare grandi lavori artistici
Troviamo però il Sacchi pagare il trasporto di un
busto d'alabastro con testa di metallo (fatto da
Orfeo Buselli), far rimuovere statue,1 comprare
sei croci di pero e farvi dipingere sei Cristi donati
alle Ecc.me S." Moniche, cioè alle due carmeli-
tane, sorelle del Cardinale.2 Nel 1648 il Sacchi
faceva fare, d'ord. di S. Em.za, delle pitture p. li
P.ri Capuccini di Portuis in Provenza, pitture che
gli davano ancora da fare nel 1649.3
Dal libro di Entrata e Uscita di D. Francesco
Monticelli dall'anno 1652 a tutto li 26 novembre
1653,* ricaviamo una quantità di piccole notizie
sul Sacchi, al quale, per esempio, furono mandate
robbe magnative alle j fontane, quando vi fu una
giornata intiera.^ Ai 9 agosto 1653 troviamo che
Paolo Naldini aveva collaborato al restauro e al
ritocco degli Ermisini di color celeste. Ora, Paolo
Naldini, secondo il Pascoli,6 venne consigliato
da Carlo Maratta, suo collega alla scuola del Sacchi
a darsi alla scultura, entrando nell'orbita del Ber-
nini, per cui lavorò, fra l'altro, a due statue del
1 Pag. 93, 14 marzo 1645.
3 Pag. 94, 30 ottobre 1645.
3 Pag. 137, 10 luglio 1645; 20 marzo 1649.
4 Arch. Barberini, III, 9, V.
5 Giugno 1653.
6 Vita di Paolo A aldini.
VArtt. XXVII, 10.
73
tico a quello del S. Bonaventura nella Chiesa dei
Cappuccini.
Segue, a pagg. 17-18, la descrizione del ritiatto
di Monsignor Merlini, Uditore di Ruota, del quale
abbiamo già trattato a lungo più sopra.
Curiosa e veramente inattesa è la notizia, delle
pagine 18-19, di « un' quadro, con una cagna detta
tigre sopra un' cuscino, con una sonagliera di mano
del sig. Andrea Sacchi, con cornice tinta di noce
filettata d'oro », esistente, allora, nella stanza pas-
sata la sala per li palafrenieri nell'apartamento da
basso di S. Em.za. Sarebbe interessante vedere
come il Sacchi avesse interpretato questo ritratto
canino. In generale, nelle sue composizioni man-
cano gli animali; ma nella Festa al Gesù egli rivela
molta bravura nel ritrarre i cavalli, ed il muletto
insonnolito della sedia papale è veramente colto
con grande spirito.
Fortunatamente, esiste ancoia in casa Barbe-
rini il quadro che era nella stanza del parnasso (pa-
gine 23-34) "con un' S. Pietro in piedi, con un' libro
nella sinistra, e la destra che l'accenna, di mano del
Sigr Andrea Sacchi, con cornice intagliata tutta do-
rata » Insieme a questa tela ne esistono altre sei del
Maratta, ritraenti altri Apostoli. Evidentemente, a
questa serie si riferisce una notizia, un po' inesatta,
del Bellori, il quale dice che il Cardinale Antonio
iun. aveva ordinato al Sacchi una serie di quadri,
con figure più del naturale, del Redentore e dei
dodici Apostoli. Il Sacchi avrebbe dipinto solo il
Redentore e Carlo Maratta avrebbe fatto altre sei
tele con altrettanti Apostoli. Effettivamente, esi-
stono sei Apostoli del Maratta, come dissi, ma non
il Salvatore del Sacchi, mentre il S. Pietro, che il
Bellori non cita affatto, per la notizia dell'Inven-
tario e per la grandissima somiglianza con il quadro
di Forlì, deve essere riconosciuto per opera certa
del nostro pittore. Identica è la figura del Santo
nel quadro forlivese e nel quadro romano; in questo
manca, però, completamente, lo sfondo, che dà al
quadro di Forlì un così grande carattere di novità
nell'opera del Sacchi. Nella tela barberiniana, la
figura, fiammeggiante nel manto giallo, dal cranio
calvo e lucente, pare staccarsi dal fondo oscuro e
balzar verso di noi, nell'impeto della predicazione;
non solo, ma la mancanza dell'angeletto volante,
che serviva ad animare la parte alta del quadro
di Forlì, è a tutto vantaggio della figura poderosa
dell'Apostolo, che, nel suo isolamento sul fondo
oscuro, acquista una grandiosità ed un'evidenza
che non ha nel vasto scenario dello stendardo dei
Battuti.
Nell'ultima stanza, accanto alla libraria (pagine
38-40) c'era, infine, « un quadro sopraporto di Ada-
mo, che piange Abele ucciso da Caino, di mano del
Sig.r Andrea Sacchi, con cornice tutta dorata ».
Questo è, con tutta probabilità, per non dire certez-
za,quello esposto nella Galleria Barberini. Questo
quadro godette di una grande celebrità e di molta
ammirazione, poiché ne furono fatte parecchie re-
pliche, ma non è certo uno dei migliori del Sacchi.
Il tipo dell' Adamo è frequente nell'opera sacchiana
e la posa, che fa vedere tutta una spalla e parte
della schiena di scorcio, è uno dei motivi preferiti
di Andrea. Il contrasto fra la carnagione abbron-
zata e le chiome fitte e scure del padre, con le carni
lattee ed i capelli quasi biondi del figlio è notevo-
lissimo del quadro di Icaro che si lascia legare un'ala
da Dedalo del quale esistono due repliche, una a
Roma, nella Galleria Doria Pamphily, l'altra a
Genova, in Palazzo Rosso.
È curioso notare come Carlo Maratta, nel suo
quadro di S. Rosalia che impetra la cessazione del Ut
peste, dipinto per la cappella Barberini a Palestrina,
abbia copiato, più che imitato, la figura dell' Abele
per quella di un giovane morto di peste, mettendo
il cadaverino di un fanciullo dove il Sacchi aveva
messo un vello di pecora.
Ritornando, ora, ai libri mastri del Card. Antonio
iun., quello segnato D, che, va dal 1643 al 1650,
contiene poche notizie sul Sacchi, probabilmente
perchè il Cardinale, fuggito da Roma in Francia,
dopo la elezione di Innocenzo X, non aveva nè
voglia, nè modo di farfare grandi lavori artistici
Troviamo però il Sacchi pagare il trasporto di un
busto d'alabastro con testa di metallo (fatto da
Orfeo Buselli), far rimuovere statue,1 comprare
sei croci di pero e farvi dipingere sei Cristi donati
alle Ecc.me S." Moniche, cioè alle due carmeli-
tane, sorelle del Cardinale.2 Nel 1648 il Sacchi
faceva fare, d'ord. di S. Em.za, delle pitture p. li
P.ri Capuccini di Portuis in Provenza, pitture che
gli davano ancora da fare nel 1649.3
Dal libro di Entrata e Uscita di D. Francesco
Monticelli dall'anno 1652 a tutto li 26 novembre
1653,* ricaviamo una quantità di piccole notizie
sul Sacchi, al quale, per esempio, furono mandate
robbe magnative alle j fontane, quando vi fu una
giornata intiera.^ Ai 9 agosto 1653 troviamo che
Paolo Naldini aveva collaborato al restauro e al
ritocco degli Ermisini di color celeste. Ora, Paolo
Naldini, secondo il Pascoli,6 venne consigliato
da Carlo Maratta, suo collega alla scuola del Sacchi
a darsi alla scultura, entrando nell'orbita del Ber-
nini, per cui lavorò, fra l'altro, a due statue del
1 Pag. 93, 14 marzo 1645.
3 Pag. 94, 30 ottobre 1645.
3 Pag. 137, 10 luglio 1645; 20 marzo 1649.
4 Arch. Barberini, III, 9, V.
5 Giugno 1653.
6 Vita di Paolo A aldini.
VArtt. XXVII, 10.