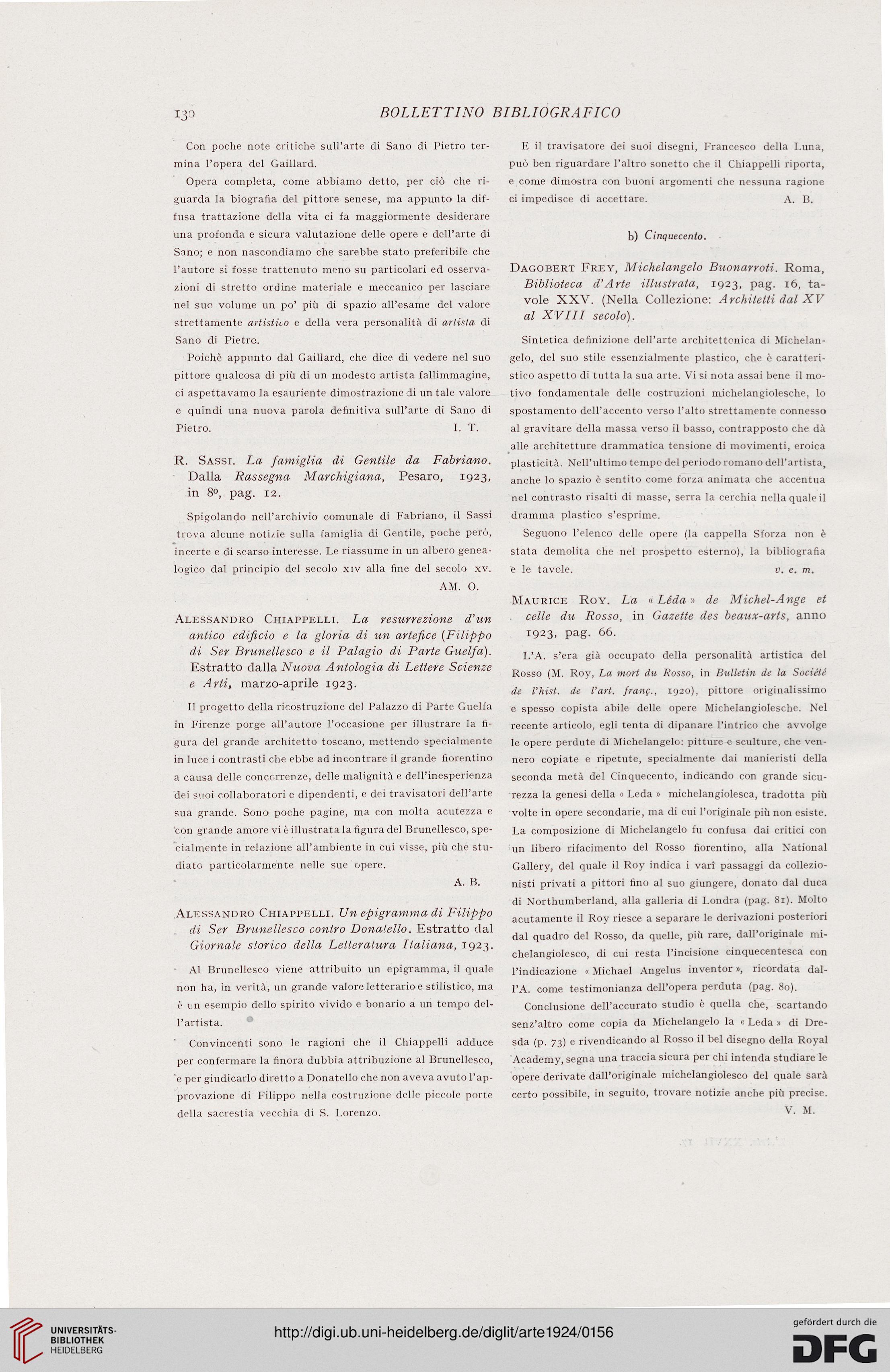BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
130
Con poche note critiche sull'arte di Sano di Pietro ter-
mina l'opera del Gaillard.
Opera completa, come abbiamo detto, per ciò che ri-
guarda la biografia del pittore senese, ma appunto la dif-
fusa trattazione della vita ci fa maggiormente desiderare
una profonda e sicura valutazione delle opere e dell'arte di
Sano; e non nascondiamo che sarebbe stato preferibile che
l'autore si fosse trattenuto meno su particolari ed osserva-
zioni di stretto ordine materiale e meccanico per lasciare
nel suo volume un po' più di spazio all'esame del valore
strettamente artistico e della vera personalità di artista di
Sano di Pietro.
Poiché appunto dal Gaillard, che dice di vedere nel suo
pittore qualcosa di più di un modesto artista fallimmagine,
ci aspettavamo la esauriente dimostrazione di un tale valore
e quindi una nuova parola definitiva sull'arte di Sano di
Pietro. 1. T.
R. Sassi. La famiglia di Gentile da Fabriano.
Dalla Rassegna Marchigiana, Pesaro, 1923,
in 8°, pag. 12.
Spigolando nell'archivio comunale di Fabriano, il Sassi
trova alcune notizie sulla famiglia di Gentile, poche però,
incerte e di scarso interesse. Le riassume in un albero genea-
logico dal principio del secolo xiv alla fine del secolo xv.
AM. O.
Alessandro Chiappelli. La resurrezione d'un
antico edificio e la gloria di un artefice {Filippo
di Ser Brunellesco e il Palagio di Parte Guelfa).
Estratto dalla Nuova Antologia di Lettere Scienze
e Arti, marzo-aprile 1923.
Il progetto della ricostruzione del Palazzo di Parte Guelfa
in Firenze porge all'autore l'occasione per illustrare la fi-
gura del grande architetto toscano, mettendo specialmente
in luce i contrasti che ebbe ad incontrare il grande fiorentino
a causa delle concorrenze, delle malignità e dell'inesperienza
dei suoi collaboratori e dipendenti, e dei travisatori dell'arte
sua grande. Sono poche pagine, ma con molta acutezza e
'con grande amore vi è illustrata la figura del Brunellesco, spe-
cialmente in relazione all'ambiente in cui visse, più che stu-
diato particolarmente nelle sue opere.
A. I!.
Alessandro Chiappelli. Un epigramma di Filippo
di Ser Brunellesco contro Donatello. Estratto dal
Giornale storico della Letteratura Italiana, 1923.
Al Brunellesco viene attribuito un epigramma, il quale
non ha, in verità, un grande valore letterario e stilistico, ma
è un esempio dello spirito vivido e bonario a un tempo del-
l'artista.
Convincenti sono le ragioni che il Chiappelli adduce
per confermare la finora dubbia attribuzione al Brunellesco,
"e per giudicarlo diretto a Donatello che non aveva avuto l'ap-
provazione di Filippo nella eostruzione delle piccole porte
della sacrestia vecchia di S. Lorenzo.
E il travisatore dei suoi disegni, Francesco della Luna,
può ben riguardare l'altro sonetto che il Chiappelli riporta,
e come dimostra con buoni argomenti che nessuna ragione
ci impedisce di accettare. A. B.
b) Cinquecento.
Dagobert Frey, Michelangelo Buonarroti. Roma,
Biblioteca d'Arte illustrata, 1923, pag. 16, ta-
vole XXV. (Nella Collezione: Architetti dal XV
al XVIII secolo).
Sintetica definizione dell'arte architettonica di Michelan-
gelo, del suo stile essenzialmente plastico, che è caratteri-
stico aspetto di tutta la sua arte. Vi si nota assai bene il mo-
tivo fondamentale delle costruzioni michelangiolesche, lo
spostamento dell'accento verso l'alto strettamente connesso
al gravitare della massa verso il basso, contrapposto che dà
alle architetture drammatica tensione di movimenti, eroica
plasticità. Nell'ultimo tempo del periodo romano dell'artista,
anche lo spazio è sentito come forza animata che accentua
nel contrasto risalti di masse, serra la cerchia nella quale il
dramma plastico s'esprime.
Seguono l'elenco delle opere (la cappella Sforza non è
stata demolita che nel prospetto esterno), la bibliografia
e le tavole. v. e. m.
Maurice Roy. La « Lèda » de Michel-Ange et
celle du Rosso, in Gazette des beaux-arts, anno
1923, pag. 66.
L'A. s'era già occupato della personalità artistica del
Rosso (M. Roy, ha mort du Rosso, in BulUtin de la Société
de l'hist. de l'art, frane., 1920), pittore originalissimo
e spesso copista abile delle opere Michelangiolesche. Nel
recente articolo, egli tenta di dipanare l'intrico che avvolge
le opere perdute di Michelangelo: pitture e sculture, che ven-
nero copiate e ripetute, specialmente dai manieristi della
seconda metà del Cinquecento, indicando con grande sicu-
rezza la genesi della « Leda » michelangiolesca, tradotta più
volte in opere secondarie, ma di cui l'originale più non esiste.
La composizione di Michelangelo fu confusa dai critici con
un libero rifacimento del Rosso fiorentino, alla National
Gallery, del quale il Roy indica i vari passaggi da collezio-
nisti privati a pittori fino al suo giungere, donato dal duca
di Northumberland, alla galleria di Londra (pag. 81). Molto
acutamente il Roy riesce a separare le derivazioni posteriori
dal quadro del Rosso, da quelle, più rare, dall'originale mi-
chelangiolesco, di cui resta l'incisione cinquecentesca con
l'indicazione « Michael Angelus inventor », ricordata dal-
l'A. come testimonianza dell'opera perduta (pag. 80).
Conclusione dell'accurato studio è quella che, scartando
senz'altro come copia da Michelangelo la « Leda » di Dre-
sda (p. 73) e rivendicando al Rosso il bel disegno della Royal
Academy, segna una traccia sicura per chi intenda studiare le
opere derivate dall'originale michelangiolesco del quale sarà
certo possibile, in seguito, trovare notizie anche più precise.
V. M.
130
Con poche note critiche sull'arte di Sano di Pietro ter-
mina l'opera del Gaillard.
Opera completa, come abbiamo detto, per ciò che ri-
guarda la biografia del pittore senese, ma appunto la dif-
fusa trattazione della vita ci fa maggiormente desiderare
una profonda e sicura valutazione delle opere e dell'arte di
Sano; e non nascondiamo che sarebbe stato preferibile che
l'autore si fosse trattenuto meno su particolari ed osserva-
zioni di stretto ordine materiale e meccanico per lasciare
nel suo volume un po' più di spazio all'esame del valore
strettamente artistico e della vera personalità di artista di
Sano di Pietro.
Poiché appunto dal Gaillard, che dice di vedere nel suo
pittore qualcosa di più di un modesto artista fallimmagine,
ci aspettavamo la esauriente dimostrazione di un tale valore
e quindi una nuova parola definitiva sull'arte di Sano di
Pietro. 1. T.
R. Sassi. La famiglia di Gentile da Fabriano.
Dalla Rassegna Marchigiana, Pesaro, 1923,
in 8°, pag. 12.
Spigolando nell'archivio comunale di Fabriano, il Sassi
trova alcune notizie sulla famiglia di Gentile, poche però,
incerte e di scarso interesse. Le riassume in un albero genea-
logico dal principio del secolo xiv alla fine del secolo xv.
AM. O.
Alessandro Chiappelli. La resurrezione d'un
antico edificio e la gloria di un artefice {Filippo
di Ser Brunellesco e il Palagio di Parte Guelfa).
Estratto dalla Nuova Antologia di Lettere Scienze
e Arti, marzo-aprile 1923.
Il progetto della ricostruzione del Palazzo di Parte Guelfa
in Firenze porge all'autore l'occasione per illustrare la fi-
gura del grande architetto toscano, mettendo specialmente
in luce i contrasti che ebbe ad incontrare il grande fiorentino
a causa delle concorrenze, delle malignità e dell'inesperienza
dei suoi collaboratori e dipendenti, e dei travisatori dell'arte
sua grande. Sono poche pagine, ma con molta acutezza e
'con grande amore vi è illustrata la figura del Brunellesco, spe-
cialmente in relazione all'ambiente in cui visse, più che stu-
diato particolarmente nelle sue opere.
A. I!.
Alessandro Chiappelli. Un epigramma di Filippo
di Ser Brunellesco contro Donatello. Estratto dal
Giornale storico della Letteratura Italiana, 1923.
Al Brunellesco viene attribuito un epigramma, il quale
non ha, in verità, un grande valore letterario e stilistico, ma
è un esempio dello spirito vivido e bonario a un tempo del-
l'artista.
Convincenti sono le ragioni che il Chiappelli adduce
per confermare la finora dubbia attribuzione al Brunellesco,
"e per giudicarlo diretto a Donatello che non aveva avuto l'ap-
provazione di Filippo nella eostruzione delle piccole porte
della sacrestia vecchia di S. Lorenzo.
E il travisatore dei suoi disegni, Francesco della Luna,
può ben riguardare l'altro sonetto che il Chiappelli riporta,
e come dimostra con buoni argomenti che nessuna ragione
ci impedisce di accettare. A. B.
b) Cinquecento.
Dagobert Frey, Michelangelo Buonarroti. Roma,
Biblioteca d'Arte illustrata, 1923, pag. 16, ta-
vole XXV. (Nella Collezione: Architetti dal XV
al XVIII secolo).
Sintetica definizione dell'arte architettonica di Michelan-
gelo, del suo stile essenzialmente plastico, che è caratteri-
stico aspetto di tutta la sua arte. Vi si nota assai bene il mo-
tivo fondamentale delle costruzioni michelangiolesche, lo
spostamento dell'accento verso l'alto strettamente connesso
al gravitare della massa verso il basso, contrapposto che dà
alle architetture drammatica tensione di movimenti, eroica
plasticità. Nell'ultimo tempo del periodo romano dell'artista,
anche lo spazio è sentito come forza animata che accentua
nel contrasto risalti di masse, serra la cerchia nella quale il
dramma plastico s'esprime.
Seguono l'elenco delle opere (la cappella Sforza non è
stata demolita che nel prospetto esterno), la bibliografia
e le tavole. v. e. m.
Maurice Roy. La « Lèda » de Michel-Ange et
celle du Rosso, in Gazette des beaux-arts, anno
1923, pag. 66.
L'A. s'era già occupato della personalità artistica del
Rosso (M. Roy, ha mort du Rosso, in BulUtin de la Société
de l'hist. de l'art, frane., 1920), pittore originalissimo
e spesso copista abile delle opere Michelangiolesche. Nel
recente articolo, egli tenta di dipanare l'intrico che avvolge
le opere perdute di Michelangelo: pitture e sculture, che ven-
nero copiate e ripetute, specialmente dai manieristi della
seconda metà del Cinquecento, indicando con grande sicu-
rezza la genesi della « Leda » michelangiolesca, tradotta più
volte in opere secondarie, ma di cui l'originale più non esiste.
La composizione di Michelangelo fu confusa dai critici con
un libero rifacimento del Rosso fiorentino, alla National
Gallery, del quale il Roy indica i vari passaggi da collezio-
nisti privati a pittori fino al suo giungere, donato dal duca
di Northumberland, alla galleria di Londra (pag. 81). Molto
acutamente il Roy riesce a separare le derivazioni posteriori
dal quadro del Rosso, da quelle, più rare, dall'originale mi-
chelangiolesco, di cui resta l'incisione cinquecentesca con
l'indicazione « Michael Angelus inventor », ricordata dal-
l'A. come testimonianza dell'opera perduta (pag. 80).
Conclusione dell'accurato studio è quella che, scartando
senz'altro come copia da Michelangelo la « Leda » di Dre-
sda (p. 73) e rivendicando al Rosso il bel disegno della Royal
Academy, segna una traccia sicura per chi intenda studiare le
opere derivate dall'originale michelangiolesco del quale sarà
certo possibile, in seguito, trovare notizie anche più precise.
V. M.