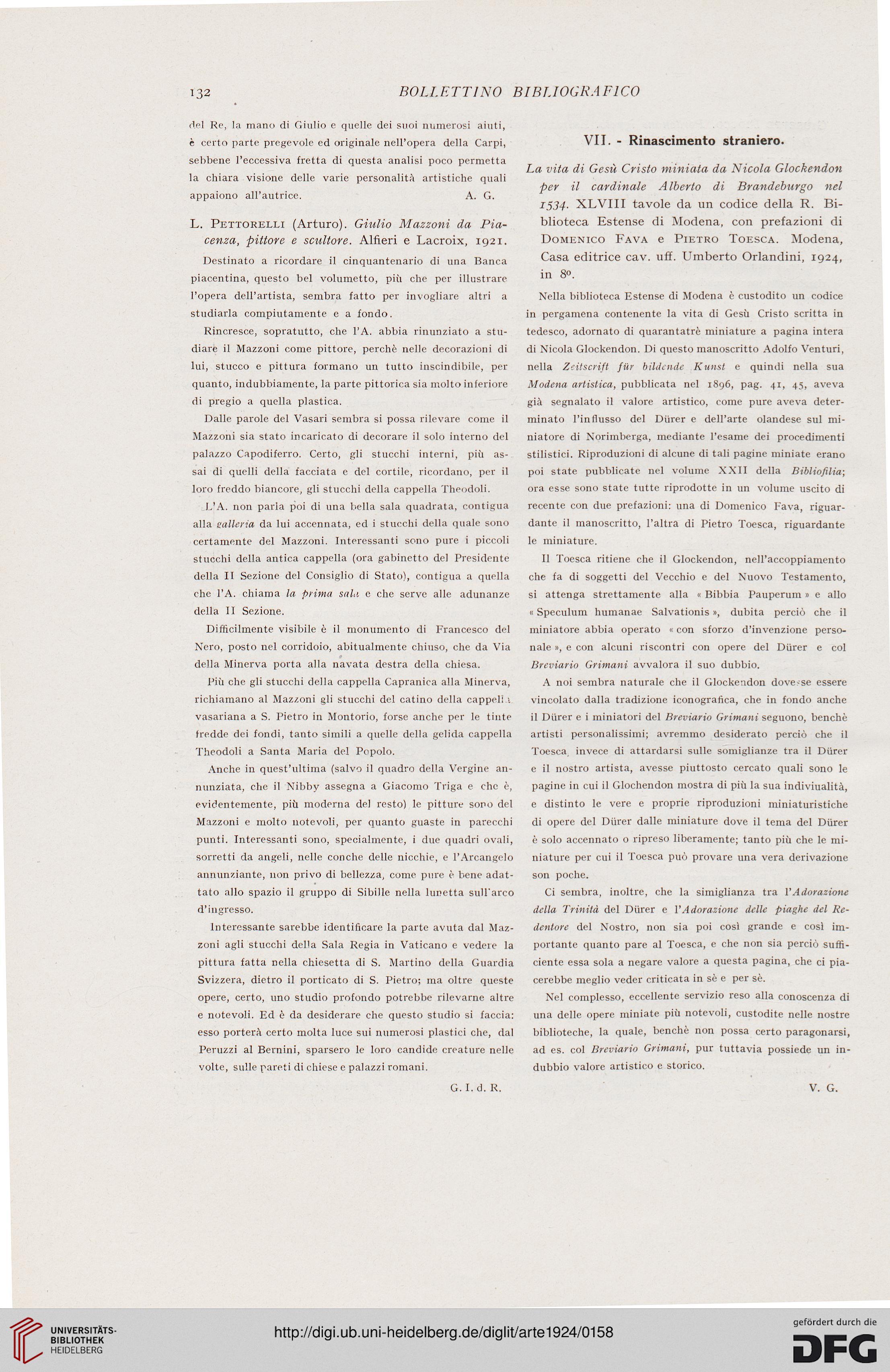132
BOLLETTINO BIRLIOGKA FI CO
('<'! Re, la mano di Giulio e quelle dei suoi numerosi aiuti,
è certo parte pregevole ed originale nell'opera della Carpi,
sebbene l'eccessiva fretta di questa analisi poco permetta
la chiara visione delle varie personalità artistiche quali
appaiono all'autrice. A. G.
L. Pettorelli (Arturo). Giulio Mazzoni da Pia-
cenza, pittore e scultore. Alfieri e Lacroix, 1921.
Destinato a ricordare il cinquantenario di una Banca
piacentina, questo bel volumetto, più che per illustrare
l'opera dell'artista, sembra fatto per invogliare altri a
studiarla compiutamente e a fondo.
Rincresce, sopratutto, che l'A. abbia rinunziato a stu-
diare il Mazzoni come pittore, perchè nelle decorazioni di
lui, stucco e pittura formano un tutto inscindibile, per
quanto, indubbiamente, la parte pittorica sia molto inferiore
di pregio a quella plastica.
Dalle parole del Vasari sembra si possa rilevare come il
Mazzoni sia stato incaricato di decorare il solo interno del
palazzo Capodiferro. Certo, gli stucchi interni, più as-
sai di quelli della facciata e del cortile, ricordano, per il
loro freddo biancore, gli stucchi della cappella Theodoli.
L'A. non paria poi di una bella sala quadrata, contigua
alla galleria da lui accennata, ed i stucchi della quale sono
certamente del Mazzoni. Interessanti sono pure i piccoli
stucchi della antica cappella (ora gabinetto del Presidente
della II Sezione del Consiglio di Stato), contigua a quella
che l'A. chiama la prima sala e che serve alle adunanze
della II Sezione.
Difficilmente visibile è il monumento di Francesco del
Nero, posto nel corridoio, abitualmente chiuso, che da Via
della Minerva porta alla navata destra della chiesa.
Più che gli stucchi della cappella Capranica alla Minerva,
richiamano al Mazzoni gli stucchi del catino della cappell i
vasariana a S. Pietro in Montorio, forse anche per le tinte
fredde dei fondi, tanto simili a quelle della gelida cappella
Theodoli a Santa Maria del Popolo.
Anche in quest'ultima (salvo il quadro della Vergine an-
nunziata, che il Nibby assegna a Giacomo Triga e che è,
evidentemente, più moderna del resto) le pitture sono del
Mazzoni e molto notevoli, per quanto guaste in parecchi
punti. Interessanti sono, specialmente, i due quadri ovali,
sorretti da angeli, nelle conche delle nicchie, e l'Arcangelo
annunziante, non privo di bellezza, come pure è bene adat-
tato allo spazio il gruppo di Sibille nella lunetta sull'arco
d'ingresso.
Interessante sarebbe identificare la parte avuta dal Maz-
zoni agli stucchi della Sala Regia in Vaticano e vedere la
pittura fatta nella chiesetta di S. Martino della Guardia
Svizzera, dietro il porticato di S. Pietro; ma oltre queste
opere, certo, uno studio profondo potrebbe rilevarne altre
e notevoli. Ed è da desiderare che questo studio si faccia:
esso porterà certo molta luce sui numerosi plastici che, dal
Peruzzi al Bernini, sparsero le loro candide creature nelle
volte, sulle pareti di chiese e palazzi romani.
G. I. d. R.
VII. - Rinascimento straniero.
La vita di Gesù Cristo miniata da Nicola Glockendon
per il cardinale Alberto di Brandeburgo nel
1534. XLVIII tavole da un codice della R. Bi-
blioteca Estense di Modena, con prefazioni di
Domenico Fava e Pietro Toesca. Modena,
Casa editrice cav. uff. Umberto Orlandini, 1924,
in 8°.
Nella biblioteca Estense di Modena è custodito un codice
in pergamena contenente la vita di Gesù Cristo scritta in
tedesco, adornato di quarantatre miniature a pagina intera
di Nicola Glockendon. Di questo manoscritto Adolfo Venturi,
nella ZHtscrifl fiir bildende Kunsi e quindi nella sua
Modena artistica, pubblicata nel 1896, pag. 41, 45, aveva
già segnalato il valore artistico, come pure aveva deter-
minato l'influsso del Dùrer e dell'arte olandese sul mi-
niatore di Norimberga, mediante l'esame dei procedimenti
stilistici. Riproduzioni di alcune di tali pagine miniate erano
poi state pubblicate nel volume XXII della Bibliofilia;
ora esse sono state tutte riprodotte in un volume uscito di
recente con due prefazioni: una di Domenico Fava, riguar-
dante il manoscritto, l'altra di Pietro Toesca, riguardante
le miniature.
Il Toesca ritiene che il Glockendon, nell'accoppiamento
che fa di soggetti del Vecchio e del Nuovo Testamento,
si attenga strettamente alla « Bibbia Pauperum » e allo
« Speculum humanae Salvationis », dubita perciò che il
miniatore abbia operato « con sforzo d'invenzione perso-
nale », e con alcuni riscontri con opere del Durer e col
Breviario Grimani avvalora il suo dubbio.
A noi sembra naturale che il Glockendon dove-se essere
vincolato dalla tradizione iconografica, che in fondo anche
il Dùrer e i miniatori del Breviario Grimani seguono, benché
artisti personalissimi; avremmo desiderato perciò che il
Toesca invece di attardarsi sulle somiglianze tra il Dùrer
e il nostro artista, avesse piuttosto cercato quali sono le
pagine in cui il Glochendon mostra di più la sua indiviualità,
e distinto le vere e proprie riproduzioni miniaturistiche
di opere del Dùrer dalle miniature dove il tema del Dùrer
è solo accennato o ripreso liberamente; tanto più che le mi-
niature per cui il Toesca può provare una vera derivazione
son poche.
Ci sembra, inoltre, che la simiglianza tra l'Adorazione
della Trinità del Dùrer e VAdorazione delle piaghe del Re-
dentore del Nostro, non sia poi cosi grande e cosi im-
portante quanto pare al Toesca, e che non sia perciò suffi-
ciente essa sola a negare valore a questa pagina, che ci pia-
cerebbe meglio veder criticata in sè e per sè.
Nel complesso, eccellente servizio reso alla conoscenza di
una delle opere miniate più notevoli, custodite nelle nostre
biblioteche, la quale, benché non possa certo paragonarsi,
ad es. col Breviario Grimani, pur tuttavia possiede un in-
dubbio valore artistico e storico.
V. G.
BOLLETTINO BIRLIOGKA FI CO
('<'! Re, la mano di Giulio e quelle dei suoi numerosi aiuti,
è certo parte pregevole ed originale nell'opera della Carpi,
sebbene l'eccessiva fretta di questa analisi poco permetta
la chiara visione delle varie personalità artistiche quali
appaiono all'autrice. A. G.
L. Pettorelli (Arturo). Giulio Mazzoni da Pia-
cenza, pittore e scultore. Alfieri e Lacroix, 1921.
Destinato a ricordare il cinquantenario di una Banca
piacentina, questo bel volumetto, più che per illustrare
l'opera dell'artista, sembra fatto per invogliare altri a
studiarla compiutamente e a fondo.
Rincresce, sopratutto, che l'A. abbia rinunziato a stu-
diare il Mazzoni come pittore, perchè nelle decorazioni di
lui, stucco e pittura formano un tutto inscindibile, per
quanto, indubbiamente, la parte pittorica sia molto inferiore
di pregio a quella plastica.
Dalle parole del Vasari sembra si possa rilevare come il
Mazzoni sia stato incaricato di decorare il solo interno del
palazzo Capodiferro. Certo, gli stucchi interni, più as-
sai di quelli della facciata e del cortile, ricordano, per il
loro freddo biancore, gli stucchi della cappella Theodoli.
L'A. non paria poi di una bella sala quadrata, contigua
alla galleria da lui accennata, ed i stucchi della quale sono
certamente del Mazzoni. Interessanti sono pure i piccoli
stucchi della antica cappella (ora gabinetto del Presidente
della II Sezione del Consiglio di Stato), contigua a quella
che l'A. chiama la prima sala e che serve alle adunanze
della II Sezione.
Difficilmente visibile è il monumento di Francesco del
Nero, posto nel corridoio, abitualmente chiuso, che da Via
della Minerva porta alla navata destra della chiesa.
Più che gli stucchi della cappella Capranica alla Minerva,
richiamano al Mazzoni gli stucchi del catino della cappell i
vasariana a S. Pietro in Montorio, forse anche per le tinte
fredde dei fondi, tanto simili a quelle della gelida cappella
Theodoli a Santa Maria del Popolo.
Anche in quest'ultima (salvo il quadro della Vergine an-
nunziata, che il Nibby assegna a Giacomo Triga e che è,
evidentemente, più moderna del resto) le pitture sono del
Mazzoni e molto notevoli, per quanto guaste in parecchi
punti. Interessanti sono, specialmente, i due quadri ovali,
sorretti da angeli, nelle conche delle nicchie, e l'Arcangelo
annunziante, non privo di bellezza, come pure è bene adat-
tato allo spazio il gruppo di Sibille nella lunetta sull'arco
d'ingresso.
Interessante sarebbe identificare la parte avuta dal Maz-
zoni agli stucchi della Sala Regia in Vaticano e vedere la
pittura fatta nella chiesetta di S. Martino della Guardia
Svizzera, dietro il porticato di S. Pietro; ma oltre queste
opere, certo, uno studio profondo potrebbe rilevarne altre
e notevoli. Ed è da desiderare che questo studio si faccia:
esso porterà certo molta luce sui numerosi plastici che, dal
Peruzzi al Bernini, sparsero le loro candide creature nelle
volte, sulle pareti di chiese e palazzi romani.
G. I. d. R.
VII. - Rinascimento straniero.
La vita di Gesù Cristo miniata da Nicola Glockendon
per il cardinale Alberto di Brandeburgo nel
1534. XLVIII tavole da un codice della R. Bi-
blioteca Estense di Modena, con prefazioni di
Domenico Fava e Pietro Toesca. Modena,
Casa editrice cav. uff. Umberto Orlandini, 1924,
in 8°.
Nella biblioteca Estense di Modena è custodito un codice
in pergamena contenente la vita di Gesù Cristo scritta in
tedesco, adornato di quarantatre miniature a pagina intera
di Nicola Glockendon. Di questo manoscritto Adolfo Venturi,
nella ZHtscrifl fiir bildende Kunsi e quindi nella sua
Modena artistica, pubblicata nel 1896, pag. 41, 45, aveva
già segnalato il valore artistico, come pure aveva deter-
minato l'influsso del Dùrer e dell'arte olandese sul mi-
niatore di Norimberga, mediante l'esame dei procedimenti
stilistici. Riproduzioni di alcune di tali pagine miniate erano
poi state pubblicate nel volume XXII della Bibliofilia;
ora esse sono state tutte riprodotte in un volume uscito di
recente con due prefazioni: una di Domenico Fava, riguar-
dante il manoscritto, l'altra di Pietro Toesca, riguardante
le miniature.
Il Toesca ritiene che il Glockendon, nell'accoppiamento
che fa di soggetti del Vecchio e del Nuovo Testamento,
si attenga strettamente alla « Bibbia Pauperum » e allo
« Speculum humanae Salvationis », dubita perciò che il
miniatore abbia operato « con sforzo d'invenzione perso-
nale », e con alcuni riscontri con opere del Durer e col
Breviario Grimani avvalora il suo dubbio.
A noi sembra naturale che il Glockendon dove-se essere
vincolato dalla tradizione iconografica, che in fondo anche
il Dùrer e i miniatori del Breviario Grimani seguono, benché
artisti personalissimi; avremmo desiderato perciò che il
Toesca invece di attardarsi sulle somiglianze tra il Dùrer
e il nostro artista, avesse piuttosto cercato quali sono le
pagine in cui il Glochendon mostra di più la sua indiviualità,
e distinto le vere e proprie riproduzioni miniaturistiche
di opere del Dùrer dalle miniature dove il tema del Dùrer
è solo accennato o ripreso liberamente; tanto più che le mi-
niature per cui il Toesca può provare una vera derivazione
son poche.
Ci sembra, inoltre, che la simiglianza tra l'Adorazione
della Trinità del Dùrer e VAdorazione delle piaghe del Re-
dentore del Nostro, non sia poi cosi grande e cosi im-
portante quanto pare al Toesca, e che non sia perciò suffi-
ciente essa sola a negare valore a questa pagina, che ci pia-
cerebbe meglio veder criticata in sè e per sè.
Nel complesso, eccellente servizio reso alla conoscenza di
una delle opere miniate più notevoli, custodite nelle nostre
biblioteche, la quale, benché non possa certo paragonarsi,
ad es. col Breviario Grimani, pur tuttavia possiede un in-
dubbio valore artistico e storico.
V. G.