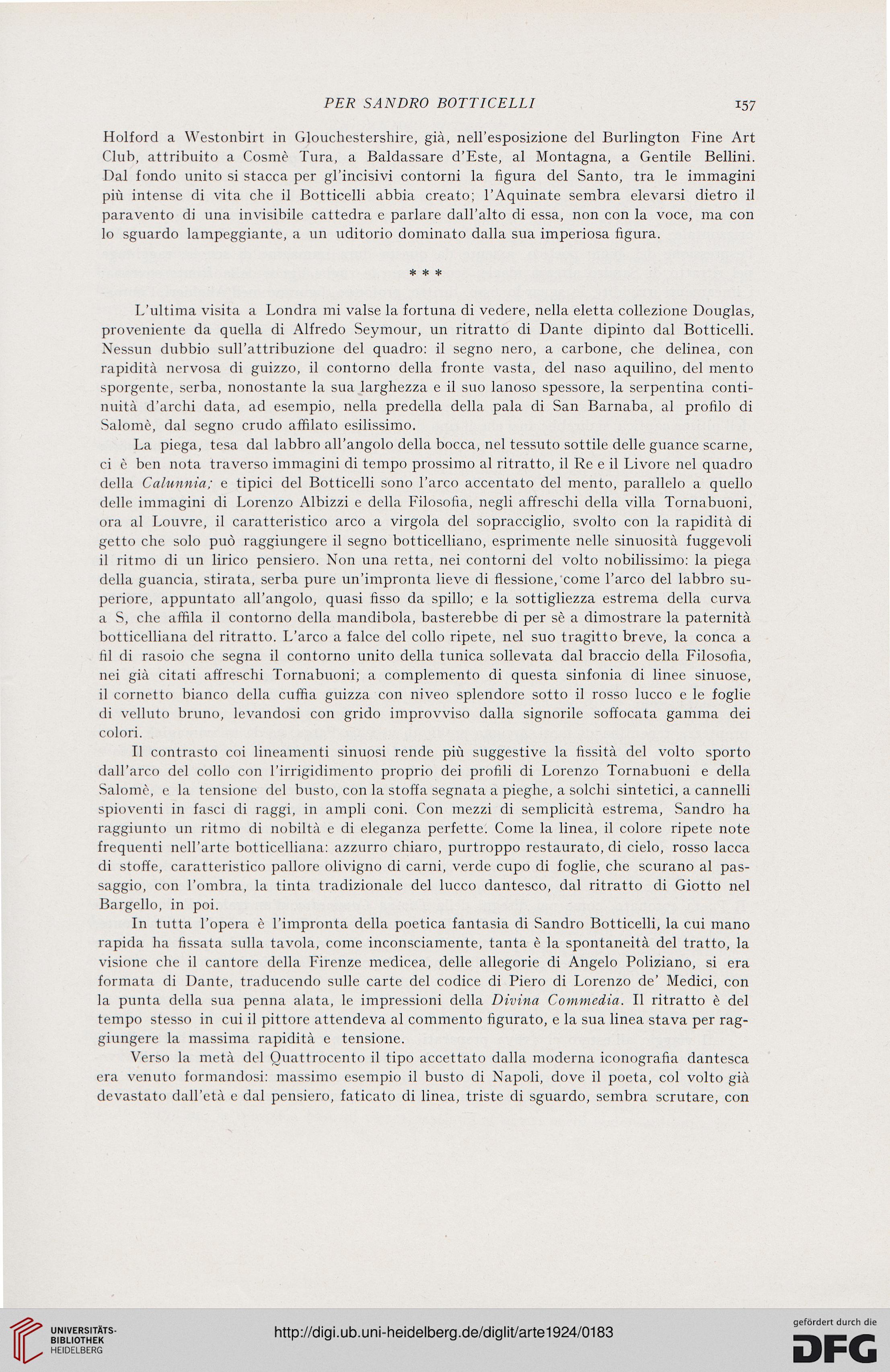PER SANDRO BOTTICELLI
157
Holford a Westonbirt in Glouchestershire, già, nell'esposizione del Burlington Fine Art
Club, attribuito a Cosmè Tura, a Baldassare d'Este, al Montagna, a Gentile Bellini.
Dal fondo unito si stacca per gl'incisivi contorni la figura del Santo, tra le immagini
più intense di vita che il Botticelli abbia creato; l'Aquinate sembra elevarsi dietro il
paravento di una invisibile cattedra e parlare dall'alto di essa, non con la voce, ma con
10 sguardo lampeggiante, a un uditorio dominato dalla sua imperiosa figura.
* * *
L'ultima visita a Londra mi valse la fortuna di vedere, nella eletta collezione Douglas,
proveniente da quella di Alfredo Seymour, un ritratto di Dante dipinto dal Botticelli.
Nessun dubbio sull'attribuzione del quadro: il segno nero, a carbone, che delinea, con
rapidità nervosa di guizzo, il contorno della fronte vasta, del naso aquilino, del mento
sporgente, serba, nonostante la sua larghezza e il suo lanoso spessore, la serpentina conti-
nuità d'archi data, ad esempio, nella predella della pala di San Barnaba, al profilo di
Salomè, dal segno crudo affilato esilissimo.
La piega, tesa dal labbro all'angolo della bocca, nel tessuto sottile delle guance scarne,
ci è ben nota traverso immagini di tempo prossimo al ritratto, il Re e il Livore nel quadro
della Calunnia; e tipici del Botticelli sono l'arco accentato del mento, parallelo a quello
delle immagini di Lorenzo Albizzi e della Filosofia, negli affreschi della villa Tornabuoni,
ora al Louvre, il caratteristico arco a virgola del sopracciglio, svolto con la rapidità di
getto che solo può raggiungere il segno botticelliano, esprimente nelle sinuosità fuggevoli
11 ritmo di un lirico pensiero. Non una retta, nei contorni del volto nobilissimo: la piega
della guancia, stirata, serba pure un'impronta lieve di flessione, come l'arco del labbro su-
periore, appuntato all'angolo, quasi fisso da spillo; e la sottigliezza estrema della curva
a S, che affila il contorno della mandibola, basterebbe di per sè a dimostrare la paternità
botticelliana del ritratto. L'arco a falce del collo ripete, nel suo tragitto breve, la conca a
lìl di rasoio che segna il contorno unito della tunica sollevata dal braccio della Filosofia,
nei già citati affreschi Tornabuoni; a complemento di questa sinfonia di linee sinuose,
il cornetto bianco della cuffia guizza con niveo splendore sotto il rosso lucco e le foglie
ili velluto bruno, levandosi con grido improvviso dalla signorile soffocata gamma dei
colori.
Il contrasto coi lineamenti sinuosi rende più suggestive la fissità del volto sporto
dall'arco del collo con l'irrigidimento proprio dei profili di Lorenzo Tornabuoni e della
Salomè, e la tensione del busto, con la stoffa segnata a pieghe, a solchi sintetici, a cannelli
spioventi in fasci di raggi, in ampli coni. Con mezzi di semplicità estrema, Sandro ha
raggiunto un ritmo di nobiltà e di eleganza perfette. Come la linea, il colore ripete note
frequenti nell'arte botticelliana: azzurro chiaro, purtroppo restaurato, di cielo, rosso lacca
di stoffe, caratteristico pallore olivigno di carni, verde cupo di foglie, che scurano al pas-
saggio, con l'ombra, la tinta tradizionale del lucco dantesco, dal ritratto di Giotto nel
Bargello, in poi.
In tutta l'opera è l'impronta della poetica fantasia di Sandro Botticelli, la cui mano
rapida ha fissata sulla tavola, come inconsciamente, tanta è la spontaneità del tratto, la
visione che il cantore della Firenze medicea, delle allegorie di Angelo Poliziano, si era
formata di Dante, traducendo sulle carte del codice di Piero di Lorenzo de' Medici, con
la punta della sua penna alata, le impressioni della Divina Commedia. Il ritratto è del
tempo stesso in cui il pittore attendeva al commento figurato, e la sua linea stava per rag-
giungere la massima rapidità e tensione.
Verso la metà del Quattrocento il tipo accettato dalla moderna iconografia dantesca
era venuto formandosi: massimo esempio il busto di Napoli, dove il poeta, col volto già
devastato dall'età e dal pensiero, faticato di linea, triste di sguardo, sembra scrutare, con
157
Holford a Westonbirt in Glouchestershire, già, nell'esposizione del Burlington Fine Art
Club, attribuito a Cosmè Tura, a Baldassare d'Este, al Montagna, a Gentile Bellini.
Dal fondo unito si stacca per gl'incisivi contorni la figura del Santo, tra le immagini
più intense di vita che il Botticelli abbia creato; l'Aquinate sembra elevarsi dietro il
paravento di una invisibile cattedra e parlare dall'alto di essa, non con la voce, ma con
10 sguardo lampeggiante, a un uditorio dominato dalla sua imperiosa figura.
* * *
L'ultima visita a Londra mi valse la fortuna di vedere, nella eletta collezione Douglas,
proveniente da quella di Alfredo Seymour, un ritratto di Dante dipinto dal Botticelli.
Nessun dubbio sull'attribuzione del quadro: il segno nero, a carbone, che delinea, con
rapidità nervosa di guizzo, il contorno della fronte vasta, del naso aquilino, del mento
sporgente, serba, nonostante la sua larghezza e il suo lanoso spessore, la serpentina conti-
nuità d'archi data, ad esempio, nella predella della pala di San Barnaba, al profilo di
Salomè, dal segno crudo affilato esilissimo.
La piega, tesa dal labbro all'angolo della bocca, nel tessuto sottile delle guance scarne,
ci è ben nota traverso immagini di tempo prossimo al ritratto, il Re e il Livore nel quadro
della Calunnia; e tipici del Botticelli sono l'arco accentato del mento, parallelo a quello
delle immagini di Lorenzo Albizzi e della Filosofia, negli affreschi della villa Tornabuoni,
ora al Louvre, il caratteristico arco a virgola del sopracciglio, svolto con la rapidità di
getto che solo può raggiungere il segno botticelliano, esprimente nelle sinuosità fuggevoli
11 ritmo di un lirico pensiero. Non una retta, nei contorni del volto nobilissimo: la piega
della guancia, stirata, serba pure un'impronta lieve di flessione, come l'arco del labbro su-
periore, appuntato all'angolo, quasi fisso da spillo; e la sottigliezza estrema della curva
a S, che affila il contorno della mandibola, basterebbe di per sè a dimostrare la paternità
botticelliana del ritratto. L'arco a falce del collo ripete, nel suo tragitto breve, la conca a
lìl di rasoio che segna il contorno unito della tunica sollevata dal braccio della Filosofia,
nei già citati affreschi Tornabuoni; a complemento di questa sinfonia di linee sinuose,
il cornetto bianco della cuffia guizza con niveo splendore sotto il rosso lucco e le foglie
ili velluto bruno, levandosi con grido improvviso dalla signorile soffocata gamma dei
colori.
Il contrasto coi lineamenti sinuosi rende più suggestive la fissità del volto sporto
dall'arco del collo con l'irrigidimento proprio dei profili di Lorenzo Tornabuoni e della
Salomè, e la tensione del busto, con la stoffa segnata a pieghe, a solchi sintetici, a cannelli
spioventi in fasci di raggi, in ampli coni. Con mezzi di semplicità estrema, Sandro ha
raggiunto un ritmo di nobiltà e di eleganza perfette. Come la linea, il colore ripete note
frequenti nell'arte botticelliana: azzurro chiaro, purtroppo restaurato, di cielo, rosso lacca
di stoffe, caratteristico pallore olivigno di carni, verde cupo di foglie, che scurano al pas-
saggio, con l'ombra, la tinta tradizionale del lucco dantesco, dal ritratto di Giotto nel
Bargello, in poi.
In tutta l'opera è l'impronta della poetica fantasia di Sandro Botticelli, la cui mano
rapida ha fissata sulla tavola, come inconsciamente, tanta è la spontaneità del tratto, la
visione che il cantore della Firenze medicea, delle allegorie di Angelo Poliziano, si era
formata di Dante, traducendo sulle carte del codice di Piero di Lorenzo de' Medici, con
la punta della sua penna alata, le impressioni della Divina Commedia. Il ritratto è del
tempo stesso in cui il pittore attendeva al commento figurato, e la sua linea stava per rag-
giungere la massima rapidità e tensione.
Verso la metà del Quattrocento il tipo accettato dalla moderna iconografia dantesca
era venuto formandosi: massimo esempio il busto di Napoli, dove il poeta, col volto già
devastato dall'età e dal pensiero, faticato di linea, triste di sguardo, sembra scrutare, con