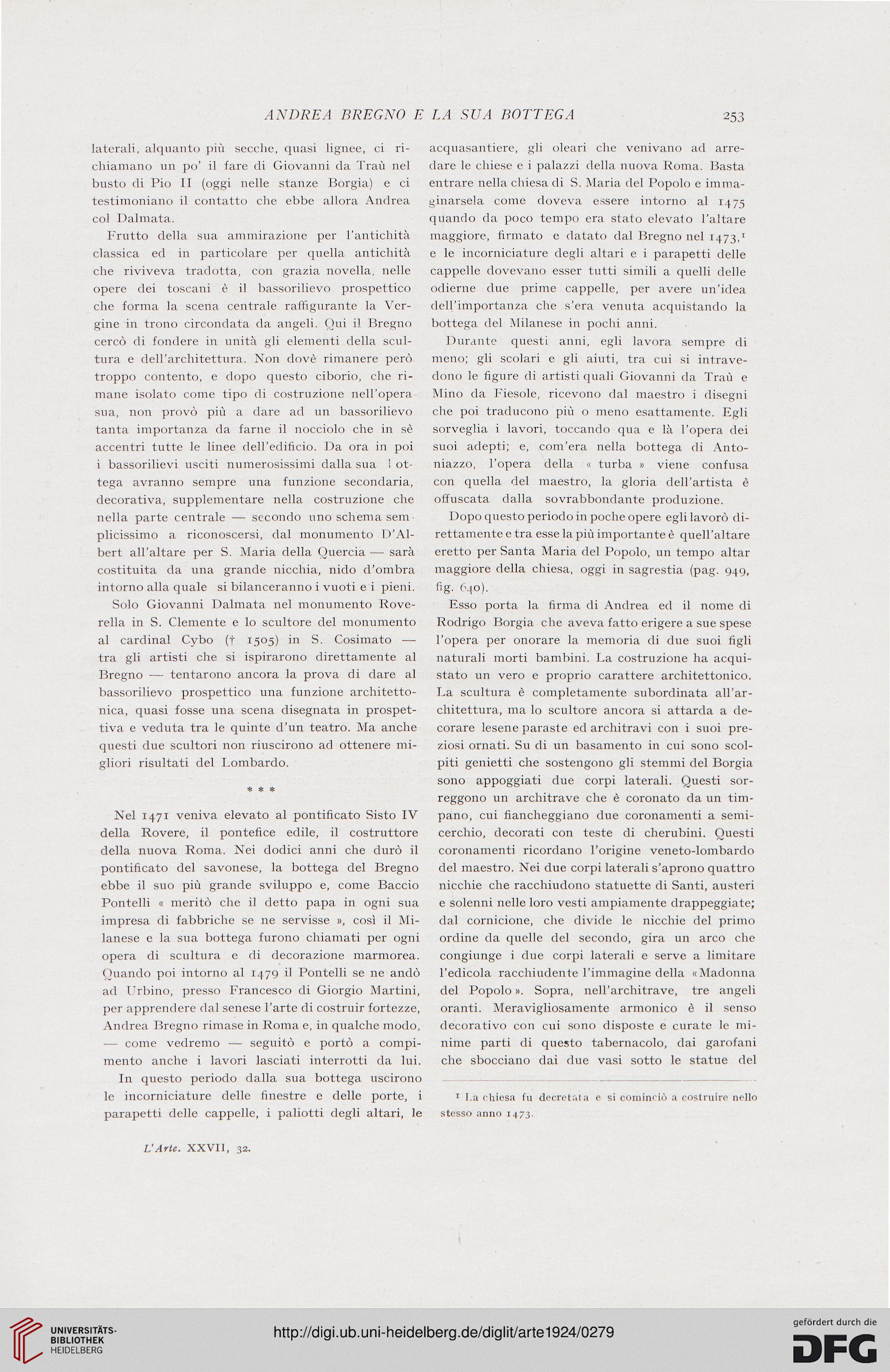ANDREA BREGNO E LA SUA BOTTEGA
253
laterali, alquanto più secche, quasi lignee, ci ri-
chiamano un po' il fare di Giovanni da Traù nel
busto di Pio II (oggi nelle stanze Borgia) e ci
testimoniano il contatto che ebbe allora Andrea
col Dalmata.
Frutto della sua ammirazione per l'antichità
classica ed in particolare per quella antichità
che riviveva tradotta, con grazia novella, nelle
opere dei toscani è il bassorilievo prospettico
che forma la scena centrale raffigurante la Ver-
gine in trono circondata da angeli. Qui il Bregno
cercò di fondere in unità gli elementi della scul-
tura e dell'architettura. Non dovè rimanere però
troppo contento, e dopo questo ciborio, che ri-
mane isolato come tipo di costruzione nell'opera
sua, non provò più a dare ad un bassorilievo
tanta importanza da farne il nocciolo che in sè
accentri tutte le linee dell'edificio. Da ora in poi
i bassorilievi usciti numerosissimi dalla sua 1 ot-
tega avranno sempre una funzione secondaria,
decorativa, supplementare nella costruzione che
nella parte centrale — secondo uno schema sem
plicissimo a riconoscersi, dal monumento 1 )'Al-
bert all'altare per S. Maria della Quercia — sarà
costituita da una grande nicchia, nido d'ombra
intorno alla quale si bilanceranno i vuoti e i pieni.
Solo Giovanni Dalmata nel monumento Rove-
rella in S. Clemente e lo scultore del monumento
al cardinal Cybo (t 1505) in S. Cosimato —
tra gli artisti che si ispirarono direttamente al
Bregno — tentarono ancora la prova di dare al
bassorilievo prospettico una funzione architetto-
nica, quasi fosse una scena disegnata in prospet-
tiva e veduta tra le quinte d'un teatro. Ma anche
questi due scultori non riuscirono ad ottenere mi-
gliori risultati del Lombardo.
* * *
Nel 1471 veniva elevato al pontificato Sisto IV
della Rovere, il pontefice edile, il costruttore
della nuova Roma. Nei dodici anni che durò il
pontificato del savonese, la bottega del Bregno
ebbe il suo più grande sviluppo e, come Baccio
Pontelli « meritò che il detto papa in ogni sua
impresa di fabbriche se ne servisse », così il Mi-
lanese e la sua bottega furono chiamati per ogni
opera di scultura e di decorazione marmorea.
Oliando poi intorno al 1479 il Pontelli se ne andò
ad Urbino, presso Francesco di Giorgio Martini,
per apprendere dal senese l'arte di costruir fortezze,
Andrea Bregno rimase in Roma e, in qualche modo,
— come vedremo — seguitò e portò a compi-
mento anche i lavori lasciati interrotti da lui.
In questo periodo dalla sua bottega uscirono
le incorniciature delle finestre e delle porte, i
parapetti delle cappelle, i paliotti degli altari, le
acquasantiere, gli oleari che venivano ad arre-
dare le chiese e i palazzi della nuova Roma. Basta
entrare nella chiesa di S. Maria del Popolo e imma-
ginarsela come doveva essere intorno al 1475
quando da poco tempo era stato elevato l'altare
maggiore, firmato e datato dal Bregno nel 1473,1
e le incorniciature degli altari e i parapetti delle
cappelle dovevano esser tutti simili a quelli delle
odierne due prime cappelle, per avere un'idea
dell'importanza che s'era venuta acquistando la
bottega del Milanese in pochi anni.
Durante questi anni, egli lavora sempre di
meno; gli scolari e gli aiuti, tra cui si intrave-
dono le figure di artisti quali Giovanni da Traù e
Mino da Fiesole, ricevono dal maestro i disegni
che poi traducono più o meno esattamente. Fgli
sorveglia i lavori, toccando qua e là l'opera dei
suoi adepti; e, com'era nella bottega di Anto-
niazzo, l'opera della « turba » viene confusa
con quella del maestro, la gloria dell'artista è
offuscata dalla sovrabbondante produzione.
Dopo questo periodo in poche opere egli lavorò di-
rettamente e tra esse la più importante è quell'altare
eretto per Santa Maria del Popolo, un tempo aitar
maggiore della chiesa, oggi in sagrestia (pag. 949,
fig. 640).
Esso porta la firma di Andrea ed il nome di
Rodrigo Borgia che aveva fatto erigere a sue spese
l'opera per onorare la memoria di due suoi figli
naturali morti bambini. La costruzione ha acqui-
stato un vero e proprio carattere architettonico.
La scultura è completamente subordinata all'ar-
chitettura, ma lo scultore ancora si attarda a de-
corare lesene paraste ed architravi con i suoi pre-
ziosi ornati. Su di un basamento in cui sono scol-
piti genietti che sostengono gli stemmi del Borgia
sono appoggiati due corpi laterali. Questi sor-
reggono un architrave che è coronato da un tim-
pano, cui fiancheggiano due coronamenti a semi-
cerchio, decorati con teste di cherubini. Questi
coronamenti ricordano l'origine veneto-lombardo
del maestro. Nei due corpi laterali s'aprono quattro
nicchie che racchiudono statuette di Santi, austeri
e solenni nelle loro vesti ampiamente drappeggiate;
dal cornicione, che divide le nicchie del primo
ordine da quelle del secondo, gira un arco che
congiunge i due corpi laterali e serve a limitare
l'edicola racchiudente l'immagine della «Madonna
del Popolo ». Sopra, nell'architrave, tre angeli
oranti. Meravigliosamente armonico è il senso
decorativo con cui sono disposte e curate le mi-
nime parti di questo tabernacolo, dai garofani
che sbocciano dai due vasi sotto le statue del
1 l a chiesa fu decretata e si cominciò a costruire nello
stesso anno 1473.
L'Arte. XXVII, 32.
253
laterali, alquanto più secche, quasi lignee, ci ri-
chiamano un po' il fare di Giovanni da Traù nel
busto di Pio II (oggi nelle stanze Borgia) e ci
testimoniano il contatto che ebbe allora Andrea
col Dalmata.
Frutto della sua ammirazione per l'antichità
classica ed in particolare per quella antichità
che riviveva tradotta, con grazia novella, nelle
opere dei toscani è il bassorilievo prospettico
che forma la scena centrale raffigurante la Ver-
gine in trono circondata da angeli. Qui il Bregno
cercò di fondere in unità gli elementi della scul-
tura e dell'architettura. Non dovè rimanere però
troppo contento, e dopo questo ciborio, che ri-
mane isolato come tipo di costruzione nell'opera
sua, non provò più a dare ad un bassorilievo
tanta importanza da farne il nocciolo che in sè
accentri tutte le linee dell'edificio. Da ora in poi
i bassorilievi usciti numerosissimi dalla sua 1 ot-
tega avranno sempre una funzione secondaria,
decorativa, supplementare nella costruzione che
nella parte centrale — secondo uno schema sem
plicissimo a riconoscersi, dal monumento 1 )'Al-
bert all'altare per S. Maria della Quercia — sarà
costituita da una grande nicchia, nido d'ombra
intorno alla quale si bilanceranno i vuoti e i pieni.
Solo Giovanni Dalmata nel monumento Rove-
rella in S. Clemente e lo scultore del monumento
al cardinal Cybo (t 1505) in S. Cosimato —
tra gli artisti che si ispirarono direttamente al
Bregno — tentarono ancora la prova di dare al
bassorilievo prospettico una funzione architetto-
nica, quasi fosse una scena disegnata in prospet-
tiva e veduta tra le quinte d'un teatro. Ma anche
questi due scultori non riuscirono ad ottenere mi-
gliori risultati del Lombardo.
* * *
Nel 1471 veniva elevato al pontificato Sisto IV
della Rovere, il pontefice edile, il costruttore
della nuova Roma. Nei dodici anni che durò il
pontificato del savonese, la bottega del Bregno
ebbe il suo più grande sviluppo e, come Baccio
Pontelli « meritò che il detto papa in ogni sua
impresa di fabbriche se ne servisse », così il Mi-
lanese e la sua bottega furono chiamati per ogni
opera di scultura e di decorazione marmorea.
Oliando poi intorno al 1479 il Pontelli se ne andò
ad Urbino, presso Francesco di Giorgio Martini,
per apprendere dal senese l'arte di costruir fortezze,
Andrea Bregno rimase in Roma e, in qualche modo,
— come vedremo — seguitò e portò a compi-
mento anche i lavori lasciati interrotti da lui.
In questo periodo dalla sua bottega uscirono
le incorniciature delle finestre e delle porte, i
parapetti delle cappelle, i paliotti degli altari, le
acquasantiere, gli oleari che venivano ad arre-
dare le chiese e i palazzi della nuova Roma. Basta
entrare nella chiesa di S. Maria del Popolo e imma-
ginarsela come doveva essere intorno al 1475
quando da poco tempo era stato elevato l'altare
maggiore, firmato e datato dal Bregno nel 1473,1
e le incorniciature degli altari e i parapetti delle
cappelle dovevano esser tutti simili a quelli delle
odierne due prime cappelle, per avere un'idea
dell'importanza che s'era venuta acquistando la
bottega del Milanese in pochi anni.
Durante questi anni, egli lavora sempre di
meno; gli scolari e gli aiuti, tra cui si intrave-
dono le figure di artisti quali Giovanni da Traù e
Mino da Fiesole, ricevono dal maestro i disegni
che poi traducono più o meno esattamente. Fgli
sorveglia i lavori, toccando qua e là l'opera dei
suoi adepti; e, com'era nella bottega di Anto-
niazzo, l'opera della « turba » viene confusa
con quella del maestro, la gloria dell'artista è
offuscata dalla sovrabbondante produzione.
Dopo questo periodo in poche opere egli lavorò di-
rettamente e tra esse la più importante è quell'altare
eretto per Santa Maria del Popolo, un tempo aitar
maggiore della chiesa, oggi in sagrestia (pag. 949,
fig. 640).
Esso porta la firma di Andrea ed il nome di
Rodrigo Borgia che aveva fatto erigere a sue spese
l'opera per onorare la memoria di due suoi figli
naturali morti bambini. La costruzione ha acqui-
stato un vero e proprio carattere architettonico.
La scultura è completamente subordinata all'ar-
chitettura, ma lo scultore ancora si attarda a de-
corare lesene paraste ed architravi con i suoi pre-
ziosi ornati. Su di un basamento in cui sono scol-
piti genietti che sostengono gli stemmi del Borgia
sono appoggiati due corpi laterali. Questi sor-
reggono un architrave che è coronato da un tim-
pano, cui fiancheggiano due coronamenti a semi-
cerchio, decorati con teste di cherubini. Questi
coronamenti ricordano l'origine veneto-lombardo
del maestro. Nei due corpi laterali s'aprono quattro
nicchie che racchiudono statuette di Santi, austeri
e solenni nelle loro vesti ampiamente drappeggiate;
dal cornicione, che divide le nicchie del primo
ordine da quelle del secondo, gira un arco che
congiunge i due corpi laterali e serve a limitare
l'edicola racchiudente l'immagine della «Madonna
del Popolo ». Sopra, nell'architrave, tre angeli
oranti. Meravigliosamente armonico è il senso
decorativo con cui sono disposte e curate le mi-
nime parti di questo tabernacolo, dai garofani
che sbocciano dai due vasi sotto le statue del
1 l a chiesa fu decretata e si cominciò a costruire nello
stesso anno 1473.
L'Arte. XXVII, 32.