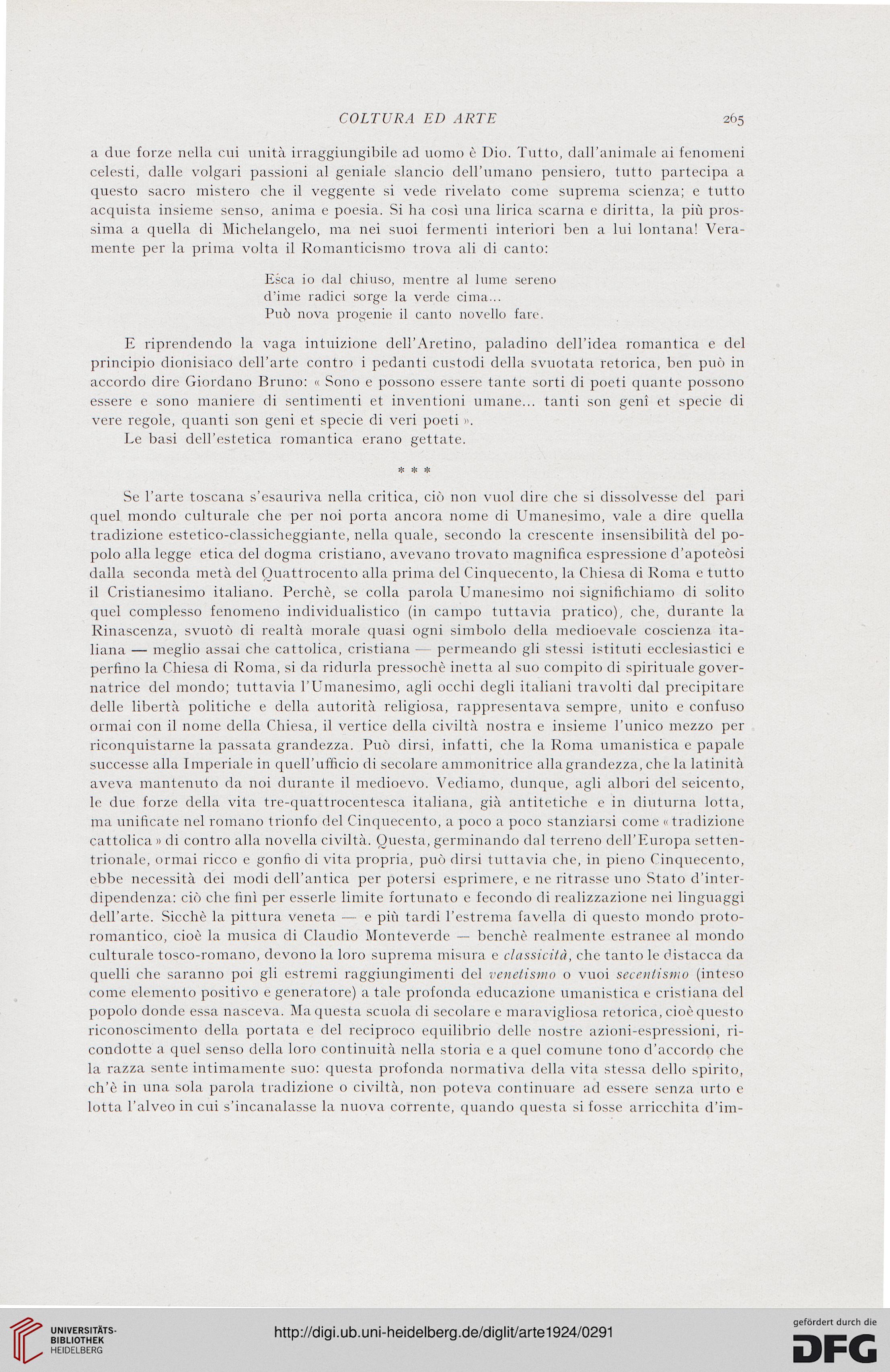COLTURA ED ARTE
265
a due forze nella cui unità irraggiungibile ad uomo è Dio. Tutto, dall'animale ai fenomeni
celesti, dalle volgari passioni al geniale slancio dell'umano pensiero, tutto partecipa a
questo sacro mistero che il veggente si vede rivelato come suprema scienza; e tutto
acquista insieme senso, anima e poesia. Si ha così una lirica scarna e diritta, la più pros-
sima a quella di Michelangelo, ma nei suoi fermenti interiori ben a lui lontana! Vera-
mente per la prima volta il Romanticismo trova ali di canto:
Esca io dal chiuso, mentre al lume sereno
d'ime radici sorge la verde cima...
Può nova progenie il canto novello fare.
E riprendendo la vaga intuizione dell'Aretino, paladino dell'idea romantica e del
principio dionisiaco dell'arte contro i pedanti custodi della svuotata retorica, ben può in
accordo dire Giordano Bruno: « Sono e possono essere tante sorti di poeti quante possono
essere e sono maniere di sentimenti et inventioni umane... tanti son geni et specie di
vere regole, quanti son geni et specie di veri poeti ».
Le basi dell'estetica romantica erano gettate.
£ afe >H
Se l'arte toscana s'esauriva nella critica, ciò non vuol dire che si dissolvesse del pari
quel mondo culturale che per noi porta ancora nome di Umanesimo, vale a dire quella
tradizione estetico-classicheggiante, nella quale, secondo la crescente insensibilità del po-
polo alla legge etica del dogma cristiano, avevano trovato magnifica espressione d'apoteòsi
dalla seconda metà del Quattrocento alla prima del Cinquecento, la Chiesa di Roma e tutto
il Cristianesimo italiano. Perchè, se colla parola Umanesimo noi significhiamo di solito
quel complesso fenomeno individualistico (in campo tuttavia pratico), che, durante la
Rinascenza, svuotò di realtà morale (piasi ogni simbolo della medioevale coscienza ita-
liana — meglio assai che cattolica, cristiana — permeando gli stessi istituti ecclesiastici e
perfino la Chiesa di Roma, si da ridurla pressoché inetta al suo compito di spirituale gover-
natrice del mondo; tuttavia l'Umanesimo, agli occhi degli italiani travolti dal precipitare
delle libertà politiche e della autorità religiosa, rappresentava sempre, unito e confuso
ormai con il nome della Chiesa, il vertice della civiltà nostra e insieme l'unico mezzo per
riconquistarne la passata grandezza. Può dirsi, infatti, che la Roma umanistica e papale
successe alla Imperiale in quell'ufficio di secolare ammonitrice alla grandezza, che la latinità
aveva mantenuto da noi durante il medioevo. Vediamo, dunque, agli albori del seicento,
le due forze della vita tre-quattrocentesca italiana, già antitetiche e in diuturna lotta,
ma unificate nel romano trionfo del Cinquecento, a poco a poco stanziarsi come « tradizione
cattolica » di contro alla novella civiltà. Questa, germinando dal terreno dell'Europa setten-
trionale, ormai ricco e gonfio di vita propria, può dirsi tuttavia che, in pieno Cinquecento,
ebbe necessità dei modi dell'antica per potersi esprimere, e ne ritrasse uno Stato d'inter-
dipendenza: ciò che finì per esserle limite fortunato e fecondo di realizzazione nei linguaggi
dell'arte. Sicché la pittura veneta — e più tardi l'estrema favella di questo mondo proto-
romantico, cioè la musica di Claudio Monteverde — benché realmente estranee al mondo
culturale tosco-romano, devono la loro suprema misura e classicità, che tanto le distacca da
quelli che saranno poi gli estremi raggiungimenti del venetismo o vuoi secentismo (inteso
come elemento positivo e generatore) a tale profonda educazione umanistica e cristiana del
popolo donde essa nasceva. Ma questa scuola di secolare e mara vigliosa retorica, cioè questo
riconoscimento della portata e del reciproco equilibrio delle nostri' azioni-espressioni, ri-
condotte a quel senso della loro continuità nella storia e a quel comune tono d'accordo che
la razza sente intimamente suo: questa profonda normativa della vita stessa dello spirito,
ch'è in una sola parola tradizione o civiltà, non poteva continuare ad essere senza urto e
lotta l'alveo in cui s'incanalasse la nuova corrente, quando questa si fosse arricchita d'im-
265
a due forze nella cui unità irraggiungibile ad uomo è Dio. Tutto, dall'animale ai fenomeni
celesti, dalle volgari passioni al geniale slancio dell'umano pensiero, tutto partecipa a
questo sacro mistero che il veggente si vede rivelato come suprema scienza; e tutto
acquista insieme senso, anima e poesia. Si ha così una lirica scarna e diritta, la più pros-
sima a quella di Michelangelo, ma nei suoi fermenti interiori ben a lui lontana! Vera-
mente per la prima volta il Romanticismo trova ali di canto:
Esca io dal chiuso, mentre al lume sereno
d'ime radici sorge la verde cima...
Può nova progenie il canto novello fare.
E riprendendo la vaga intuizione dell'Aretino, paladino dell'idea romantica e del
principio dionisiaco dell'arte contro i pedanti custodi della svuotata retorica, ben può in
accordo dire Giordano Bruno: « Sono e possono essere tante sorti di poeti quante possono
essere e sono maniere di sentimenti et inventioni umane... tanti son geni et specie di
vere regole, quanti son geni et specie di veri poeti ».
Le basi dell'estetica romantica erano gettate.
£ afe >H
Se l'arte toscana s'esauriva nella critica, ciò non vuol dire che si dissolvesse del pari
quel mondo culturale che per noi porta ancora nome di Umanesimo, vale a dire quella
tradizione estetico-classicheggiante, nella quale, secondo la crescente insensibilità del po-
polo alla legge etica del dogma cristiano, avevano trovato magnifica espressione d'apoteòsi
dalla seconda metà del Quattrocento alla prima del Cinquecento, la Chiesa di Roma e tutto
il Cristianesimo italiano. Perchè, se colla parola Umanesimo noi significhiamo di solito
quel complesso fenomeno individualistico (in campo tuttavia pratico), che, durante la
Rinascenza, svuotò di realtà morale (piasi ogni simbolo della medioevale coscienza ita-
liana — meglio assai che cattolica, cristiana — permeando gli stessi istituti ecclesiastici e
perfino la Chiesa di Roma, si da ridurla pressoché inetta al suo compito di spirituale gover-
natrice del mondo; tuttavia l'Umanesimo, agli occhi degli italiani travolti dal precipitare
delle libertà politiche e della autorità religiosa, rappresentava sempre, unito e confuso
ormai con il nome della Chiesa, il vertice della civiltà nostra e insieme l'unico mezzo per
riconquistarne la passata grandezza. Può dirsi, infatti, che la Roma umanistica e papale
successe alla Imperiale in quell'ufficio di secolare ammonitrice alla grandezza, che la latinità
aveva mantenuto da noi durante il medioevo. Vediamo, dunque, agli albori del seicento,
le due forze della vita tre-quattrocentesca italiana, già antitetiche e in diuturna lotta,
ma unificate nel romano trionfo del Cinquecento, a poco a poco stanziarsi come « tradizione
cattolica » di contro alla novella civiltà. Questa, germinando dal terreno dell'Europa setten-
trionale, ormai ricco e gonfio di vita propria, può dirsi tuttavia che, in pieno Cinquecento,
ebbe necessità dei modi dell'antica per potersi esprimere, e ne ritrasse uno Stato d'inter-
dipendenza: ciò che finì per esserle limite fortunato e fecondo di realizzazione nei linguaggi
dell'arte. Sicché la pittura veneta — e più tardi l'estrema favella di questo mondo proto-
romantico, cioè la musica di Claudio Monteverde — benché realmente estranee al mondo
culturale tosco-romano, devono la loro suprema misura e classicità, che tanto le distacca da
quelli che saranno poi gli estremi raggiungimenti del venetismo o vuoi secentismo (inteso
come elemento positivo e generatore) a tale profonda educazione umanistica e cristiana del
popolo donde essa nasceva. Ma questa scuola di secolare e mara vigliosa retorica, cioè questo
riconoscimento della portata e del reciproco equilibrio delle nostri' azioni-espressioni, ri-
condotte a quel senso della loro continuità nella storia e a quel comune tono d'accordo che
la razza sente intimamente suo: questa profonda normativa della vita stessa dello spirito,
ch'è in una sola parola tradizione o civiltà, non poteva continuare ad essere senza urto e
lotta l'alveo in cui s'incanalasse la nuova corrente, quando questa si fosse arricchita d'im-