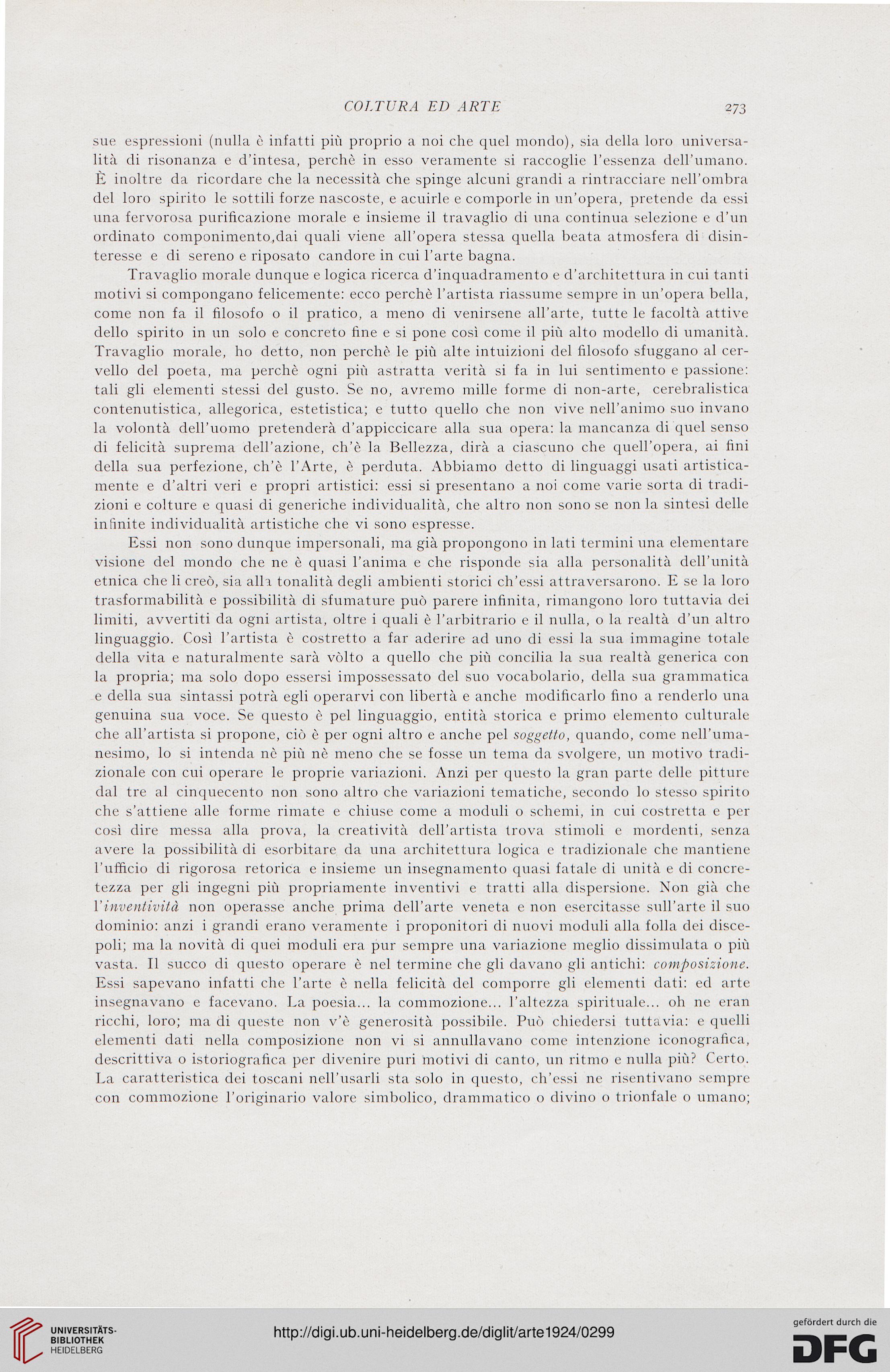COLTURA ED ARTE
273
sue espressioni (nulla è infatti più proprio a noi che quel mondo), sia della loro universa-
lità di risonanza e d'intesa, perchè in esso veramente si raccoglie l'essenza dell'umano.
E inoltre da ricordare che la necessità che spinge alcuni grandi a rintracciare nell'ombra
del loro spirito le sottili forze nascoste, e acuirle e comporle in un'opera, pretende da essi
una fervorosa purificazione morale e insieme il travaglio di una continua selezione e d'un
ordinato componimento,dai quali viene all'opera stessa quella beata atmosfera di disin-
teresse e di sereno e riposato candore in cui l'arte bagna.
Travaglio morale dunque e logica ricerca d'inquadramento e d'architettura in cui tanti
motivi si compongano felicemente: ecco perchè l'artista riassume sempre in un'opera bella,
come non fa il filosofo o il pratico, a meno di venirsene all'arte, tutte le facoltà attive
dello spirito in un solo e concreto fine e si pone così come il più alto modello di umanità.
Travaglio morale, ho detto, non perchè le più alte intuizioni del filosofo sfuggano al cer-
vello del poeta, ma perchè ogni più astratta verità si fa in lui sentimento e passione:
tali gli elementi stessi del gusto. Se no, avremo mille forme di non-arte, cerebralistica
contenutistica, allegorica, estetistica; e tutto quello che non vive nell'animo suo invano
la volontà dell'uomo pretenderà d'appiccicare alla sua opera: la mancanza di quel senso
di felicità suprema dell'azione, ch'è la Bellezza, dirà a ciascuno che quell'opera, ai fini
della sua perfezione, ch'è l'Arte, è perduta. Abbiamo detto di linguaggi usati artistica-
mente e d'altri veri e propri artistici: essi si presentano a noi come varie sorta di tradi-
zioni e colture e quasi di generiche individualità, che altro non sono se non la sintesi delle
infinite individualità artistiche che vi sono espresse.
Essi non sono dunque impersonali, ma già propongono in lati termini una elementare
visione del mondo che ne è quasi l'anima e che risponde sia alla personalità dell'unità
etnica che li creò, sia alla tonalità degli ambienti storici ch'essi attraversarono. E se la loro
trasformabilità e possibilità di sfumature può parere infinita, rimangono loro tuttavia dei
limiti, avvertiti da ogni artista, oltre i quali è l'arbitrario e il nulla, o la realtà d'un altro
linguaggio. Così l'artista è costretto a far aderire ad uno di essi la sua immagine totale
della vita e naturalmente sarà vòlto a quello che più concilia la sua realtà generica con
la propria; ma solo dopo essersi impossessato del suo vocabolario, della sua grammatica
e della sua sintassi potrà egli operarvi con libertà e anche modificarlo fino a renderlo una
genuina sua voce. Se questo è pel linguaggio, entità storica e primo elemento culturale
che all'artista si propone, ciò è per ogni altro e anche pel soggetto, quando, come nell'uma-
nesimo, lo si intenda nè più nè meno che se fosse un tema da svolgere, un motivo tradi-
zionale con cui operare le proprie variazioni. Anzi per questo la gran parte delle pitture
dal tre al cinquecento non sono altro che variazioni tematiche, secondo lo stesso spirito
che s'attiene alle forme rimate e chiuse come a moduli o schemi, in cui costretta e per
così dire messa alla prova, la creatività dell'artista trova stimoli e mordenti, senza
avere la possibilità di esorbitare da una architettura logica e tradizionale che mantiene
l'ufficio di rigorosa retorica e insieme un insegnamento quasi fatale di unità e di concre-
tezza per gli ingegni più propriamente inventivi e tratti alla dispersione. Non già che
Yinventività non operasse anche prima dell'arte veneta e non esercitasse sull'arte il suo
dominio: anzi i grandi erano veramente i proponitori di nuovi moduli alla folla dei disce-
poli; ma la novità di quei moduli era pur sempre una variazione meglio dissimulata o più
vasta. Il succo di questo operare è nel termine che gli davano gli antichi: composizione.
Essi sapevano infatti che l'arte è nella felicità del comporre gli elementi dati: ed arte
insegnavano e facevano. La poesia... la commozione... l'altezza spirituale... oh ne eran
ricchi, loro; ma di queste non v'è generosità possibile. Può chiedersi tuttavia: e quelli
elementi dati nella composizione non vi si annullavano come intenzione iconografica,
descrittiva o istoriografica per divenire puri motivi di canto, un ritmo e nulla più? Certo.
La caratteristica dei toscani nell'usarli sta solo in questo, ch'essi ne risentivano sempre
con commozione l'originario valore simbolico, drammatico o divino o trionfale o umano;
273
sue espressioni (nulla è infatti più proprio a noi che quel mondo), sia della loro universa-
lità di risonanza e d'intesa, perchè in esso veramente si raccoglie l'essenza dell'umano.
E inoltre da ricordare che la necessità che spinge alcuni grandi a rintracciare nell'ombra
del loro spirito le sottili forze nascoste, e acuirle e comporle in un'opera, pretende da essi
una fervorosa purificazione morale e insieme il travaglio di una continua selezione e d'un
ordinato componimento,dai quali viene all'opera stessa quella beata atmosfera di disin-
teresse e di sereno e riposato candore in cui l'arte bagna.
Travaglio morale dunque e logica ricerca d'inquadramento e d'architettura in cui tanti
motivi si compongano felicemente: ecco perchè l'artista riassume sempre in un'opera bella,
come non fa il filosofo o il pratico, a meno di venirsene all'arte, tutte le facoltà attive
dello spirito in un solo e concreto fine e si pone così come il più alto modello di umanità.
Travaglio morale, ho detto, non perchè le più alte intuizioni del filosofo sfuggano al cer-
vello del poeta, ma perchè ogni più astratta verità si fa in lui sentimento e passione:
tali gli elementi stessi del gusto. Se no, avremo mille forme di non-arte, cerebralistica
contenutistica, allegorica, estetistica; e tutto quello che non vive nell'animo suo invano
la volontà dell'uomo pretenderà d'appiccicare alla sua opera: la mancanza di quel senso
di felicità suprema dell'azione, ch'è la Bellezza, dirà a ciascuno che quell'opera, ai fini
della sua perfezione, ch'è l'Arte, è perduta. Abbiamo detto di linguaggi usati artistica-
mente e d'altri veri e propri artistici: essi si presentano a noi come varie sorta di tradi-
zioni e colture e quasi di generiche individualità, che altro non sono se non la sintesi delle
infinite individualità artistiche che vi sono espresse.
Essi non sono dunque impersonali, ma già propongono in lati termini una elementare
visione del mondo che ne è quasi l'anima e che risponde sia alla personalità dell'unità
etnica che li creò, sia alla tonalità degli ambienti storici ch'essi attraversarono. E se la loro
trasformabilità e possibilità di sfumature può parere infinita, rimangono loro tuttavia dei
limiti, avvertiti da ogni artista, oltre i quali è l'arbitrario e il nulla, o la realtà d'un altro
linguaggio. Così l'artista è costretto a far aderire ad uno di essi la sua immagine totale
della vita e naturalmente sarà vòlto a quello che più concilia la sua realtà generica con
la propria; ma solo dopo essersi impossessato del suo vocabolario, della sua grammatica
e della sua sintassi potrà egli operarvi con libertà e anche modificarlo fino a renderlo una
genuina sua voce. Se questo è pel linguaggio, entità storica e primo elemento culturale
che all'artista si propone, ciò è per ogni altro e anche pel soggetto, quando, come nell'uma-
nesimo, lo si intenda nè più nè meno che se fosse un tema da svolgere, un motivo tradi-
zionale con cui operare le proprie variazioni. Anzi per questo la gran parte delle pitture
dal tre al cinquecento non sono altro che variazioni tematiche, secondo lo stesso spirito
che s'attiene alle forme rimate e chiuse come a moduli o schemi, in cui costretta e per
così dire messa alla prova, la creatività dell'artista trova stimoli e mordenti, senza
avere la possibilità di esorbitare da una architettura logica e tradizionale che mantiene
l'ufficio di rigorosa retorica e insieme un insegnamento quasi fatale di unità e di concre-
tezza per gli ingegni più propriamente inventivi e tratti alla dispersione. Non già che
Yinventività non operasse anche prima dell'arte veneta e non esercitasse sull'arte il suo
dominio: anzi i grandi erano veramente i proponitori di nuovi moduli alla folla dei disce-
poli; ma la novità di quei moduli era pur sempre una variazione meglio dissimulata o più
vasta. Il succo di questo operare è nel termine che gli davano gli antichi: composizione.
Essi sapevano infatti che l'arte è nella felicità del comporre gli elementi dati: ed arte
insegnavano e facevano. La poesia... la commozione... l'altezza spirituale... oh ne eran
ricchi, loro; ma di queste non v'è generosità possibile. Può chiedersi tuttavia: e quelli
elementi dati nella composizione non vi si annullavano come intenzione iconografica,
descrittiva o istoriografica per divenire puri motivi di canto, un ritmo e nulla più? Certo.
La caratteristica dei toscani nell'usarli sta solo in questo, ch'essi ne risentivano sempre
con commozione l'originario valore simbolico, drammatico o divino o trionfale o umano;