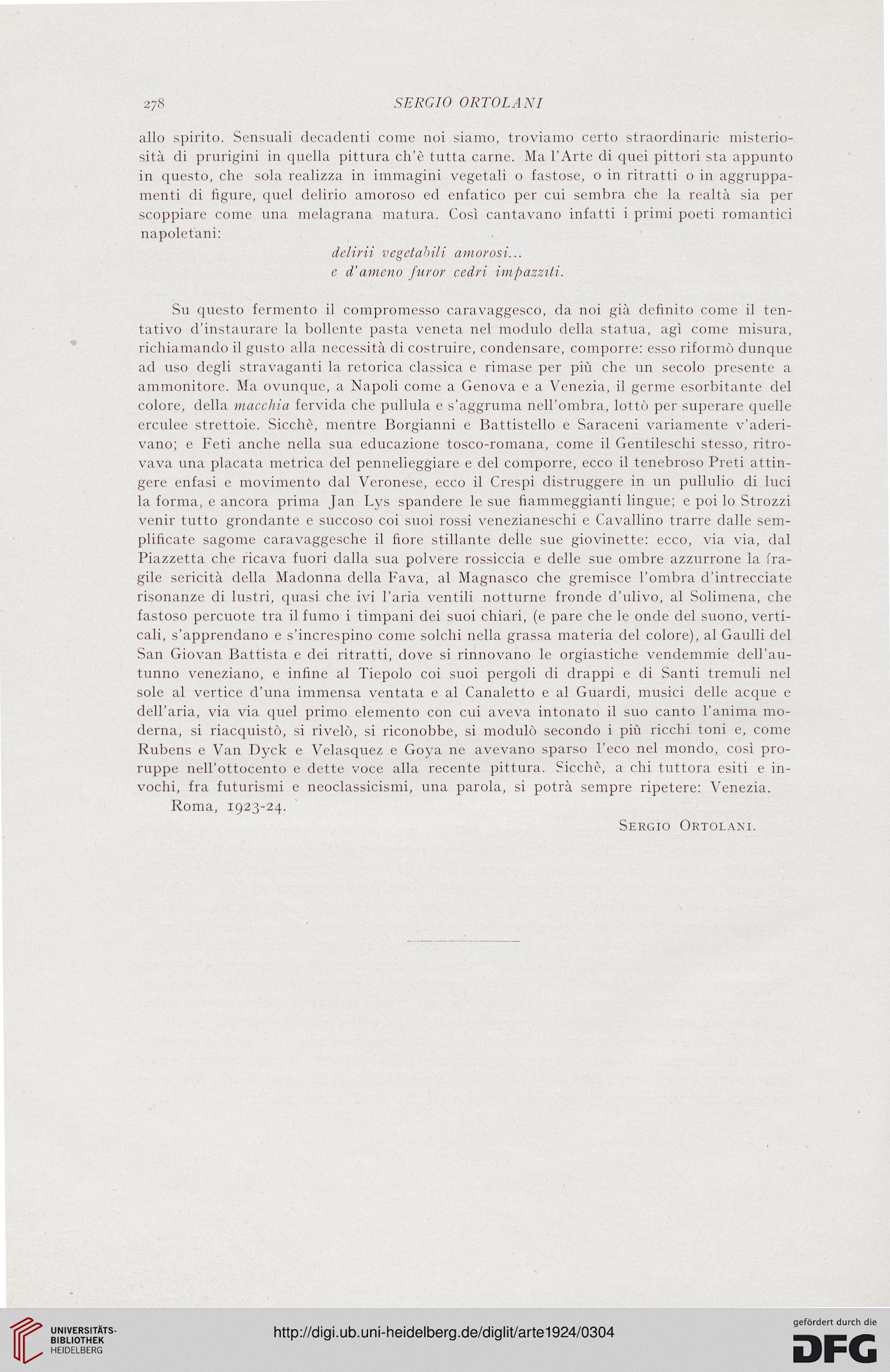278
SERGIO ORTO LA NI
allo spirito. Sensuali decadenti come noi siamo, troviamo certo straordinarie misterio-
sità di pnirigini in quella pittura eh'è tutta carne. Ma l'Arte di quei pittori sta appunto
in questo, che sola realizza in immagini vegetali o fastose, o in ritratti o in aggruppa-
menti di figure, quel delirio amoroso ed enfatico per cui sembra che la realtà sia per
scoppiare come una melagrana matura. Così cantavano infatti i primi poeti romantici
napoletani:
delirii vegetabili amorosi...
e d'ameno furor cedri impazziti.
Su questo fermento il compromesso caravaggesco, da noi già definito come il ten-
tativo d'instaurare la bollente pasta veneta nel modulo della statua, agì come misura,
richiamando il gusto alla necessità di costruire, condensare, comporre: esso riformò dunque
ad uso degli stravaganti la retorica classica e rimase per più che un secolo presente a
ammonitore. Ma ovunque, a Napoli come a Genova e a Venezia, il germe esorbitante del
colore, della macchia fervida che pullula e s'aggruma nell'ombra, lottò per superare quelle
erculee strettoie. Sicché, mentre Borgianni e Battistello e Saraceni variamente v'aderi-
vano; e Feti anche nella sua educazione tosco-romana, come il Gentileschi stesso, ritro-
vava una placata metrica del pennelieggiare e del comporre, ecco il tenebroso Preti attin-
gere enfasi e movimento dal Veronese, ecco il Crespi distruggere in un pullulio di luci
la forma, e ancora prima Jan Lys spandere le sue fiammeggianti lingue; e poi lo Strozzi
venir tutto grondante e succoso coi suoi rossi venezianeschi e Cavallino trarre dalle sem-
plificate sagome caravaggesche il fiore stillante deile sue giovinette: ecco, via via, dal
Piazzetta che ricava fuori dalla sua polvere rossiccia e delle sue ombre azzurrone la fra-
gile sericità della Madonna della Fava, al Magnasco che gremisce l'ombra d'intrecciate
risonanze di lustri, quasi che ivi l'aria ventili notturne fronde d'ulivo, al Solimena, che
fastoso percuote tra il fumo i timpani dei suoi chiari, (e pare che le onde del suono, verti-
cali, s'apprendano e s'increspino come solchi nella grassa materia del colore), al Gaudi del
San Giovan Battista e dei ritratti, dove si rinnovano le orgiastiche vendemmie dell'au-
tunno veneziano, e infine al Tiepolo coi suoi pergoli di drappi e di Santi tremuli nel
sole al vertice d'una immensa ventata e al Canaletto e al Guardi, musici delle acque e
dell'aria, via via quel primo elemento con cui aveva intonato il suo canto l'anima mo-
derna, si riacquistò, si rivelò, si riconobbe, si modulò secondo i più ricchi toni e, come
Rubens e Van Dyck e Velasquez e Goya ne avevano sparso l'eco nel mondo, così pro-
ruppe nell'ottocento e dette voce alla recente pittura. Sicché, a chi tuttora esiti e in-
vochi, fra futurismi e neoclassicismi, una parola, si potrà sempre ripetere: Venezia.
Roma, 1923-24.
Sergio Ortolani.
SERGIO ORTO LA NI
allo spirito. Sensuali decadenti come noi siamo, troviamo certo straordinarie misterio-
sità di pnirigini in quella pittura eh'è tutta carne. Ma l'Arte di quei pittori sta appunto
in questo, che sola realizza in immagini vegetali o fastose, o in ritratti o in aggruppa-
menti di figure, quel delirio amoroso ed enfatico per cui sembra che la realtà sia per
scoppiare come una melagrana matura. Così cantavano infatti i primi poeti romantici
napoletani:
delirii vegetabili amorosi...
e d'ameno furor cedri impazziti.
Su questo fermento il compromesso caravaggesco, da noi già definito come il ten-
tativo d'instaurare la bollente pasta veneta nel modulo della statua, agì come misura,
richiamando il gusto alla necessità di costruire, condensare, comporre: esso riformò dunque
ad uso degli stravaganti la retorica classica e rimase per più che un secolo presente a
ammonitore. Ma ovunque, a Napoli come a Genova e a Venezia, il germe esorbitante del
colore, della macchia fervida che pullula e s'aggruma nell'ombra, lottò per superare quelle
erculee strettoie. Sicché, mentre Borgianni e Battistello e Saraceni variamente v'aderi-
vano; e Feti anche nella sua educazione tosco-romana, come il Gentileschi stesso, ritro-
vava una placata metrica del pennelieggiare e del comporre, ecco il tenebroso Preti attin-
gere enfasi e movimento dal Veronese, ecco il Crespi distruggere in un pullulio di luci
la forma, e ancora prima Jan Lys spandere le sue fiammeggianti lingue; e poi lo Strozzi
venir tutto grondante e succoso coi suoi rossi venezianeschi e Cavallino trarre dalle sem-
plificate sagome caravaggesche il fiore stillante deile sue giovinette: ecco, via via, dal
Piazzetta che ricava fuori dalla sua polvere rossiccia e delle sue ombre azzurrone la fra-
gile sericità della Madonna della Fava, al Magnasco che gremisce l'ombra d'intrecciate
risonanze di lustri, quasi che ivi l'aria ventili notturne fronde d'ulivo, al Solimena, che
fastoso percuote tra il fumo i timpani dei suoi chiari, (e pare che le onde del suono, verti-
cali, s'apprendano e s'increspino come solchi nella grassa materia del colore), al Gaudi del
San Giovan Battista e dei ritratti, dove si rinnovano le orgiastiche vendemmie dell'au-
tunno veneziano, e infine al Tiepolo coi suoi pergoli di drappi e di Santi tremuli nel
sole al vertice d'una immensa ventata e al Canaletto e al Guardi, musici delle acque e
dell'aria, via via quel primo elemento con cui aveva intonato il suo canto l'anima mo-
derna, si riacquistò, si rivelò, si riconobbe, si modulò secondo i più ricchi toni e, come
Rubens e Van Dyck e Velasquez e Goya ne avevano sparso l'eco nel mondo, così pro-
ruppe nell'ottocento e dette voce alla recente pittura. Sicché, a chi tuttora esiti e in-
vochi, fra futurismi e neoclassicismi, una parola, si potrà sempre ripetere: Venezia.
Roma, 1923-24.
Sergio Ortolani.