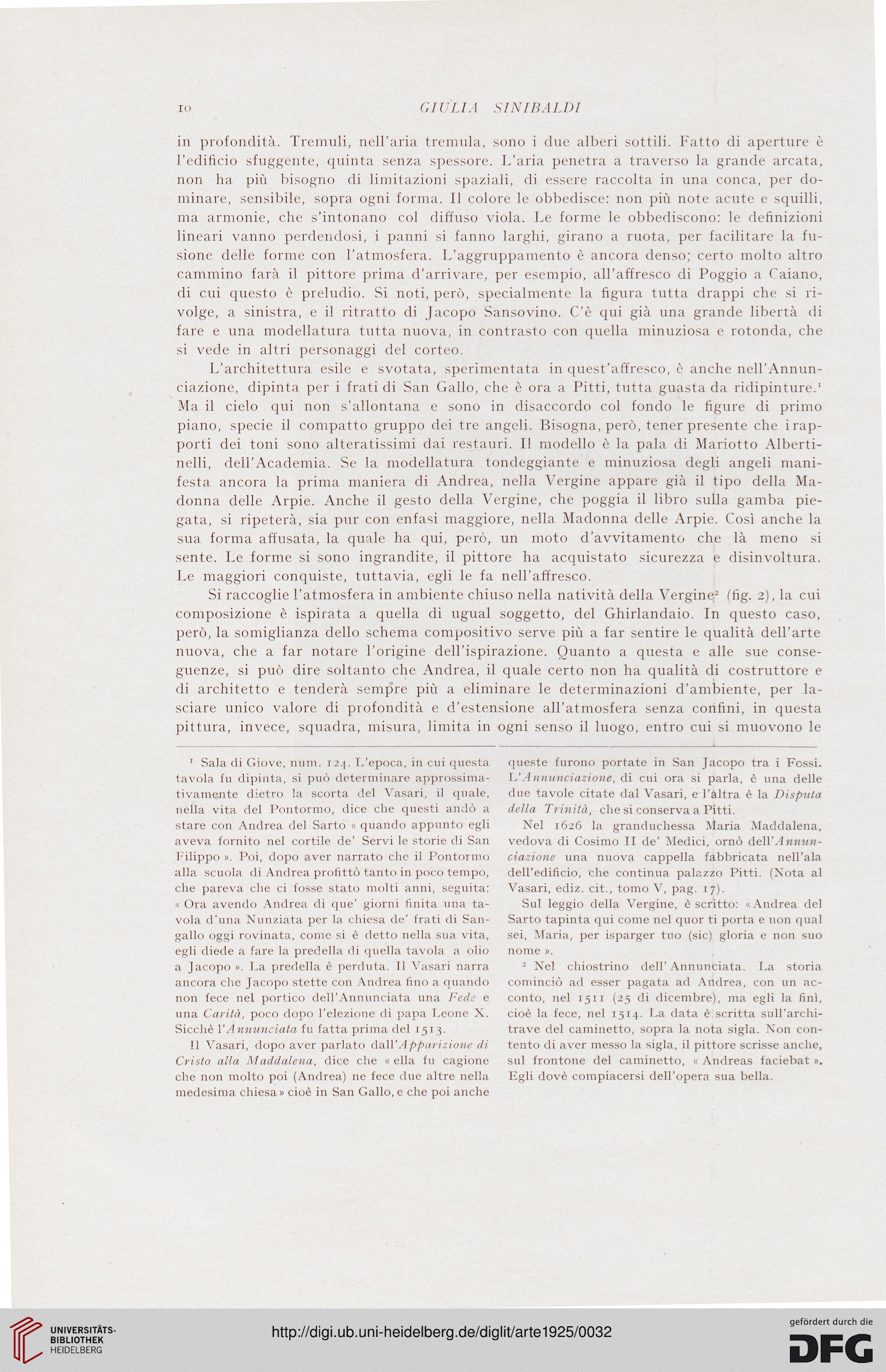1(1
GIULIA SINIBALD1
in profondità. Tremuli, nell'aria tremula, sono i due alberi sottili. Fatto di aperture è
l'edificio sfuggente, quinta senza spessore. L'aria penetra a traverso la grande arcata,
non ha più bisogno di limitazioni spaziali, di essere raccolta in una conca, per do-
minare, sensibile, sopra ogni forma. Il colore le obbedisce: non più note acute e squilli,
ma armonie, che s'intonano col diffuso viola. Le fórme le obbediscono: le definizioni
lineari vanno perdendosi, i panni si fanno larghi, girano a ruota, per facilitare la fu-
sione delle forme con l'atmosfera. L'aggruppamento è ancora denso; certo molto altro
cammino farà il pittore prima d'arrivare, per esempio, all'affresco di Poggio a Caiano,
di cui questo è preludio. Si noti, però, specialmente la figura tutta drappi che si ri-
volge, a sinistra, e il ritratto di Jacopo Sansovino. C'è qui già una grande libertà di
fare e una modellatura tutta nuova, in contrasto con quella minuziosa e rotonda, che
si vede in altri personaggi del corteo.
L'architettura esile e svotata, sperimentata in quest'affresco, è anche nell'Annun-
ciazione, dipinta per i frati di San Gallo, che è ora a Pitti, tutta guasta da ridipinture.1
Ma il cielo qui non s'allontana e sono in disaccordo col fondo le figure di primo
piano, specie il compatto gruppo dei tre angeli. Bisogna, però, tener presente che i rap-
porti dei toni sono alteratissimi dai restauri. Il modello è la pala di Mariotto Alberti-
nelli, dell'Academia. Se la modellatura tondeggiante e minuziosa degli angeli mani-
festa ancora la prima maniera di Andrea, nella Vergine appare già il tipo della Ma-
donna delle Arpie. Anche il gesto della Vergine, che poggia il libro sulla gamba pie-
gata, si ripeterà, sia pur con enfasi maggiore, nella Madonna delle Arpie. Così anche la
sua forma affusata, la quale ha qui, però, un moto d'avvitamento che là meno si
sente. Le forme si sono ingrandite, il pittore ha acquistato sicurezza e disinvoltura.
Le maggiori conquiste, tuttavia, egli le fa nell'affresco.
Si raccoglie l'atmosfera in ambiente chiuso nella natività della Vergine2 (fig. 2), la cui
composizione è ispirata a quella di ugual soggetto, del Ghirlandaio. In questo caso,
però, la somiglianza dello schema compositivo serve più a far sentire le qualità dell'arte
nuova, che a far notare l'origine dell'ispirazione. Quanto a questa e alle sue conse-
guenze, si può dire soltanto che Andrea, il quale certo non ha qualità di costruttore e
di architetto e tenderà sempre più a eliminare le determinazioni d'ambiente, per la-
sciare unico valore di profondità e d'estensione all'atmosfera senza confini, in questa
pittura, invece, squadra, misura, limita in ogni senso il luogo, entro cui si muovono le
I Sala di Giove, mini. 124. L'epoca, in cui questa
tavola fu dipinta, si può determinare approssima-
tivamente dietro la scorta del Vasari, il quale,
nella vita del Pontormo, dice che questi andò a
stare con Andrea del Sarto « quando appunto egli
aveva fornito nel cortile de' Servi le storie di San
Filippo ». Poi, dopo aver narrato che il Pontormo
alla scuola di Andrea profittò tanto in poco tempo,
che pareva che ci fosse stato molti anni, seguita:
« Ora avendo Andrea di que' giorni finita una ta-
vola d'ima Nunziata per la chiesa de' frati di San-
galli) oggi rovinata, come si è detto nella sua vita,
egli diede a fare la predella di quella tavola a olio
a Jacopo ». La predella è perduta. Il Vasari narra
ancora che Jacopo stette con Andrea fino a quando
non fece nel portico dell'Annunciata una Fede e
una Carità, poco dopo l'elezione di papa Leone X.
Sicché l'Annunciata fu fatta prima del 1513.
II Vasari, dopo aver parlato dall'Apparizione di
Cristo alla Maddalena, dice che «ella fu cagione
che non molto poi (Andrea) ne fece due altre nella
medesima chiesa » cioè in San Gallo, e che poi anche
queste furono portate in San Jacopo tra i Fossi.
L'Annunciazione, di cui ora si parla, è una delle
due tavole citate dal Vasari, e l'altra è la Disputa
della Trinità, che si conserva a Pitti.
Nel 1626 la granduchessa Maria Maddalena,
vedova di Cosimo II de' Medici, ornò dell'.Annun-
ciazione una nuova cappella fabbricata nell'ala
dell'edificio, che continua palazzo Pitti. (Nota al
Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 17).
Sul leggio della Vergine, è scritto: «Andrea del
Sarto tapinta qui come nel cjuor ti porta e non qua!
sei, Maria, per isparger tuo (sic) gloria e non suo
nome ».
2 Nel chiostrino dell'Annunciata. La storia
cominciò ad esser pagata ad Andrea, con un ac-
conto, nel 151 1 (25 di dicembre), ma egli la finì,
cioè la fece, nel 1514. La data è scritta sull'archi-
trave del caminetto, sopra la nota sigla. Non con-
tento di aver messo la sigla, il pittore scrisse anche,
sul frontone del caminetto, « Andreas faciebat ».
Egli dovè compiacersi dell'opera sua bella.
GIULIA SINIBALD1
in profondità. Tremuli, nell'aria tremula, sono i due alberi sottili. Fatto di aperture è
l'edificio sfuggente, quinta senza spessore. L'aria penetra a traverso la grande arcata,
non ha più bisogno di limitazioni spaziali, di essere raccolta in una conca, per do-
minare, sensibile, sopra ogni forma. Il colore le obbedisce: non più note acute e squilli,
ma armonie, che s'intonano col diffuso viola. Le fórme le obbediscono: le definizioni
lineari vanno perdendosi, i panni si fanno larghi, girano a ruota, per facilitare la fu-
sione delle forme con l'atmosfera. L'aggruppamento è ancora denso; certo molto altro
cammino farà il pittore prima d'arrivare, per esempio, all'affresco di Poggio a Caiano,
di cui questo è preludio. Si noti, però, specialmente la figura tutta drappi che si ri-
volge, a sinistra, e il ritratto di Jacopo Sansovino. C'è qui già una grande libertà di
fare e una modellatura tutta nuova, in contrasto con quella minuziosa e rotonda, che
si vede in altri personaggi del corteo.
L'architettura esile e svotata, sperimentata in quest'affresco, è anche nell'Annun-
ciazione, dipinta per i frati di San Gallo, che è ora a Pitti, tutta guasta da ridipinture.1
Ma il cielo qui non s'allontana e sono in disaccordo col fondo le figure di primo
piano, specie il compatto gruppo dei tre angeli. Bisogna, però, tener presente che i rap-
porti dei toni sono alteratissimi dai restauri. Il modello è la pala di Mariotto Alberti-
nelli, dell'Academia. Se la modellatura tondeggiante e minuziosa degli angeli mani-
festa ancora la prima maniera di Andrea, nella Vergine appare già il tipo della Ma-
donna delle Arpie. Anche il gesto della Vergine, che poggia il libro sulla gamba pie-
gata, si ripeterà, sia pur con enfasi maggiore, nella Madonna delle Arpie. Così anche la
sua forma affusata, la quale ha qui, però, un moto d'avvitamento che là meno si
sente. Le forme si sono ingrandite, il pittore ha acquistato sicurezza e disinvoltura.
Le maggiori conquiste, tuttavia, egli le fa nell'affresco.
Si raccoglie l'atmosfera in ambiente chiuso nella natività della Vergine2 (fig. 2), la cui
composizione è ispirata a quella di ugual soggetto, del Ghirlandaio. In questo caso,
però, la somiglianza dello schema compositivo serve più a far sentire le qualità dell'arte
nuova, che a far notare l'origine dell'ispirazione. Quanto a questa e alle sue conse-
guenze, si può dire soltanto che Andrea, il quale certo non ha qualità di costruttore e
di architetto e tenderà sempre più a eliminare le determinazioni d'ambiente, per la-
sciare unico valore di profondità e d'estensione all'atmosfera senza confini, in questa
pittura, invece, squadra, misura, limita in ogni senso il luogo, entro cui si muovono le
I Sala di Giove, mini. 124. L'epoca, in cui questa
tavola fu dipinta, si può determinare approssima-
tivamente dietro la scorta del Vasari, il quale,
nella vita del Pontormo, dice che questi andò a
stare con Andrea del Sarto « quando appunto egli
aveva fornito nel cortile de' Servi le storie di San
Filippo ». Poi, dopo aver narrato che il Pontormo
alla scuola di Andrea profittò tanto in poco tempo,
che pareva che ci fosse stato molti anni, seguita:
« Ora avendo Andrea di que' giorni finita una ta-
vola d'ima Nunziata per la chiesa de' frati di San-
galli) oggi rovinata, come si è detto nella sua vita,
egli diede a fare la predella di quella tavola a olio
a Jacopo ». La predella è perduta. Il Vasari narra
ancora che Jacopo stette con Andrea fino a quando
non fece nel portico dell'Annunciata una Fede e
una Carità, poco dopo l'elezione di papa Leone X.
Sicché l'Annunciata fu fatta prima del 1513.
II Vasari, dopo aver parlato dall'Apparizione di
Cristo alla Maddalena, dice che «ella fu cagione
che non molto poi (Andrea) ne fece due altre nella
medesima chiesa » cioè in San Gallo, e che poi anche
queste furono portate in San Jacopo tra i Fossi.
L'Annunciazione, di cui ora si parla, è una delle
due tavole citate dal Vasari, e l'altra è la Disputa
della Trinità, che si conserva a Pitti.
Nel 1626 la granduchessa Maria Maddalena,
vedova di Cosimo II de' Medici, ornò dell'.Annun-
ciazione una nuova cappella fabbricata nell'ala
dell'edificio, che continua palazzo Pitti. (Nota al
Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 17).
Sul leggio della Vergine, è scritto: «Andrea del
Sarto tapinta qui come nel cjuor ti porta e non qua!
sei, Maria, per isparger tuo (sic) gloria e non suo
nome ».
2 Nel chiostrino dell'Annunciata. La storia
cominciò ad esser pagata ad Andrea, con un ac-
conto, nel 151 1 (25 di dicembre), ma egli la finì,
cioè la fece, nel 1514. La data è scritta sull'archi-
trave del caminetto, sopra la nota sigla. Non con-
tento di aver messo la sigla, il pittore scrisse anche,
sul frontone del caminetto, « Andreas faciebat ».
Egli dovè compiacersi dell'opera sua bella.