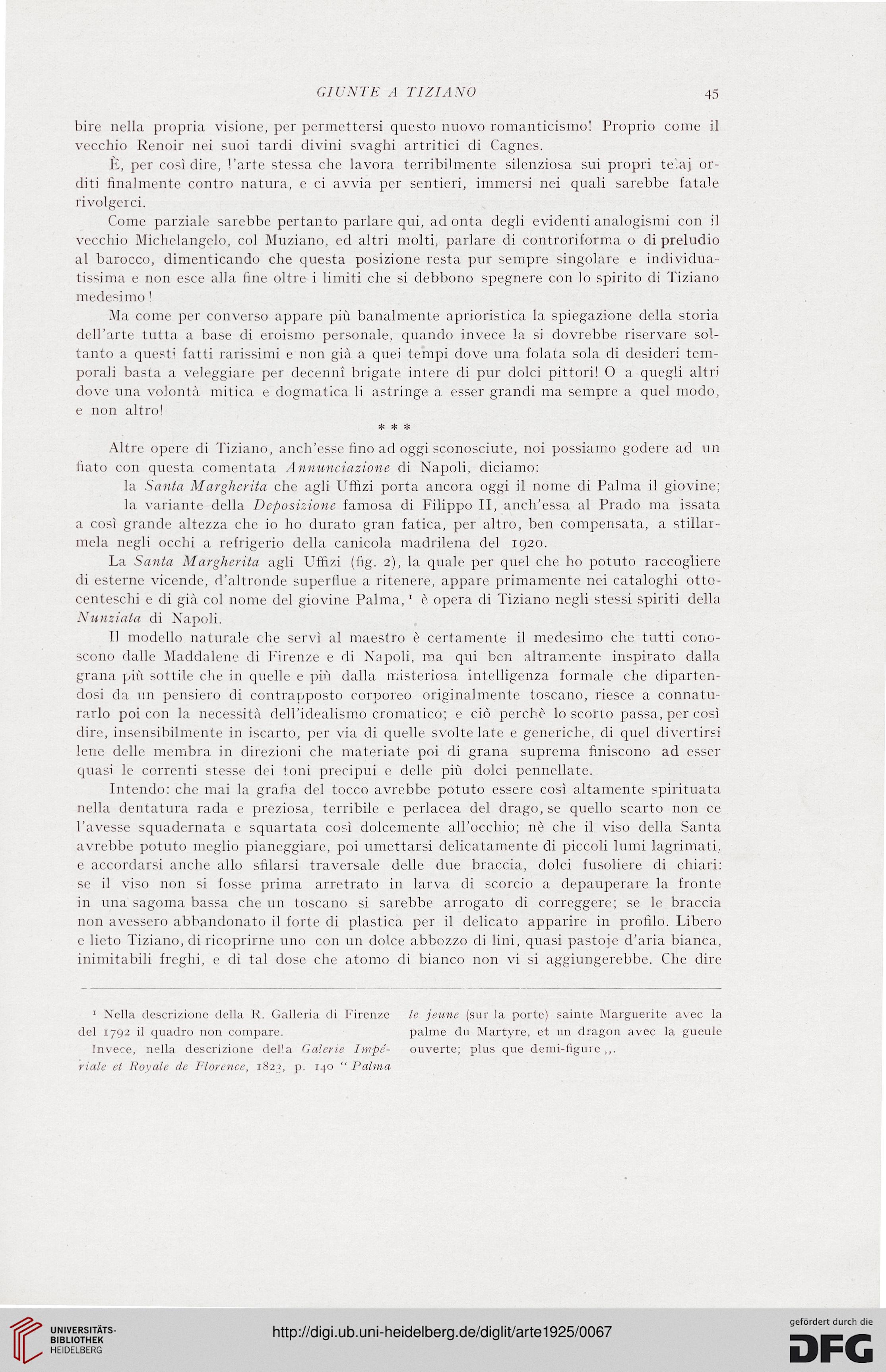GIUNTE A TIZIANO
45
bire nella propria visione, por permettersi questo nuovo romanticismo! Proprio come il
vecchio Renoir nei suoi tardi divini svaghi artritici di Cagnes.
È, per così dire, l'arte stessa che lavora terribilmente silenziosa sui propri te'.aj or-
diti finalmente contro natura, e ci avvia per sentieri, immersi nei quali sarebbe fatale
rivolgerci.
Come parziale sarebbe pertanto parlare qui, ad onta degli evidenti analogismi con il
vecchio Michelangelo, col Muziano, ed altri molti, parlare di controriforma o di preludio
al barocco, dimenticando che questa posizione resta pur sempre singolare e individua-
tisi]'ma e non esce alla fine oltre i limiti che si debbono spegnere con lo spirito di Tiziano
medesimo !
Ma come per converso appare più banalmente aprioristica la spiegazione della storia
dell'arte tutta a base di eroismo personale, quando invece la si dovrebbe riservare sol-
tanto a questi fatti rarissimi e non già a quei tempi dove una folata sola di desideri tem-
porali basta a veleggiare per decenni brigate intere di pur dolci pittori! O a quegli altri
dove una volontà mitica e dogmatica li astringe a esser grandi ma sempre a quel modo,
e non altro!
* * *
Altre opere di Tiziano, anch'esse fino ad oggi sconosciute, noi possiamo godere ad un
fiato con questa comentata Annunciazione di Napoli, diciamo:
la Santa Margherita che agli Uffìzi porta ancora oggi il nome di Palma il giovine;
la variante della Deposizione famosa di Filippo II, anch'essa al Prado ma issata
a così grande altezza che io ho durato gran fatica, per altro, ben compensata, a stillar
mela negli occhi a refrigerio della canicola madrilena del 1920.
La Santa Margherita agli Uffizi (fig. 2), la quale per quel che ho potuto raccogliere
di esterne vicende, d'altronde superflue a ritenere, appare primamente nei cataloghi otto-
centeschi e di già col nome del giovine Palma,1 è opera di Tiziano negli stessi spiriti della
Nunziata di Napoli.
Il modello naturale che servì al maestro è certamente il medesimo che tutti cono-
scono dalle Maddalene di Firenze e di Napoli, ma qui ben altramente inspirato dalla
grana più sottile che in quelle e più dalla misteriosa intelligenza formale che diparten-
dosi da un pensiero di contrapposto corporeo originalmente toscano, riesce a connatu-
rarlo poi con la necessità dell'idealismo cromatico; e ciò perchè lo scorto passa, per così
dire, insensibilmente in iscarto, per via di quelle svolte late e generiche, di quel divertirsi
lene delle membra in direzioni che materiate poi di grana suprema finiscono ad esser
quasi le correnti stesse dei toni precipui e delle più dolci pennellate.
Intendo: che mai la grafia del tocco avrebbe potuto essere così altamente spiritual:!
nella dentatura rada e preziosa, terribile e perlacea del drago, se quello scarto non ce
l'avesse squadernata e squartata così dolcemente all'occhio; nè che il viso della Santa
avrebbe potuto meglio pianeggiare, poi umettarsi delicatamente di piccoli lumi lagrimati,
e accordarsi anche allo sfilarsi traversale delle due braccia, dolci fusoliere di chiari:
se il viso non si fosse prima arretrato in larva di scorcio a depauperare la fronte
in una sagoma bassa che un toscano si sarebbe arrogato di correggere; se le braccia
non avessero abbandonato il forte di plastica per il delicato apparire in profilo. Libero
e lieto Tiziano, di ricoprirne uno con un dolce abbozzo di lini, quasi pastoje d'aria bianca,
inimitabili freghi, e di tal dose che atomo di bianco non vi si aggiungerebbe. Che dire
1 Nella descrizione della R. Galleria di Firenze
del 1792 il quadro non compare.
Invece, nella descrizione della Galerie Impe-
riale et Royale de Florence, 182?, p. 140 " Palma
le jeune (sur la porte) sainte Marguerite avec la
palme du Martyrc, et un dragon avec la gueule
ouverte; plus que demi-figure ,,.
45
bire nella propria visione, por permettersi questo nuovo romanticismo! Proprio come il
vecchio Renoir nei suoi tardi divini svaghi artritici di Cagnes.
È, per così dire, l'arte stessa che lavora terribilmente silenziosa sui propri te'.aj or-
diti finalmente contro natura, e ci avvia per sentieri, immersi nei quali sarebbe fatale
rivolgerci.
Come parziale sarebbe pertanto parlare qui, ad onta degli evidenti analogismi con il
vecchio Michelangelo, col Muziano, ed altri molti, parlare di controriforma o di preludio
al barocco, dimenticando che questa posizione resta pur sempre singolare e individua-
tisi]'ma e non esce alla fine oltre i limiti che si debbono spegnere con lo spirito di Tiziano
medesimo !
Ma come per converso appare più banalmente aprioristica la spiegazione della storia
dell'arte tutta a base di eroismo personale, quando invece la si dovrebbe riservare sol-
tanto a questi fatti rarissimi e non già a quei tempi dove una folata sola di desideri tem-
porali basta a veleggiare per decenni brigate intere di pur dolci pittori! O a quegli altri
dove una volontà mitica e dogmatica li astringe a esser grandi ma sempre a quel modo,
e non altro!
* * *
Altre opere di Tiziano, anch'esse fino ad oggi sconosciute, noi possiamo godere ad un
fiato con questa comentata Annunciazione di Napoli, diciamo:
la Santa Margherita che agli Uffìzi porta ancora oggi il nome di Palma il giovine;
la variante della Deposizione famosa di Filippo II, anch'essa al Prado ma issata
a così grande altezza che io ho durato gran fatica, per altro, ben compensata, a stillar
mela negli occhi a refrigerio della canicola madrilena del 1920.
La Santa Margherita agli Uffizi (fig. 2), la quale per quel che ho potuto raccogliere
di esterne vicende, d'altronde superflue a ritenere, appare primamente nei cataloghi otto-
centeschi e di già col nome del giovine Palma,1 è opera di Tiziano negli stessi spiriti della
Nunziata di Napoli.
Il modello naturale che servì al maestro è certamente il medesimo che tutti cono-
scono dalle Maddalene di Firenze e di Napoli, ma qui ben altramente inspirato dalla
grana più sottile che in quelle e più dalla misteriosa intelligenza formale che diparten-
dosi da un pensiero di contrapposto corporeo originalmente toscano, riesce a connatu-
rarlo poi con la necessità dell'idealismo cromatico; e ciò perchè lo scorto passa, per così
dire, insensibilmente in iscarto, per via di quelle svolte late e generiche, di quel divertirsi
lene delle membra in direzioni che materiate poi di grana suprema finiscono ad esser
quasi le correnti stesse dei toni precipui e delle più dolci pennellate.
Intendo: che mai la grafia del tocco avrebbe potuto essere così altamente spiritual:!
nella dentatura rada e preziosa, terribile e perlacea del drago, se quello scarto non ce
l'avesse squadernata e squartata così dolcemente all'occhio; nè che il viso della Santa
avrebbe potuto meglio pianeggiare, poi umettarsi delicatamente di piccoli lumi lagrimati,
e accordarsi anche allo sfilarsi traversale delle due braccia, dolci fusoliere di chiari:
se il viso non si fosse prima arretrato in larva di scorcio a depauperare la fronte
in una sagoma bassa che un toscano si sarebbe arrogato di correggere; se le braccia
non avessero abbandonato il forte di plastica per il delicato apparire in profilo. Libero
e lieto Tiziano, di ricoprirne uno con un dolce abbozzo di lini, quasi pastoje d'aria bianca,
inimitabili freghi, e di tal dose che atomo di bianco non vi si aggiungerebbe. Che dire
1 Nella descrizione della R. Galleria di Firenze
del 1792 il quadro non compare.
Invece, nella descrizione della Galerie Impe-
riale et Royale de Florence, 182?, p. 140 " Palma
le jeune (sur la porte) sainte Marguerite avec la
palme du Martyrc, et un dragon avec la gueule
ouverte; plus que demi-figure ,,.