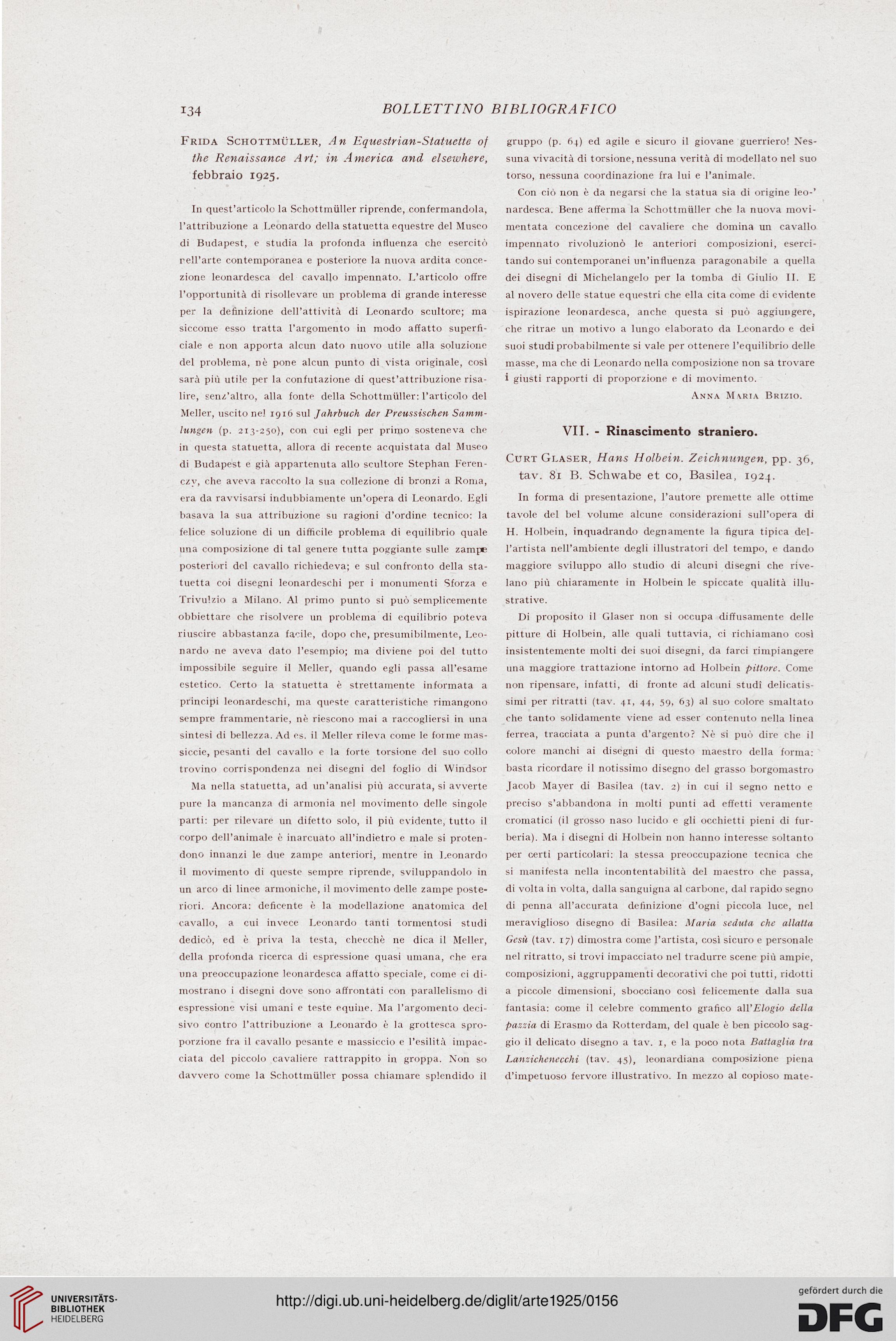134
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Frida Schottmuller, An Equestrian-Statuette of
the Renaissance Art; in America and elsewhere,
febbraio 1925.
In quest'articolo la Schottmuller riprende, confermandola,
l'attribuzione a Leonardo della statuetta equestre del Museo
di Budapest, e studia la profonda influenza che esercitò
rell'arte contemporanea e posteriore la nuova ardita conce-
zione leonardesca del cavallo impennato. L'articolo offre
l'opportunità di risollevare un problema di grande interesse
per la definizione dell'attività di Leonardo scultore; ma
siccome esso tratta l'argomento in modo affatto superfi-
ciale e non apporta alcun dato nuovo utile alla soluzione
del problema, nè pone alcun punto di vista originale, cosi
sarà più utile per la confutazione di quest'attribuzione risa-
lire, senz'altro, alla fonte della Schottmuller: l'articolo del
Meller, uscito nel 1916 sul Jahrbuch der Preussischen Samm-
lungen (p. 213-250), con cui egli per primo sosteneva che
in questa statuetta, allora di recente acquistata dal Museo
di Budapest e già appartenuta allo scultore Stephan Feren-
czy, che aveva raccolto la sua collezione di bronzi a Roma,
era da ravvisarsi indubbiamente un'opera di Leonardo. Egli
basava la sua attribuzione su ragioni d'ordine tecnico: la
felice soluzione di un difficile problema di equilibrio quale
una composizione di tal genere tutta poggiante sulle zampe
posteriori del cavallo richiedeva; e sul confronto della sta-
tuetta coi disegni leonardeschi per i monumenti Sforza e
Trivulzio a Milano. Al primo punto si può semplicemente
obbiettare che risolvere un problema di equilibrio poteva
riuscire abbastanza facile, dopo che, presumibilmente, Leo-
nardo ne aveva dato l'esempio; ma diviene poi del tutto
impossibile seguire il Meller, quando egli passa all'esame
estetico. Certo la statuetta è strettamente informata a
principi leonardeschi, ma queste caratteristiche rimangono
sempre frammentarie, nè. riescono mai a raccogliersi in una
sintesi di bellezza. Ad es. il Meller rileva come le forme mas-
siccie, pesanti del cavallo e la forte torsione del suo collo
trovino corrispondenza nei disegni del foglio di Windsor
Ma nella statuetta, ad un'analisi più accurata, si avverte
pure la mancanza di armonia nel movimento delle singole
parti: per rilevare un difetto solo, il più evidente, tutto il
corpo dell'animale è inarcuato all'indietro e male si proten-
dono innanzi le due zampe anteriori, mentre in Leonardo
il movimento di queste sempre riprende, sviluppandolo in
un arco di linee armoniche, il movimento delle zampe poste-
riori. Ancora: deficente è la modellazione anatomica del
cavallo, a cui invece Leonardo tanti tormentosi studi
dedicò, ed è priva la testa, checché ne dica il Meller,
della profonda ricerca di espressione quasi umana, che era
una preoccupazione leonardesca affatto speciale, come ci di-
mostrano i disegni dove sono affrontati con parallelismo di
espressione visi umani e teste equine. Ma l'argomento deci-
sivo contro l'attribuzione a Leonardo è la grottesca spro-
porzione fra il cavallo pesante e massiccio e l'esilità impac-
ciata del piccolo cavaliere rattrappito in groppa. Non so
davvero come la Schottmuller possa chiamare splendido il
gruppo (p. 64) ed agile e sicuro il giovane guerriero! Nes-
suna vivacità di torsione, nessuna verità di modellato nel suo
torso, nessuna coordinazione fra lui e l'animale.
Con ciò non è da negarsi che la statua sia di origine leo-'
nardesca. Bene afferma la Schottmuller che la nuova movi-
mentata concezione del cavaliere che domina un cavallo
impennato rivoluzionò le anteriori composizioni, eserci-
tando sui contemporanei un'influenza paragonabile a quella
dei disegni di Michelangelo per la tomba di Giulio IL E
al novero delle statue equestri che ella cita come di evidente
ispirazione leonardesca, anche questa si può aggiungere,
che ritrae un motivo a lungo elaborato da Leonardo e dei
suoi studi probabilmente si vale per ottenere l'equilibrio delle
masse, ma che di Leonardo nella composizione non sa trovare
i giusti rapporti di proporzione e di movimento.
Anna Mvrta Brizio.
VII. - Rinascimento straniero.
Curt Glaser, Hans Holbein. Zeichnungen, pp. 36,
tav. 81 B. Schwabe et co, Basilea, 1924.
In forma di presentazione, l'autore premette alle ottime
tavole del bel volume alcune considerazioni sull'opera di
H. Holbein, inquadrando degnamente la figura tipica del-
l'artista nell'ambiente degli illustratori del tempo, e dando
maggiore sviluppo allo studio di alcuni disegni che rive-
lano più chiaramente in Holbein le spiccate qualità illu-
strative.
Di proposito il Glaser non si occupa diffusamente delle
pitture di Holbein, alle quali tuttavia, ci richiamano cosi
insistentemente molti dei suoi disegni, da farci rimpiangere
una maggiore trattazione intorno ad Holbein pittore. Come
non ripensare, infatti, di fronte ad alcuni studi delicatis-
simi per ritratti (tav. 41, 44, 59, 63) al suo colore smaltato
che tanto solidamente viene ad esser contenuto nella linea
ferrea, tracciata a punta d'argento? Nè si può dire che il
colore manchi ai disegni di questo maestro della forma:
basta ricordare il notissimo disegno del grasso borgomastro
Jacob Mayer di Basilea (tav. 2) in cui il segno netto e
preciso s'abbandona in molti punti ad effetti veramente
cromatici (il grosso naso lucido e gli occhietti pieni di fur-
beria). Ma i disegni di Holbein non hanno interesse soltanto
per certi particolari: la stessa preoccupazione tecnica che
si manifesta nella incontentabilità del maestro che passa,
di volta in volta, dalla sanguigna al carbone, dal rapido segno
di penna all'accurata definizione d'ogni piccola luce, nel
meraviglioso disegno di Basilea: Maria seduta che allatta
Gesù (tav. 17) dimostra come l'artista, così sicuro e personale
nel ritratto, si trovi impacciato nel tradurre scene più ampie,
composizioni, aggruppamenti decorativi che poi tutti, ridotti
a piccole dimensioni, sbocciano così felicemente dalla sua
fantasia: come il celebre commento grafico all'Elogio della
pazzia di Erasmo da Rotterdam, del quale è ben piccolo sag-
gio il delicato disegno a tav. 1, e la poco nota Battaglia tra
Lanzichenecchi (tav. 45), leonardiana composizione piena
d'impetuoso fervore illustrativo. In mezzo al copioso mate-
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Frida Schottmuller, An Equestrian-Statuette of
the Renaissance Art; in America and elsewhere,
febbraio 1925.
In quest'articolo la Schottmuller riprende, confermandola,
l'attribuzione a Leonardo della statuetta equestre del Museo
di Budapest, e studia la profonda influenza che esercitò
rell'arte contemporanea e posteriore la nuova ardita conce-
zione leonardesca del cavallo impennato. L'articolo offre
l'opportunità di risollevare un problema di grande interesse
per la definizione dell'attività di Leonardo scultore; ma
siccome esso tratta l'argomento in modo affatto superfi-
ciale e non apporta alcun dato nuovo utile alla soluzione
del problema, nè pone alcun punto di vista originale, cosi
sarà più utile per la confutazione di quest'attribuzione risa-
lire, senz'altro, alla fonte della Schottmuller: l'articolo del
Meller, uscito nel 1916 sul Jahrbuch der Preussischen Samm-
lungen (p. 213-250), con cui egli per primo sosteneva che
in questa statuetta, allora di recente acquistata dal Museo
di Budapest e già appartenuta allo scultore Stephan Feren-
czy, che aveva raccolto la sua collezione di bronzi a Roma,
era da ravvisarsi indubbiamente un'opera di Leonardo. Egli
basava la sua attribuzione su ragioni d'ordine tecnico: la
felice soluzione di un difficile problema di equilibrio quale
una composizione di tal genere tutta poggiante sulle zampe
posteriori del cavallo richiedeva; e sul confronto della sta-
tuetta coi disegni leonardeschi per i monumenti Sforza e
Trivulzio a Milano. Al primo punto si può semplicemente
obbiettare che risolvere un problema di equilibrio poteva
riuscire abbastanza facile, dopo che, presumibilmente, Leo-
nardo ne aveva dato l'esempio; ma diviene poi del tutto
impossibile seguire il Meller, quando egli passa all'esame
estetico. Certo la statuetta è strettamente informata a
principi leonardeschi, ma queste caratteristiche rimangono
sempre frammentarie, nè. riescono mai a raccogliersi in una
sintesi di bellezza. Ad es. il Meller rileva come le forme mas-
siccie, pesanti del cavallo e la forte torsione del suo collo
trovino corrispondenza nei disegni del foglio di Windsor
Ma nella statuetta, ad un'analisi più accurata, si avverte
pure la mancanza di armonia nel movimento delle singole
parti: per rilevare un difetto solo, il più evidente, tutto il
corpo dell'animale è inarcuato all'indietro e male si proten-
dono innanzi le due zampe anteriori, mentre in Leonardo
il movimento di queste sempre riprende, sviluppandolo in
un arco di linee armoniche, il movimento delle zampe poste-
riori. Ancora: deficente è la modellazione anatomica del
cavallo, a cui invece Leonardo tanti tormentosi studi
dedicò, ed è priva la testa, checché ne dica il Meller,
della profonda ricerca di espressione quasi umana, che era
una preoccupazione leonardesca affatto speciale, come ci di-
mostrano i disegni dove sono affrontati con parallelismo di
espressione visi umani e teste equine. Ma l'argomento deci-
sivo contro l'attribuzione a Leonardo è la grottesca spro-
porzione fra il cavallo pesante e massiccio e l'esilità impac-
ciata del piccolo cavaliere rattrappito in groppa. Non so
davvero come la Schottmuller possa chiamare splendido il
gruppo (p. 64) ed agile e sicuro il giovane guerriero! Nes-
suna vivacità di torsione, nessuna verità di modellato nel suo
torso, nessuna coordinazione fra lui e l'animale.
Con ciò non è da negarsi che la statua sia di origine leo-'
nardesca. Bene afferma la Schottmuller che la nuova movi-
mentata concezione del cavaliere che domina un cavallo
impennato rivoluzionò le anteriori composizioni, eserci-
tando sui contemporanei un'influenza paragonabile a quella
dei disegni di Michelangelo per la tomba di Giulio IL E
al novero delle statue equestri che ella cita come di evidente
ispirazione leonardesca, anche questa si può aggiungere,
che ritrae un motivo a lungo elaborato da Leonardo e dei
suoi studi probabilmente si vale per ottenere l'equilibrio delle
masse, ma che di Leonardo nella composizione non sa trovare
i giusti rapporti di proporzione e di movimento.
Anna Mvrta Brizio.
VII. - Rinascimento straniero.
Curt Glaser, Hans Holbein. Zeichnungen, pp. 36,
tav. 81 B. Schwabe et co, Basilea, 1924.
In forma di presentazione, l'autore premette alle ottime
tavole del bel volume alcune considerazioni sull'opera di
H. Holbein, inquadrando degnamente la figura tipica del-
l'artista nell'ambiente degli illustratori del tempo, e dando
maggiore sviluppo allo studio di alcuni disegni che rive-
lano più chiaramente in Holbein le spiccate qualità illu-
strative.
Di proposito il Glaser non si occupa diffusamente delle
pitture di Holbein, alle quali tuttavia, ci richiamano cosi
insistentemente molti dei suoi disegni, da farci rimpiangere
una maggiore trattazione intorno ad Holbein pittore. Come
non ripensare, infatti, di fronte ad alcuni studi delicatis-
simi per ritratti (tav. 41, 44, 59, 63) al suo colore smaltato
che tanto solidamente viene ad esser contenuto nella linea
ferrea, tracciata a punta d'argento? Nè si può dire che il
colore manchi ai disegni di questo maestro della forma:
basta ricordare il notissimo disegno del grasso borgomastro
Jacob Mayer di Basilea (tav. 2) in cui il segno netto e
preciso s'abbandona in molti punti ad effetti veramente
cromatici (il grosso naso lucido e gli occhietti pieni di fur-
beria). Ma i disegni di Holbein non hanno interesse soltanto
per certi particolari: la stessa preoccupazione tecnica che
si manifesta nella incontentabilità del maestro che passa,
di volta in volta, dalla sanguigna al carbone, dal rapido segno
di penna all'accurata definizione d'ogni piccola luce, nel
meraviglioso disegno di Basilea: Maria seduta che allatta
Gesù (tav. 17) dimostra come l'artista, così sicuro e personale
nel ritratto, si trovi impacciato nel tradurre scene più ampie,
composizioni, aggruppamenti decorativi che poi tutti, ridotti
a piccole dimensioni, sbocciano così felicemente dalla sua
fantasia: come il celebre commento grafico all'Elogio della
pazzia di Erasmo da Rotterdam, del quale è ben piccolo sag-
gio il delicato disegno a tav. 1, e la poco nota Battaglia tra
Lanzichenecchi (tav. 45), leonardiana composizione piena
d'impetuoso fervore illustrativo. In mezzo al copioso mate-