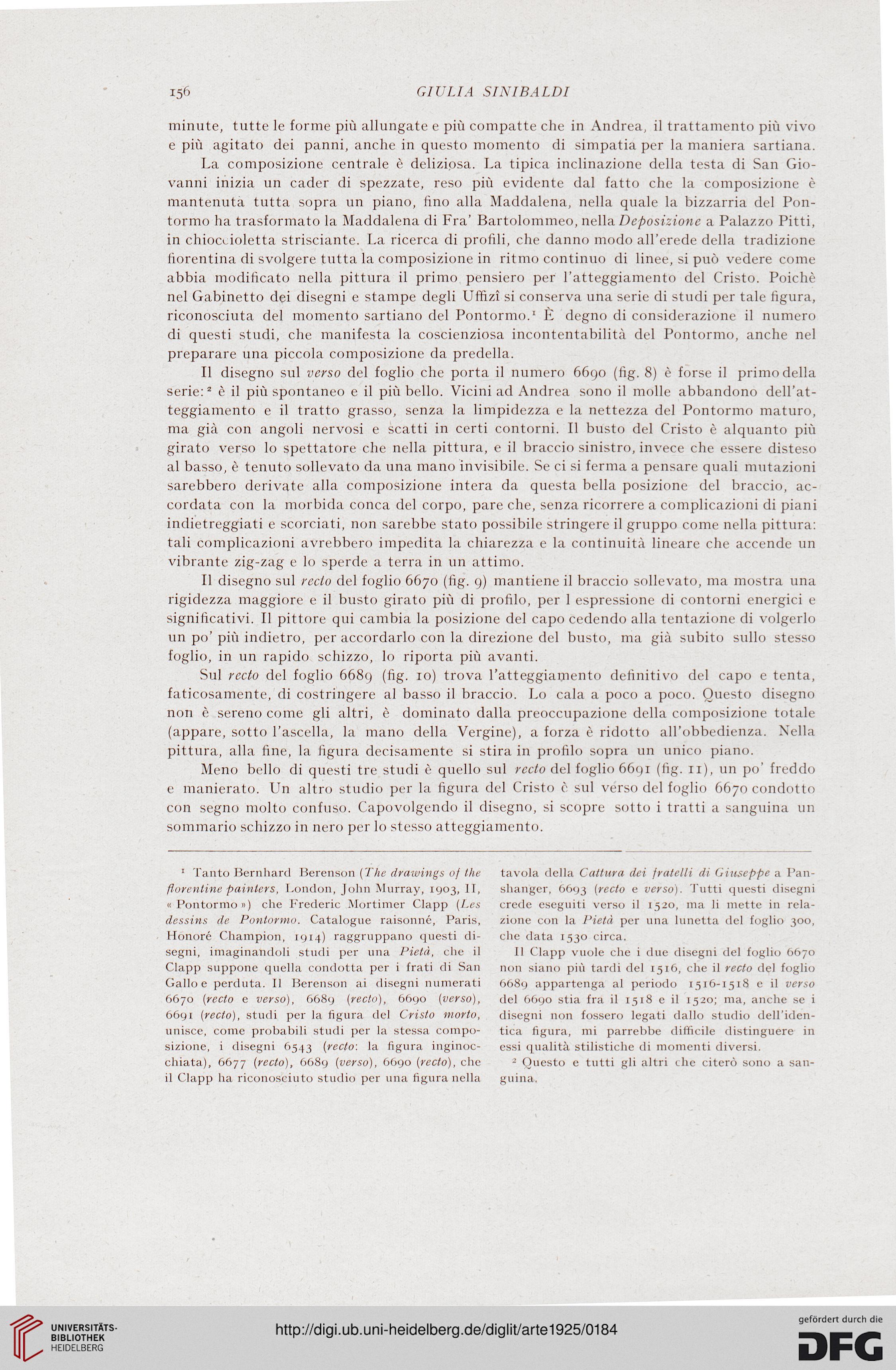156 GIULIA SINIBALDI
minute, tutte le forme più allungate e più compatte che in Andrea, il trattamento più vivo
e più agitato dei panni, anche in questo momento di simpatia per la maniera sartiana.
La composizione centrale è deliziosa. La tipica inclinazione della testa di San Gio-
vanni inizia un cader di spezzate, reso più evidente dal fatto che la composizione è
mantenuta tutta sopra un piano, fino alla Maddalena, nella quale la bizzarria del Pon-
tormo ha trasformato la Maddalena di Fra' Bartolommeo, nella Deposizione a Palazzo Pitti,
in chioceioletta strisciante. La ricerca di profili, che danno modo all'erede della tradizione
fiorentina di svolgere tutta la composizione in ritmo continuo di linee, si può vedere come
abbia modificato nella pittura il primo pensiero per l'atteggiamento del Cristo. Poiché
nel Gabinetto dei disegni e stampe degli Uffizi si conserva una serie di studi per tale figura,
riconosciuta del momento sartiano del Pontormo.1 li degno di considerazione il numero
di questi studi, che manifesta la coscienziosa incontentabilità del Pontormo, anche nel
preparare una piccola composizione da predella.
Il disegno sul verso del foglio che porta il numero 6690 (fig. 8) è forse il primo della
serie:2 è il più spontaneo e il più bello. Vicini ad Andrea sono il molle abbandono dell'at-
teggiamento e il tratto grasso, senza la limpidezza e la nettezza del Pontormo maturo,
ma già con angoli nervosi e scatti in certi contorni. Il busto del Cristo è alquanto più
girato verso lo spettatore che nella pittura, e il braccio sinistro, invece che essere disteso
al basso, è tenuto sollevato da una mano invisibile. Se ci si ferma a pensare quali mutazioni
sarebbero derivate alla composizione intera da questa bella posizione del braccio, ac-
cordata con la morbida conca del corpo, pare che, senza ricorrere a complicazioni di piani
indietreggiati e scorciati, non sarebbe stato possibile stringere il gruppo come nella pittura:
tali complicazioni avrebbero impedita la chiarezza e la continuità lineare che accende un
vibrante zig-zag e lo sperde a terra in un attimo.
Il disegno sul recto del foglio 6670 (fig. 9) mantiene il braccio sollevato, ma mostra una
rigidezza maggiore e il busto girato più di profilo, per 1 espressione di contorni energici e
significativi. Il pittore qui cambia la posizione del capo cedendo alla tentazione di volgerlo
un po' più indietro, per accordarlo con la direzione del busto, ma già subito sullo stesso
foglio, in un rapido schizzo, lo riporta più avanti.
Sul recto del foglio 6689 (fig. 10) trova l'atteggiamento definitivo del capo e tenta,
faticosamente, di costringere al basso il braccio. Lo cala a poco a poco. Questo disegno
non è sereno come gli altri, è dominato dalla preoccupazione della composizione totale
(appare, sotto l'ascella, la mano della Vergine), a forza è ridotto all'obbedienza. Nella
pittura, alla fine, la figura decisamente si stira in profilo sopra un unico piano.
Meno bello di questi tre studi è quello sul recto del foglio 6691 (fig. n), un po' freddo
e manierato. Un altro studio per la figura del Cristo è sul verso del foglio 6670 condotto
con segno molto confuso. Capovolgendo il disegno, si scopre sotto i tratti a sanguina un
sommario schizzo in nero per lo stesso atteggiamento.
1 Tanto Bernhard Berenson (The drawings of the
fiorentine painters, London, John Murray, 1903, li,
«Pontormo») che Frederic Mortimer Clapp (Les
dessins de Pontormo. Catalogne raisonné, Paris,
Hónoré Champion, 1914) raggruppano questi di-
segni, imaginandoli studi per una Pietà, che il
Clapp suppone quella condotta per i frati di San
Gallo e perduta. Il Berenson ai disegni numerati
6670 (recto e verso), 6689 (recto), 6690 (verso),
6691 (recto), studi per la figura del Cristo morto,
unisce, come probabili studi per la stessa compo-
sizione, i disegni 6543 (recto: la figura inginoc-
chiata), 6677 (recto), 6689 (verso), 6690 (recto), che
il Clapp ha riconosciuto studio per una figura nella
tavola della Cattura dei fratelli di (jiitseppe a Pan-
shanger, 6693 (recto e verso). Tutti questi disegni
crede eseguiti verso il 1520, ma li mette in rela-
zione con la Pietà per una lunetta del foglio 300,
che data 1530 circa.
Il Clapp vuole che i due disegni del foglio 6670
non siano più tardi del 1516, che il recto del foglio
6689 appartenga al periodo 1516-1518 e il verso
del 6690 stia fra il 1518 e il 1520; ma, anche se i
disegni non fossero legati dallo studio dell'iden-
tica figura, mi parrebbe difficile distinguere in
essi qualità stilistiche di momenti diversi.
2 Questo e tutti gli altri che citerò sono a san-
guina.
minute, tutte le forme più allungate e più compatte che in Andrea, il trattamento più vivo
e più agitato dei panni, anche in questo momento di simpatia per la maniera sartiana.
La composizione centrale è deliziosa. La tipica inclinazione della testa di San Gio-
vanni inizia un cader di spezzate, reso più evidente dal fatto che la composizione è
mantenuta tutta sopra un piano, fino alla Maddalena, nella quale la bizzarria del Pon-
tormo ha trasformato la Maddalena di Fra' Bartolommeo, nella Deposizione a Palazzo Pitti,
in chioceioletta strisciante. La ricerca di profili, che danno modo all'erede della tradizione
fiorentina di svolgere tutta la composizione in ritmo continuo di linee, si può vedere come
abbia modificato nella pittura il primo pensiero per l'atteggiamento del Cristo. Poiché
nel Gabinetto dei disegni e stampe degli Uffizi si conserva una serie di studi per tale figura,
riconosciuta del momento sartiano del Pontormo.1 li degno di considerazione il numero
di questi studi, che manifesta la coscienziosa incontentabilità del Pontormo, anche nel
preparare una piccola composizione da predella.
Il disegno sul verso del foglio che porta il numero 6690 (fig. 8) è forse il primo della
serie:2 è il più spontaneo e il più bello. Vicini ad Andrea sono il molle abbandono dell'at-
teggiamento e il tratto grasso, senza la limpidezza e la nettezza del Pontormo maturo,
ma già con angoli nervosi e scatti in certi contorni. Il busto del Cristo è alquanto più
girato verso lo spettatore che nella pittura, e il braccio sinistro, invece che essere disteso
al basso, è tenuto sollevato da una mano invisibile. Se ci si ferma a pensare quali mutazioni
sarebbero derivate alla composizione intera da questa bella posizione del braccio, ac-
cordata con la morbida conca del corpo, pare che, senza ricorrere a complicazioni di piani
indietreggiati e scorciati, non sarebbe stato possibile stringere il gruppo come nella pittura:
tali complicazioni avrebbero impedita la chiarezza e la continuità lineare che accende un
vibrante zig-zag e lo sperde a terra in un attimo.
Il disegno sul recto del foglio 6670 (fig. 9) mantiene il braccio sollevato, ma mostra una
rigidezza maggiore e il busto girato più di profilo, per 1 espressione di contorni energici e
significativi. Il pittore qui cambia la posizione del capo cedendo alla tentazione di volgerlo
un po' più indietro, per accordarlo con la direzione del busto, ma già subito sullo stesso
foglio, in un rapido schizzo, lo riporta più avanti.
Sul recto del foglio 6689 (fig. 10) trova l'atteggiamento definitivo del capo e tenta,
faticosamente, di costringere al basso il braccio. Lo cala a poco a poco. Questo disegno
non è sereno come gli altri, è dominato dalla preoccupazione della composizione totale
(appare, sotto l'ascella, la mano della Vergine), a forza è ridotto all'obbedienza. Nella
pittura, alla fine, la figura decisamente si stira in profilo sopra un unico piano.
Meno bello di questi tre studi è quello sul recto del foglio 6691 (fig. n), un po' freddo
e manierato. Un altro studio per la figura del Cristo è sul verso del foglio 6670 condotto
con segno molto confuso. Capovolgendo il disegno, si scopre sotto i tratti a sanguina un
sommario schizzo in nero per lo stesso atteggiamento.
1 Tanto Bernhard Berenson (The drawings of the
fiorentine painters, London, John Murray, 1903, li,
«Pontormo») che Frederic Mortimer Clapp (Les
dessins de Pontormo. Catalogne raisonné, Paris,
Hónoré Champion, 1914) raggruppano questi di-
segni, imaginandoli studi per una Pietà, che il
Clapp suppone quella condotta per i frati di San
Gallo e perduta. Il Berenson ai disegni numerati
6670 (recto e verso), 6689 (recto), 6690 (verso),
6691 (recto), studi per la figura del Cristo morto,
unisce, come probabili studi per la stessa compo-
sizione, i disegni 6543 (recto: la figura inginoc-
chiata), 6677 (recto), 6689 (verso), 6690 (recto), che
il Clapp ha riconosciuto studio per una figura nella
tavola della Cattura dei fratelli di (jiitseppe a Pan-
shanger, 6693 (recto e verso). Tutti questi disegni
crede eseguiti verso il 1520, ma li mette in rela-
zione con la Pietà per una lunetta del foglio 300,
che data 1530 circa.
Il Clapp vuole che i due disegni del foglio 6670
non siano più tardi del 1516, che il recto del foglio
6689 appartenga al periodo 1516-1518 e il verso
del 6690 stia fra il 1518 e il 1520; ma, anche se i
disegni non fossero legati dallo studio dell'iden-
tica figura, mi parrebbe difficile distinguere in
essi qualità stilistiche di momenti diversi.
2 Questo e tutti gli altri che citerò sono a san-
guina.