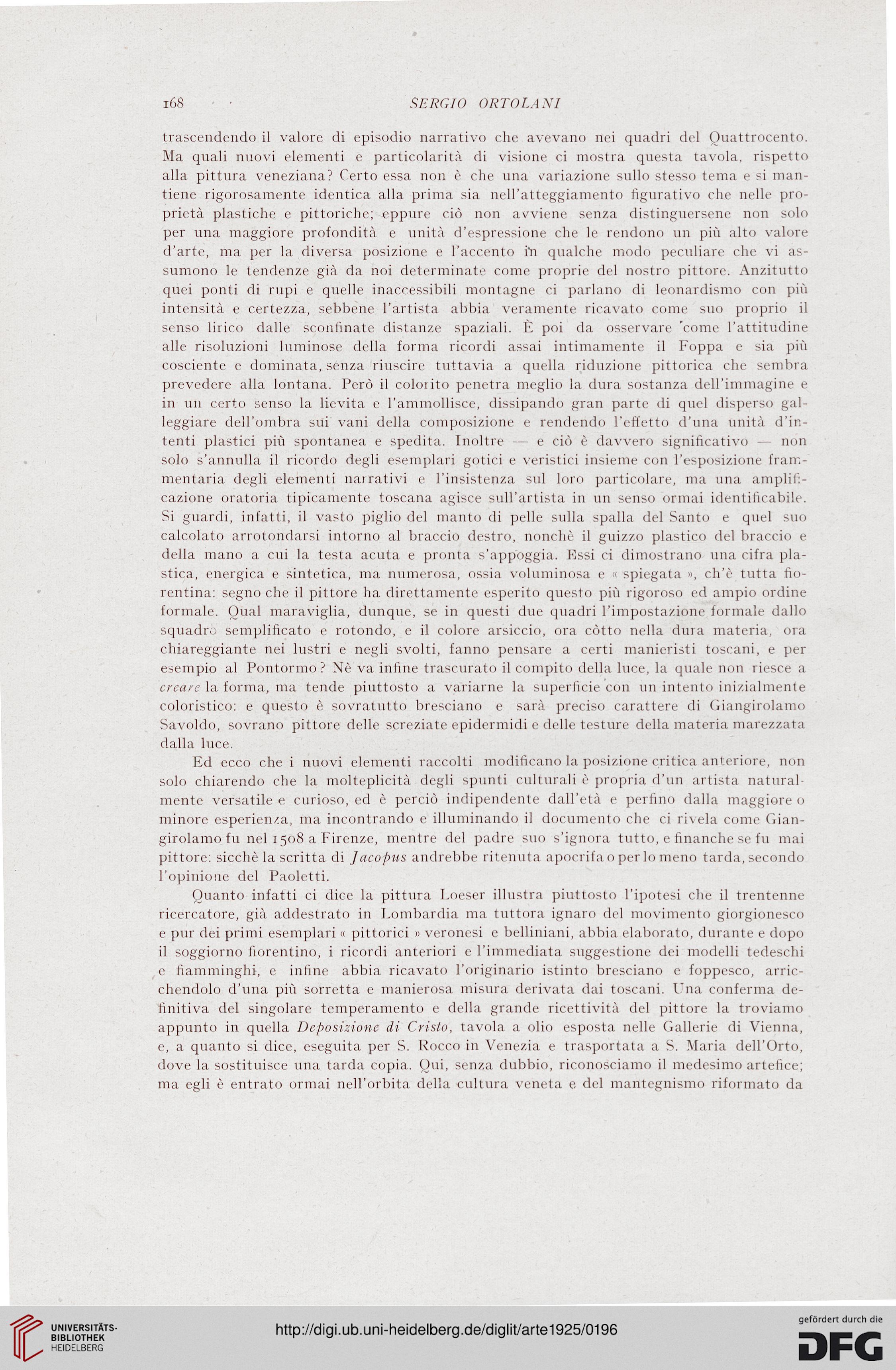i68
SERGIO ORTOLANI
trascendendo il valore di episodio narrativo che avevano nei quadri del Quattrocento.
Ma quali nuovi elementi e particolarità di visione ci mostra questa tavola, rispetto
alla pittura veneziana? Certo essa non è clic una variazione sullo stesso tema e si man-
tiene rigorosamente identica alla prima sia nell'atteggiamento figurativo che nelle pro-
prietà plastiche e pittoriche; eppure ciò non avviene senza distinguersene non solo
per una maggiore profondità e unità d'espressione che le rendono un più alto valore
d'arte, ma per la diversa posizione e l'accento i'n qualche modo peculiare che vi as-
sumono le tendenze già da noi determinate come proprie del nostro pittore. Anzitutto
quei ponti di rupi e quelle inaccessibili montagne ci parlano di leonardismo con più
intensità e certezza, sebbene l'artista abbia veramente ricavato come suo proprio il
senso lirico dalle sconfinate distanze spaziali. È poi da osservare 'come l'attitudine
alle risoluzioni luminose della forma ricordi assai intimamente il Foppa e sia più
cosciente e dominata, senza riuscire tuttavia a quella riduzione pittorica che sembra
prevedere alla lontana. Però il colorito penetra meglio la dura sostanza dell'immagine e
in un certo senso la lievita e l'ammollisce, dissipando gran parte di quel disperso gal-
leggiare dell'ombra sui vani della composizione e rendendo l'effetto d'una unità d'in-
tenti plastici più spontanea e spedita. Inoltre — e ciò è davvero significativo — non
solo s'annulla il ricordo degli esemplari gotici e veristici insieme con l'esposizione fram-
mentaria degli elementi narrativi e l'insistenza sul loro particolare, ma una amplifi-
cazione oratoria tipicamente toscana agisce sull'artista in un senso ormai identificabile.
Si guardi, infatti, il vasto piglio del manto di pelle sulla spalla del Santo e quel suo
calcolato arrotondarsi intorno al braccio destro, nonché il guizzo plastico del braccio e
della mano a cui la testa acuta e pronta s'appoggia. Essi ci dimostrano una cifra pla-
stica, energica e sintetica, ma numerosa, ossia voluminosa e « spiegata », eh'è tutta fio-
rentina: segno che il pittore ha direttamente esperito questo più rigoroso ed ampio ordine
formale. Oual maraviglia, dunque, se in questi due quadri l'impostazione formale dallo
squadro semplificato e rotondo, e il colore arsiccio, ora còtto nella dura materia, ora
chiareggiante nei lustri e negli svolti, fanno pensare a certi manieristi toscani, e per
esempio al Pontormo ? Nè va infine trascurato il compito della luce, la quale non riesce a
creare la forma, ma tende piuttosto a variarne la superficie con un intento inizialmente
coloristico: e questo è sovratutto bresciano e sarà preciso carattere di Giangirolamo
Savoldo, sovrano pittore delle screziate epidermidi e delle testure della materia marezzata
dalla luce.
Ed ecco che i nuovi elementi raccolti modificano la posizione critica anteriore, non
solo chiarendo che la molteplicità degli spunti culturali è propria d'un artista natural-
mente versatile e curioso, ed è perciò indipendente dall'età e perfino dalla maggiore o
minore esperienza, ma incontrando e illuminando il documento che ci rivela come Gian-
girolamo fu nel 1508 a Firenze, mentre del padre suo s'ignora tutto, e finanche se fu mai
pittore: sicché la scritta di Jacopus andrebbe ritenuta apocrifa o per lo meno tarda, secondo
l'opinione del Paoletti.
Quanto infatti ci dice la pittura Loeser illustra piuttosto l'ipotesi che il trentenne
ricercatore, già addestrato in Lombardia ma tuttora ignaro del movimento giorgionesco
e pur dei primi esemplari « pittorici » veronesi e belliniani, abbia elaborato, durante e dopo
il soggiorno fiorentino, i ricordi anteriori e l'immediata suggestione dei modelli tedeschi
e fiamminghi, e infine abbia ricavato l'originario istinto bresciano e foppesco, arric-
chendolo d'una più sorretta e manierosa misura derivata dai toscani. I na conferma de-
finitiva del singolare temperamento e della grande ricettività del pittore la troviamo
appunto in quella Deposizione di Cristo, tavola a olio esposta nelle Gallerie di Vienna,
e, a quanto si dice, eseguita per S. Rocco in Venezia e trasportata a S. Maria dell'Orto,
dove la sostituisce una tarda copia. Qui, senza dubbio, riconosciamo il medesimo artefice;
ma egli è entrato ormai nell'orbita della cultura veneta e del mantegnismo riformato da
SERGIO ORTOLANI
trascendendo il valore di episodio narrativo che avevano nei quadri del Quattrocento.
Ma quali nuovi elementi e particolarità di visione ci mostra questa tavola, rispetto
alla pittura veneziana? Certo essa non è clic una variazione sullo stesso tema e si man-
tiene rigorosamente identica alla prima sia nell'atteggiamento figurativo che nelle pro-
prietà plastiche e pittoriche; eppure ciò non avviene senza distinguersene non solo
per una maggiore profondità e unità d'espressione che le rendono un più alto valore
d'arte, ma per la diversa posizione e l'accento i'n qualche modo peculiare che vi as-
sumono le tendenze già da noi determinate come proprie del nostro pittore. Anzitutto
quei ponti di rupi e quelle inaccessibili montagne ci parlano di leonardismo con più
intensità e certezza, sebbene l'artista abbia veramente ricavato come suo proprio il
senso lirico dalle sconfinate distanze spaziali. È poi da osservare 'come l'attitudine
alle risoluzioni luminose della forma ricordi assai intimamente il Foppa e sia più
cosciente e dominata, senza riuscire tuttavia a quella riduzione pittorica che sembra
prevedere alla lontana. Però il colorito penetra meglio la dura sostanza dell'immagine e
in un certo senso la lievita e l'ammollisce, dissipando gran parte di quel disperso gal-
leggiare dell'ombra sui vani della composizione e rendendo l'effetto d'una unità d'in-
tenti plastici più spontanea e spedita. Inoltre — e ciò è davvero significativo — non
solo s'annulla il ricordo degli esemplari gotici e veristici insieme con l'esposizione fram-
mentaria degli elementi narrativi e l'insistenza sul loro particolare, ma una amplifi-
cazione oratoria tipicamente toscana agisce sull'artista in un senso ormai identificabile.
Si guardi, infatti, il vasto piglio del manto di pelle sulla spalla del Santo e quel suo
calcolato arrotondarsi intorno al braccio destro, nonché il guizzo plastico del braccio e
della mano a cui la testa acuta e pronta s'appoggia. Essi ci dimostrano una cifra pla-
stica, energica e sintetica, ma numerosa, ossia voluminosa e « spiegata », eh'è tutta fio-
rentina: segno che il pittore ha direttamente esperito questo più rigoroso ed ampio ordine
formale. Oual maraviglia, dunque, se in questi due quadri l'impostazione formale dallo
squadro semplificato e rotondo, e il colore arsiccio, ora còtto nella dura materia, ora
chiareggiante nei lustri e negli svolti, fanno pensare a certi manieristi toscani, e per
esempio al Pontormo ? Nè va infine trascurato il compito della luce, la quale non riesce a
creare la forma, ma tende piuttosto a variarne la superficie con un intento inizialmente
coloristico: e questo è sovratutto bresciano e sarà preciso carattere di Giangirolamo
Savoldo, sovrano pittore delle screziate epidermidi e delle testure della materia marezzata
dalla luce.
Ed ecco che i nuovi elementi raccolti modificano la posizione critica anteriore, non
solo chiarendo che la molteplicità degli spunti culturali è propria d'un artista natural-
mente versatile e curioso, ed è perciò indipendente dall'età e perfino dalla maggiore o
minore esperienza, ma incontrando e illuminando il documento che ci rivela come Gian-
girolamo fu nel 1508 a Firenze, mentre del padre suo s'ignora tutto, e finanche se fu mai
pittore: sicché la scritta di Jacopus andrebbe ritenuta apocrifa o per lo meno tarda, secondo
l'opinione del Paoletti.
Quanto infatti ci dice la pittura Loeser illustra piuttosto l'ipotesi che il trentenne
ricercatore, già addestrato in Lombardia ma tuttora ignaro del movimento giorgionesco
e pur dei primi esemplari « pittorici » veronesi e belliniani, abbia elaborato, durante e dopo
il soggiorno fiorentino, i ricordi anteriori e l'immediata suggestione dei modelli tedeschi
e fiamminghi, e infine abbia ricavato l'originario istinto bresciano e foppesco, arric-
chendolo d'una più sorretta e manierosa misura derivata dai toscani. I na conferma de-
finitiva del singolare temperamento e della grande ricettività del pittore la troviamo
appunto in quella Deposizione di Cristo, tavola a olio esposta nelle Gallerie di Vienna,
e, a quanto si dice, eseguita per S. Rocco in Venezia e trasportata a S. Maria dell'Orto,
dove la sostituisce una tarda copia. Qui, senza dubbio, riconosciamo il medesimo artefice;
ma egli è entrato ormai nell'orbita della cultura veneta e del mantegnismo riformato da