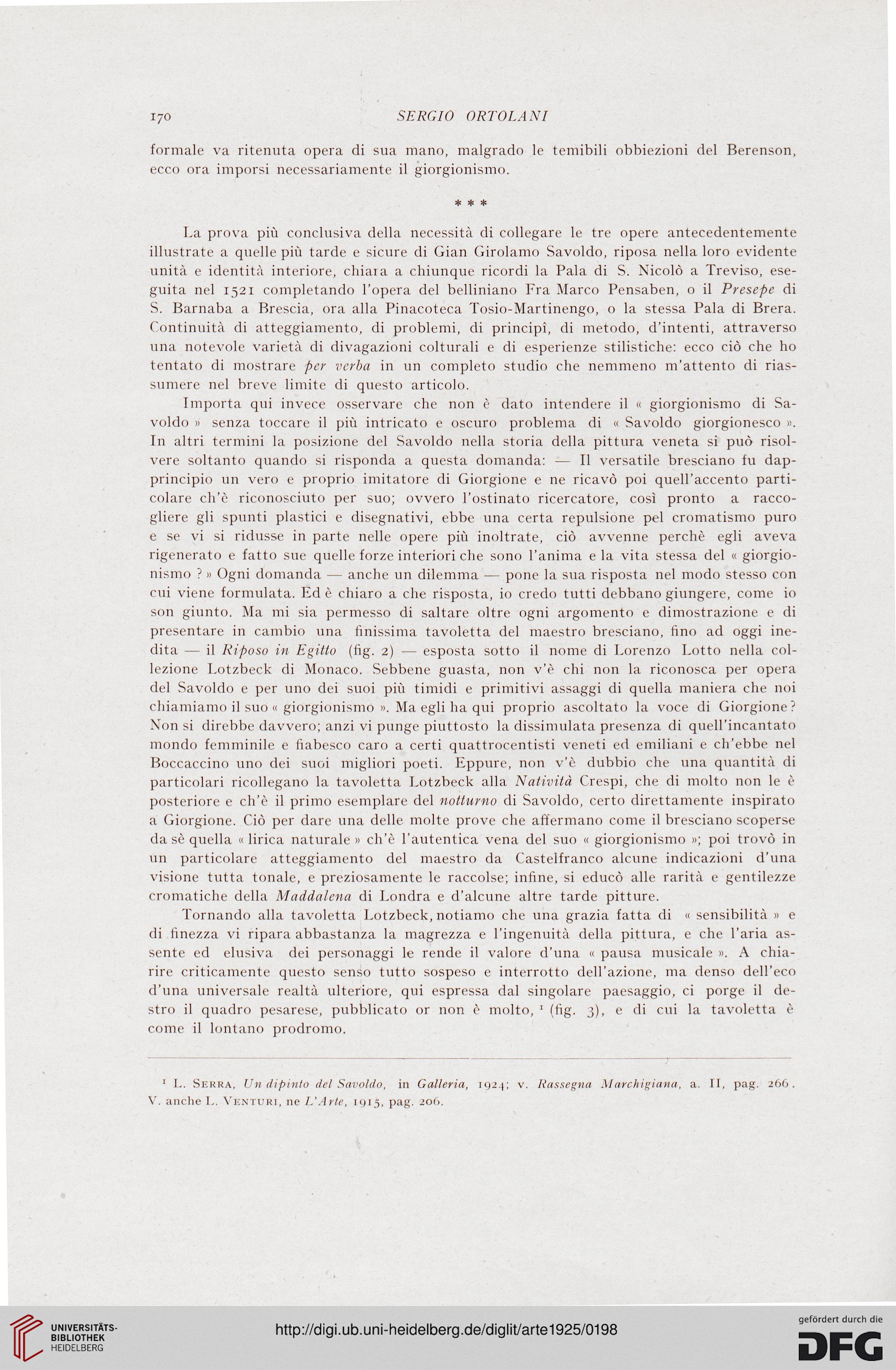I/O
SERGIO ORTOLANI
formale va ritenuta opera di sua mano, malgrado le temibili obbiezioni del Berenson,
ecco ora imporsi necessariamente il giorgionismo.
* * *
La prova più conclusiva della necessità di collegare le tre opere antecedentemente
illustrate a quelle più tarde e sicure di Gian Girolamo Savoldo, riposa nella loro evidente
unità e identità interiore, chiara a chiunque ricordi la Pala di S. Nicolò a Treviso, ese-
guita nel 1521 completando l'opera del belliniano Fra Marco Pensaben, o il Presepe di
S. Barnaba a Brescia, ora alla Pinacoteca Tosio-Martinengo, o la stessa Pala di Brera.
Continuità di atteggiamento, di problemi, di principi, di metodo, d'intenti, attraverso
una notevole Varietà di divagazioni colturali e di esperienze stilistiche: ecco ciò che ho
tentato di mostrare per vcrba in un completo studio che nemmeno m'attento di rias-
sumere nel breve limite di questo articolo.
Importa qui invece osservare che non è dato intendere il « giorgionismo di Sa-
voldo » senza toccare il più intricato e oscuro problema di « Savoldo giorgionesco ».
In altri termini la posizione del Savoldo nella storia della pittura veneta si può risol-
vere soltanto quando si risponda a questa domanda: — Il versatile bresciano fu dap-
principio un vero e proprio imitatore di Giorgione e ne ricavò poi quell'accento parti-
colare ch'è riconosciuto per suo; ovvero l'ostinato ricercatore, così pronto a racco-
gliere gli spunti plastici e disegnativi, ebbe una certa repulsione pel cromatismo puro
e se vi si ridusse in parte nelle opere più inoltrate, ciò avvenne perchè egli aveva
rigenerato e fatto sue quelle forze interiori che sono l'anima e la vita stessa del « giorgio-
nismo ? » Ogni domanda — anche un dilemma — pone la sua risposta nel modo stesso con
cui viene formulata. Ed è chiaro a che risposta, io credo tutti debbano giungere, come io
son giunto. Ma mi sia permesso di saltare oltre ogni argomento e dimostrazione e di
presentare in cambio una finissima tavoletta del maestro bresciano, fino ad oggi ine-
dita — il Riposo in Egitto (fig. 2) — esposta sotto il nome di Lorenzo Lotto nella col-
lezione Lotzbeck di Monaco. Sebbene guasta, non v'è chi non la riconosca per opera
del Savoldo e per uno dei suoi più timidi e primitivi assaggi di quella maniera che noi
chiamiamo il suo « giorgionismo ». Ma egli ha qui proprio ascoltato la voce di Giorgione?
Non si direbbe davvero; anzi vi punge piuttosto la dissimulata presenza di quell'incantato
mondo femminile e fiabesco caro a certi quattrocentisti veneti ed emiliani e ch'ebbe nel
Boccaccino uno dei suoi migliori poeti. Eppure, non v'è dubbio che una quantità di
particolari ricollegano la tavoletta Lotzbeck alla Natività Crespi, che di molto non le è
posteriore e ch'è il primo esemplare del notturno di Savoldo, certo direttamente inspirato
a Giorgione. Ciò per dare una delle molte prove che affermano come il bresciano scoperse
da sè quella « lirica naturale » ch'è l'autentica vena del suo « giorgionismo »; poi trovò in
un particolare atteggiamento del maestro da Castelfranco alcune indicazioni d'una
visione tutta tonale, e preziosamente le raccolse; infine, si educò alle rarità e gentilezze
cromatiche della Maddalena di Londra e d'alcune altre tarde pitture.
Tornando alla tavoletta Lotzbeck, notiamo che una grazia fatta di « sensibilità » e
di finezza vi ripara abbastanza la magrezza e l'ingenuità della pittura, e che l'aria as-
sente ed elusiva dei personaggi le rende il valore d'una « pausa musicale ». A chia-
rire criticamente questo senso tutto sospeso e interrotto dell'azione, ma denso dell'eco
d'una universale realtà ulteriore, qui espressa dal singolare paesaggio, ci porge il de-
stro il quadro pesarese, pubblicato or non è molto, 1 (fig. 3), e di cui la tavoletta è
come il lontano prodromo.
1 I.. Serra, Un dipinto del Savoldo, in Galleria, 1924; v. Rassegna Marchigiana, a. II, pag. 266.
V. anche L, Venturi, ne L'Arte, 1915, pag. 206.
SERGIO ORTOLANI
formale va ritenuta opera di sua mano, malgrado le temibili obbiezioni del Berenson,
ecco ora imporsi necessariamente il giorgionismo.
* * *
La prova più conclusiva della necessità di collegare le tre opere antecedentemente
illustrate a quelle più tarde e sicure di Gian Girolamo Savoldo, riposa nella loro evidente
unità e identità interiore, chiara a chiunque ricordi la Pala di S. Nicolò a Treviso, ese-
guita nel 1521 completando l'opera del belliniano Fra Marco Pensaben, o il Presepe di
S. Barnaba a Brescia, ora alla Pinacoteca Tosio-Martinengo, o la stessa Pala di Brera.
Continuità di atteggiamento, di problemi, di principi, di metodo, d'intenti, attraverso
una notevole Varietà di divagazioni colturali e di esperienze stilistiche: ecco ciò che ho
tentato di mostrare per vcrba in un completo studio che nemmeno m'attento di rias-
sumere nel breve limite di questo articolo.
Importa qui invece osservare che non è dato intendere il « giorgionismo di Sa-
voldo » senza toccare il più intricato e oscuro problema di « Savoldo giorgionesco ».
In altri termini la posizione del Savoldo nella storia della pittura veneta si può risol-
vere soltanto quando si risponda a questa domanda: — Il versatile bresciano fu dap-
principio un vero e proprio imitatore di Giorgione e ne ricavò poi quell'accento parti-
colare ch'è riconosciuto per suo; ovvero l'ostinato ricercatore, così pronto a racco-
gliere gli spunti plastici e disegnativi, ebbe una certa repulsione pel cromatismo puro
e se vi si ridusse in parte nelle opere più inoltrate, ciò avvenne perchè egli aveva
rigenerato e fatto sue quelle forze interiori che sono l'anima e la vita stessa del « giorgio-
nismo ? » Ogni domanda — anche un dilemma — pone la sua risposta nel modo stesso con
cui viene formulata. Ed è chiaro a che risposta, io credo tutti debbano giungere, come io
son giunto. Ma mi sia permesso di saltare oltre ogni argomento e dimostrazione e di
presentare in cambio una finissima tavoletta del maestro bresciano, fino ad oggi ine-
dita — il Riposo in Egitto (fig. 2) — esposta sotto il nome di Lorenzo Lotto nella col-
lezione Lotzbeck di Monaco. Sebbene guasta, non v'è chi non la riconosca per opera
del Savoldo e per uno dei suoi più timidi e primitivi assaggi di quella maniera che noi
chiamiamo il suo « giorgionismo ». Ma egli ha qui proprio ascoltato la voce di Giorgione?
Non si direbbe davvero; anzi vi punge piuttosto la dissimulata presenza di quell'incantato
mondo femminile e fiabesco caro a certi quattrocentisti veneti ed emiliani e ch'ebbe nel
Boccaccino uno dei suoi migliori poeti. Eppure, non v'è dubbio che una quantità di
particolari ricollegano la tavoletta Lotzbeck alla Natività Crespi, che di molto non le è
posteriore e ch'è il primo esemplare del notturno di Savoldo, certo direttamente inspirato
a Giorgione. Ciò per dare una delle molte prove che affermano come il bresciano scoperse
da sè quella « lirica naturale » ch'è l'autentica vena del suo « giorgionismo »; poi trovò in
un particolare atteggiamento del maestro da Castelfranco alcune indicazioni d'una
visione tutta tonale, e preziosamente le raccolse; infine, si educò alle rarità e gentilezze
cromatiche della Maddalena di Londra e d'alcune altre tarde pitture.
Tornando alla tavoletta Lotzbeck, notiamo che una grazia fatta di « sensibilità » e
di finezza vi ripara abbastanza la magrezza e l'ingenuità della pittura, e che l'aria as-
sente ed elusiva dei personaggi le rende il valore d'una « pausa musicale ». A chia-
rire criticamente questo senso tutto sospeso e interrotto dell'azione, ma denso dell'eco
d'una universale realtà ulteriore, qui espressa dal singolare paesaggio, ci porge il de-
stro il quadro pesarese, pubblicato or non è molto, 1 (fig. 3), e di cui la tavoletta è
come il lontano prodromo.
1 I.. Serra, Un dipinto del Savoldo, in Galleria, 1924; v. Rassegna Marchigiana, a. II, pag. 266.
V. anche L, Venturi, ne L'Arte, 1915, pag. 206.