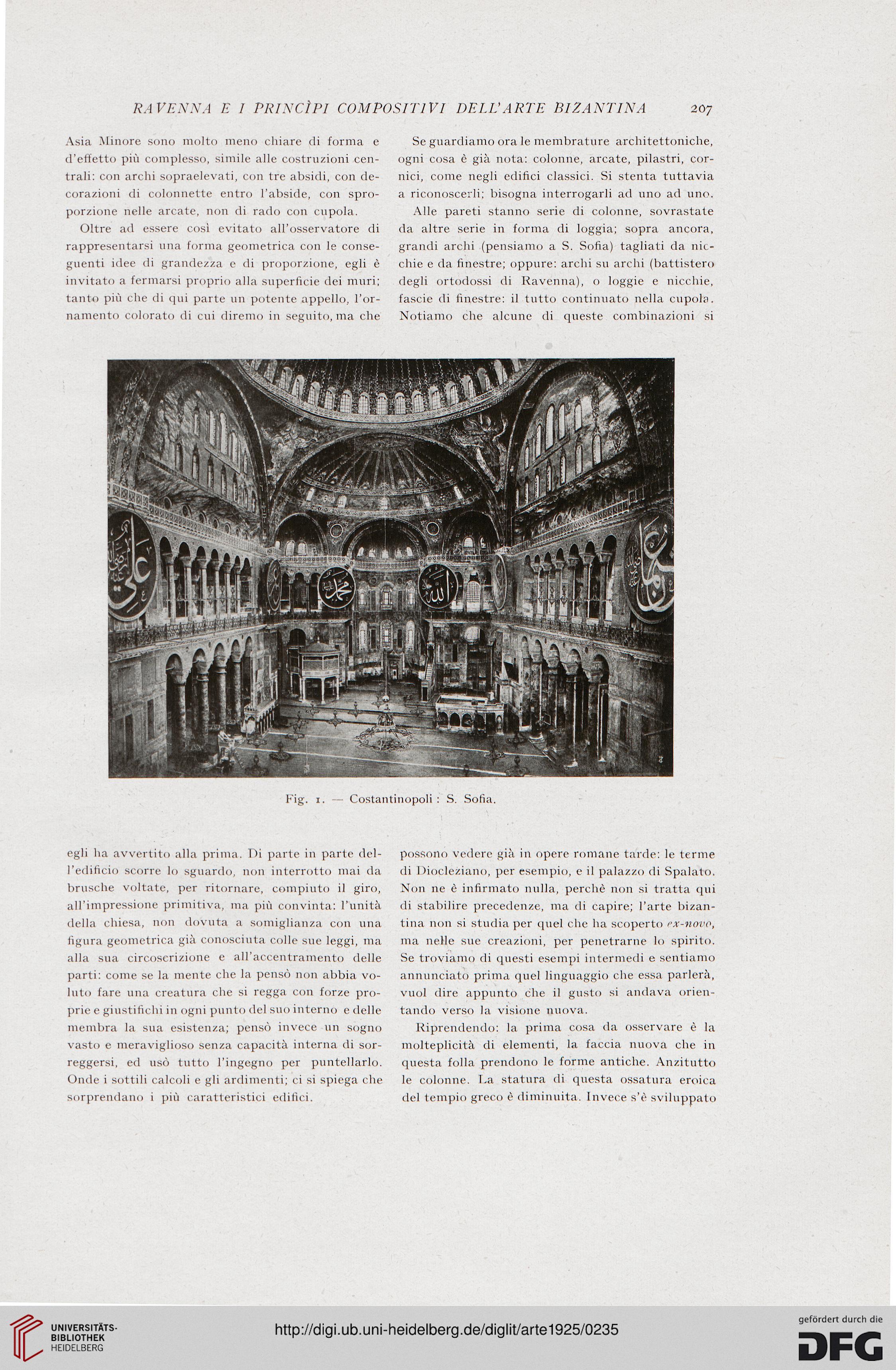RAVENNA E I PRINCÌPI COMPOSITIVI DELL'ARTE BIZANTINA 207
Asia Minore sono molto meno chiare di forma e
d'effetto più complesso, simile alle costruzioni cen-
trali: con archi sopraelevati, con tre absidi, con de-
corazioni di colonnette entro l'abside, con spro-
porzione nelle arcate, non di rado con cupola.
Oltre ad essere così evitato all'osservatore di
rappresentarsi una forma geometrica con le conse-
guenti idee di grandezza e di proporzione, egli è
invitato a fermarsi proprio alla superficie dei muri;
tanto più che di qui parte un potente appello, l'or-
namento colorato di cui diremo in seguito, ma che
Se guardiamo ora le membrature architettoniche,
ogni cosa è già nota: colonne, arcate, pilastri, cor-
nici, come negli edifici classici. Si stenta tuttavia
a riconoscerli: bisogna interrogarli ad uno ad uno.
Alle pareti stanno serie di colonne, sovrastate
da altre serie in forma di loggia; sopra ancora,
grandi archi (pensiamo a S. Sofia) tagliati da nic-
chie e da finestre; oppure: archi su archi (battistero
degli ortodossi di Ravenna), o loggie e nicchie,
fascie di finestre: il tutto continuato nella cupola.
Notiamo che alcune di queste combinazioni si
Fig. 1. — Costantinopoli : S. Sofia.
egli ha avvertito alla prima. Di parte in parte del-
l'edificio scorre lo sguardo, non interrotto mai da
brusche voltate, per ritornare, compiuto il giro,
all'impressione primitiva, ma più convinta: l'unità
della chiesa, non dovuta a somiglianza con una
figura geometrica già conosciuta colle sue leggi, ma
alla sua circoscrizione e all'accentramento delle
parti: come se la mente che la pensò non abbia vo-
luto fare una creatura che si regga con forze pro-
prie e giustifichi in ogni punto del suo interno e delle
membra la sua esistenza; pensò invece un sógno
vasto e meraviglioso senza capacità interna di sor-
reggersi, ed usò tutto l'ingegno per puntellarlo.
Onde i sottili calcoli e gli ardimenti; ci si spiega che
sorprendano i più caratteristici edifici.
possono vedere già in opere romane tarde: le terme
di Diocleziano, per esempio, e il palazzo di Spalato.
Non ne è infirmato nulla, perchè non si tratta qui
di stabilire precedenze, ma di capire; l'arte bizan-
tina non si studia per quel che ha scoperto rx-novo,
ma nelle sue creazioni, per penetrarne lo spirito.
Se troviamo di questi esempi intermedi e sentiamo
annunciato prima quel linguaggio che essa parlerà,
vuol dire appunto che il gusto si andava orien-
tando verso la visione nuova.
Riprendendo: la prima cosa da osservare è la
molteplicità di elementi, la faccia nuova che in
questa folla prendono le forme antiche. Anzitutto
le colonne. La statura di questa ossatura eroica
del tempio greco è diminuita. Invece s'è sviluppato
Asia Minore sono molto meno chiare di forma e
d'effetto più complesso, simile alle costruzioni cen-
trali: con archi sopraelevati, con tre absidi, con de-
corazioni di colonnette entro l'abside, con spro-
porzione nelle arcate, non di rado con cupola.
Oltre ad essere così evitato all'osservatore di
rappresentarsi una forma geometrica con le conse-
guenti idee di grandezza e di proporzione, egli è
invitato a fermarsi proprio alla superficie dei muri;
tanto più che di qui parte un potente appello, l'or-
namento colorato di cui diremo in seguito, ma che
Se guardiamo ora le membrature architettoniche,
ogni cosa è già nota: colonne, arcate, pilastri, cor-
nici, come negli edifici classici. Si stenta tuttavia
a riconoscerli: bisogna interrogarli ad uno ad uno.
Alle pareti stanno serie di colonne, sovrastate
da altre serie in forma di loggia; sopra ancora,
grandi archi (pensiamo a S. Sofia) tagliati da nic-
chie e da finestre; oppure: archi su archi (battistero
degli ortodossi di Ravenna), o loggie e nicchie,
fascie di finestre: il tutto continuato nella cupola.
Notiamo che alcune di queste combinazioni si
Fig. 1. — Costantinopoli : S. Sofia.
egli ha avvertito alla prima. Di parte in parte del-
l'edificio scorre lo sguardo, non interrotto mai da
brusche voltate, per ritornare, compiuto il giro,
all'impressione primitiva, ma più convinta: l'unità
della chiesa, non dovuta a somiglianza con una
figura geometrica già conosciuta colle sue leggi, ma
alla sua circoscrizione e all'accentramento delle
parti: come se la mente che la pensò non abbia vo-
luto fare una creatura che si regga con forze pro-
prie e giustifichi in ogni punto del suo interno e delle
membra la sua esistenza; pensò invece un sógno
vasto e meraviglioso senza capacità interna di sor-
reggersi, ed usò tutto l'ingegno per puntellarlo.
Onde i sottili calcoli e gli ardimenti; ci si spiega che
sorprendano i più caratteristici edifici.
possono vedere già in opere romane tarde: le terme
di Diocleziano, per esempio, e il palazzo di Spalato.
Non ne è infirmato nulla, perchè non si tratta qui
di stabilire precedenze, ma di capire; l'arte bizan-
tina non si studia per quel che ha scoperto rx-novo,
ma nelle sue creazioni, per penetrarne lo spirito.
Se troviamo di questi esempi intermedi e sentiamo
annunciato prima quel linguaggio che essa parlerà,
vuol dire appunto che il gusto si andava orien-
tando verso la visione nuova.
Riprendendo: la prima cosa da osservare è la
molteplicità di elementi, la faccia nuova che in
questa folla prendono le forme antiche. Anzitutto
le colonne. La statura di questa ossatura eroica
del tempio greco è diminuita. Invece s'è sviluppato