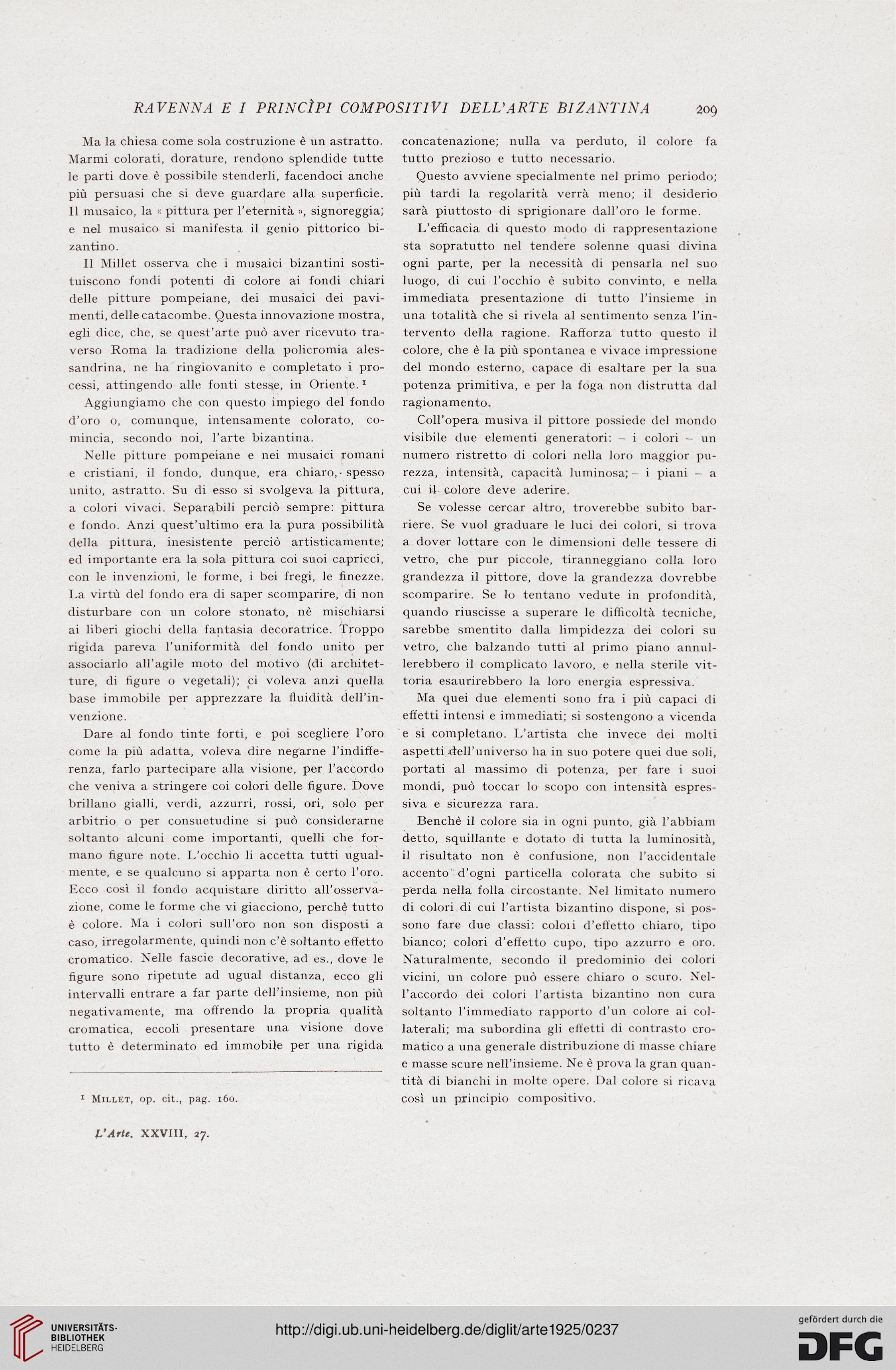RAVENNA E I PRINCÌPI COMPOSITIVI DELL'ARTE BIZANTINA 2og
Ma la chiesa come sola costruzione è un astratto.
Marmi colorati, dorature, rendono splendide tutte
le parti dove è possibile stenderli, facendoci anche
più persuasi che si deve guardare alla superficie.
Il musaico, la « pittura per l'eternità », signoreggia;
e nel musaico si manifesta il genio pittorico bi-
zantino.
Il Millet osserva che i musaici bizantini sosti-
tuiscono fondi potenti di colore ai fondi chiari
delle pitture pompeiane, dei musaici dei pavi-
menti, delle catacombe. Questa innovazione mostra,
egli dice, che, se quest'arte può aver ricevuto tra-
verso Roma la tradizione della policromia ales-
sandrina, ne ha ringiovanito e completato i pro-
cessi, attingendo alle fonti stesse, in Oriente.1
Aggiungiamo che con questo impiego del fondo
d'oro o, comunque, intensamente colorato, co-
mincia, secondo noi, l'arte bizantina.
Nelle pitture pompeiane e nei musaici romani
e cristiani, il fondo, dunque, era chiaro, spesso
unito, astratto. Su di esso si svolgeva la pittura,
a colori vivaci. Separabili perciò sempre: pittura
e fondo. Anzi quest'ultimo era la pura possibilità
della pittura, inesistente perciò artisticamente;
ed importante era la sola pittura coi suoi capricci,
con le invenzioni, le forme, i bei fregi, le finezze.
La virtù del fondo era di saper scomparire, di non
disturbare con un colore stonato, nè mischiarsi
ai liberi giochi della fantasia decoratrice. Troppo
rigida pareva l'uniformità del fondo unito per
associarlo all'agile moto del motivo (di architet-
ture, di figure o vegetali); ci voleva anzi quella
base immobile per apprezzare la fluidità dell'in-
venzione.
Dare al fondo tinte forti, e poi scegliere l'oro
come la più adatta, voleva dire negarne l'indiffe-
renza, farlo partecipare alla visione, per l'accordo
che veniva a stringere coi colori delle figure. Dove
brillano gialli, verdi, azzurri, rossi, ori, solo per
arbitrio o per consuetudine si può considerarne
soltanto alcuni come importanti, quelli che for-
mano figure note. L'occhio li accetta tutti ugual-
mente, e se qualcuno si apparta non è certo l'oro.
Ecco così il fondo acquistare diritto all'osserva-
zione, come le forme che vi giacciono, perchè tutto
è colore. Ma i colori sull'oro non son disposti a
caso, irregolarmente, quindi non c'è soltanto effetto
cromatico. Nelle fascie decorative, ad es., dove le
figure sono ripetute ad ugual distanza, ecco gli
intervalli entrare a far parte dell'insieme, non più
negativamente, ma offrendo la propria qualità
cromatica, eccoli presentare una visione dove
tutto è determinato ed immobile per una rigida
1 Millet, op. cit., pag. 160.
concatenazione; nulla va perduto, il colore fa
tutto prezioso e tutto necessario.
Questo avviene specialmente nel primo periodo;
più tardi la regolarità verrà meno; il desiderio
sarà piuttosto di sprigionare dall'oro le forme.
L'efficacia di questo modo di rappresentazione
sta sopratutto nel tendere solenne quasi divina
ogni parte, per la necessità di pensarla nel suo
luogo, di cui l'occhio è subito convinto, e nella
immediata presentazione di tutto l'insieme in
una totalità che si rivela al sentimento senza l'in-
tervento della ragione. Rafforza tutto questo il
colore, che è la più spontanea e vivace impressione
del mondo esterno, capace di esaltare per la sua
potenza primitiva, e per la foga non distrutta dal
ragionamento.
Coll'opera musiva il pittore possiede del mondo
visibile due elementi generatori: - i colori - un
numero ristretto di colori nella loro maggior pu-
rezza, intensità, capacità luminosa; - i piani - a
cui il colore deve aderire.
Se volesse cercar altro, troverebbe subito bar-
riere. Se vuol graduare le luci dei colori, si trova
a dover lottare con le dimensioni delle tessere di
vetro, che pur piccole, tiranneggiano colla loro
grandezza il pittore, dove la grandezza dovrebbe
scomparire. Se lo tentano vedute in profondità,
quando riuscisse a superare le difficoltà tecniche,
sarebbe smentito dalla limpidezza dei colori su
vetro, che balzando tutti al primo piano annul-
lerebbero il complicato lavoro, e nella sterile vit-
toria esaurirebbero la loro energia espressiva.
Ma quei due elementi sono fra i più capaci di
effetti intensi e immediati; si sostengono a vicenda
e si completano. L'artista che invece dei molti
aspetti dell'universo ha in suo potere quei due soli,
portati al massimo di potenza, per fare i suoi
mondi, può toccar lo scopo con intensità espres-
siva e sicurezza rara.
Benché il colore sia in ogni punto, già l'abbiam
detto, squillante e dotato di tutta la luminosità,
il risultato non è confusione, non l'accidentale
accento d'ogni particella colorata che subito si
perda nella folla circostante. Nel limitato numero
di colori di cui l'artista bizantino dispone, si pos-
sono fare due classi: coloii d'effetto chiaro, tipo
bianco; colori d'effetto cupo, tipo azzurro e oro.
Naturalmente, secondo il predominio dei colori
vicini, un colore può essere chiaro o scuro. Nel-
l'accordo dei colori l'artista bizantino non cura
soltanto l'immediato rapporto d'un colore ai col-
laterali; ma subordina gli effetti di contrasto cro-
matico a una generale distribuzione di masse chiare
e masse scure nell'insieme. Ne è prova la gran quan-
tità di bianchi in molte opere. Dal colore si ricava
così un principio compositivo.
l'Arte. XXVIII, 27.
Ma la chiesa come sola costruzione è un astratto.
Marmi colorati, dorature, rendono splendide tutte
le parti dove è possibile stenderli, facendoci anche
più persuasi che si deve guardare alla superficie.
Il musaico, la « pittura per l'eternità », signoreggia;
e nel musaico si manifesta il genio pittorico bi-
zantino.
Il Millet osserva che i musaici bizantini sosti-
tuiscono fondi potenti di colore ai fondi chiari
delle pitture pompeiane, dei musaici dei pavi-
menti, delle catacombe. Questa innovazione mostra,
egli dice, che, se quest'arte può aver ricevuto tra-
verso Roma la tradizione della policromia ales-
sandrina, ne ha ringiovanito e completato i pro-
cessi, attingendo alle fonti stesse, in Oriente.1
Aggiungiamo che con questo impiego del fondo
d'oro o, comunque, intensamente colorato, co-
mincia, secondo noi, l'arte bizantina.
Nelle pitture pompeiane e nei musaici romani
e cristiani, il fondo, dunque, era chiaro, spesso
unito, astratto. Su di esso si svolgeva la pittura,
a colori vivaci. Separabili perciò sempre: pittura
e fondo. Anzi quest'ultimo era la pura possibilità
della pittura, inesistente perciò artisticamente;
ed importante era la sola pittura coi suoi capricci,
con le invenzioni, le forme, i bei fregi, le finezze.
La virtù del fondo era di saper scomparire, di non
disturbare con un colore stonato, nè mischiarsi
ai liberi giochi della fantasia decoratrice. Troppo
rigida pareva l'uniformità del fondo unito per
associarlo all'agile moto del motivo (di architet-
ture, di figure o vegetali); ci voleva anzi quella
base immobile per apprezzare la fluidità dell'in-
venzione.
Dare al fondo tinte forti, e poi scegliere l'oro
come la più adatta, voleva dire negarne l'indiffe-
renza, farlo partecipare alla visione, per l'accordo
che veniva a stringere coi colori delle figure. Dove
brillano gialli, verdi, azzurri, rossi, ori, solo per
arbitrio o per consuetudine si può considerarne
soltanto alcuni come importanti, quelli che for-
mano figure note. L'occhio li accetta tutti ugual-
mente, e se qualcuno si apparta non è certo l'oro.
Ecco così il fondo acquistare diritto all'osserva-
zione, come le forme che vi giacciono, perchè tutto
è colore. Ma i colori sull'oro non son disposti a
caso, irregolarmente, quindi non c'è soltanto effetto
cromatico. Nelle fascie decorative, ad es., dove le
figure sono ripetute ad ugual distanza, ecco gli
intervalli entrare a far parte dell'insieme, non più
negativamente, ma offrendo la propria qualità
cromatica, eccoli presentare una visione dove
tutto è determinato ed immobile per una rigida
1 Millet, op. cit., pag. 160.
concatenazione; nulla va perduto, il colore fa
tutto prezioso e tutto necessario.
Questo avviene specialmente nel primo periodo;
più tardi la regolarità verrà meno; il desiderio
sarà piuttosto di sprigionare dall'oro le forme.
L'efficacia di questo modo di rappresentazione
sta sopratutto nel tendere solenne quasi divina
ogni parte, per la necessità di pensarla nel suo
luogo, di cui l'occhio è subito convinto, e nella
immediata presentazione di tutto l'insieme in
una totalità che si rivela al sentimento senza l'in-
tervento della ragione. Rafforza tutto questo il
colore, che è la più spontanea e vivace impressione
del mondo esterno, capace di esaltare per la sua
potenza primitiva, e per la foga non distrutta dal
ragionamento.
Coll'opera musiva il pittore possiede del mondo
visibile due elementi generatori: - i colori - un
numero ristretto di colori nella loro maggior pu-
rezza, intensità, capacità luminosa; - i piani - a
cui il colore deve aderire.
Se volesse cercar altro, troverebbe subito bar-
riere. Se vuol graduare le luci dei colori, si trova
a dover lottare con le dimensioni delle tessere di
vetro, che pur piccole, tiranneggiano colla loro
grandezza il pittore, dove la grandezza dovrebbe
scomparire. Se lo tentano vedute in profondità,
quando riuscisse a superare le difficoltà tecniche,
sarebbe smentito dalla limpidezza dei colori su
vetro, che balzando tutti al primo piano annul-
lerebbero il complicato lavoro, e nella sterile vit-
toria esaurirebbero la loro energia espressiva.
Ma quei due elementi sono fra i più capaci di
effetti intensi e immediati; si sostengono a vicenda
e si completano. L'artista che invece dei molti
aspetti dell'universo ha in suo potere quei due soli,
portati al massimo di potenza, per fare i suoi
mondi, può toccar lo scopo con intensità espres-
siva e sicurezza rara.
Benché il colore sia in ogni punto, già l'abbiam
detto, squillante e dotato di tutta la luminosità,
il risultato non è confusione, non l'accidentale
accento d'ogni particella colorata che subito si
perda nella folla circostante. Nel limitato numero
di colori di cui l'artista bizantino dispone, si pos-
sono fare due classi: coloii d'effetto chiaro, tipo
bianco; colori d'effetto cupo, tipo azzurro e oro.
Naturalmente, secondo il predominio dei colori
vicini, un colore può essere chiaro o scuro. Nel-
l'accordo dei colori l'artista bizantino non cura
soltanto l'immediato rapporto d'un colore ai col-
laterali; ma subordina gli effetti di contrasto cro-
matico a una generale distribuzione di masse chiare
e masse scure nell'insieme. Ne è prova la gran quan-
tità di bianchi in molte opere. Dal colore si ricava
così un principio compositivo.
l'Arte. XXVIII, 27.