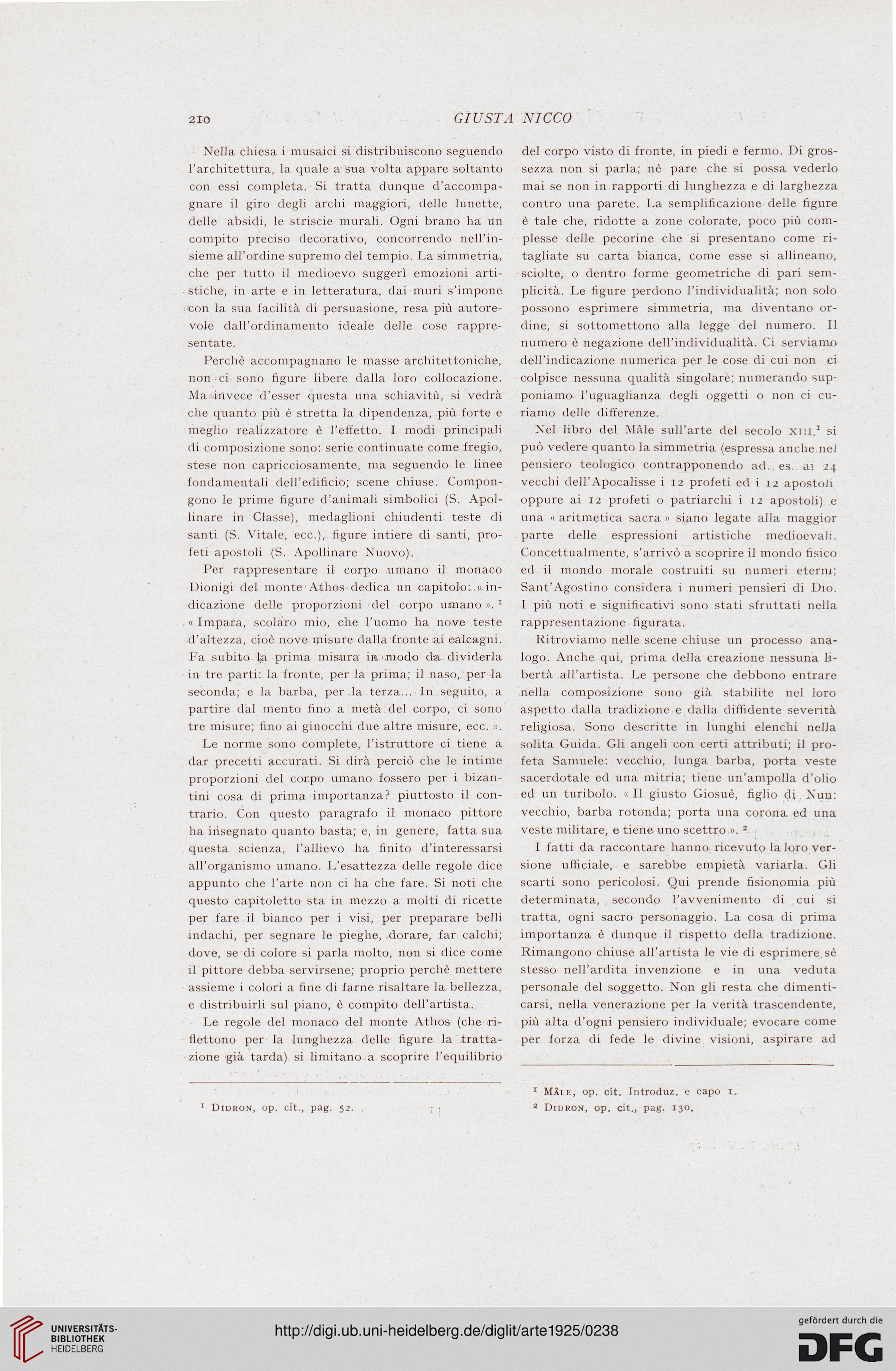210
GIUSTA NICCO
Nella chiesa i musaici si distribuiscono seguendo
l'architettura, la quale a sua volta appare soltanto
con essi completa. Si tratta dunque d'accompa-
gnare il giro degli archi maggiori, delle lunette,
delle absidi, le striscie murali. Ogni brano ha un
compito preciso decorativo, concorrendo nell'in-
sieme all'ordine supremo del tempio. La simmetria,
che per tutto il medioevo suggerì emozioni arti-
stiche, in arte e in letteratura, dai muri s'impone
con la sua facilità di persuasione, resa più autore-
vole dall'ordinamento ideale delle cose rappre-
sentate.
Perchè accompagnano le masse architettoniche,
non ci sono ligure libere dalla loro collocazione.
Ma invece d'esser questa una schiavitù, si vedrà
che quanto più è stretta la dipendenza, più forte e
meglio realizzatore è l'effetto. 1 modi principali
di composizione sono: serie continuate come fregio,
stese non capricciosamente, ma seguendo le linee
fondamentali dell'edificio; scene chiuse. Compon-
gono le prime figure d'animali simbolici (S. Apol-
linare in Classe), medaglioni chiudenti teste di
santi (S. Vitale, ecc.), figure intiere di santi, pro-
feti apostoli (S. Apollinare Nuovo).
Per rappresentare il corpo umano il monaco
Dionigi del monte Athos dedica un capitolo: n, in-
dicazione delle proporzioni del corpo umano ». 1
« Impara, scolaro mio, che l'uomo ha nove teste
d'altezza, cioè nove misure dalla fronte ai calcagni.
Fa subito la prima misura in. modo da dividerla
in tre parti: la fronte, per la prima; il naso, per la
seconda; e la barba, per la terza... In seguito, a
partire dal mento lino a metà del corpo, ci sono
tre misure; fino ai ginocchi due altre misure, ecc. ».
Le norme sono complete, l'istruttore ci tiene a
dar precetti accurati. Si dirà perciò che le intime
proporzioni del corpo umano fossero per i bizan-
tini cosa di prima importanza? piuttosto il con-
trario. Con questo paragrafo il monaco pittore
lia insegnato quanto basta; e, in genere, fatta sua
questa scienza, l'allievo ha finito d'interessarsi
all'organismo umano. L'esattezza delle regole dice
appunto che l'arte non ci ha che fare. Si noti che
questo capitoletto sta in mezzo a molti di ricette
per fare il bianco per i visi, per preparare belli
indachi, per segnare le pieghe, dorare, far: calchi;
dove, se di colore si parla molto, non si dice come
il pittore debba servirsene; proprio perchè mettere
assieme i colori a fine di farne risaltare la bellezza,
e distribuirli sul piano, è compito dell'artista.
Le regole del monaco del monte Athos (che ri-
flettono per la lunghezza delle figure la tratta-
zione già tarda) si limitano a scoprire l'equilibrio
1 Didron, op. cit., pag. 52.
del corpo visto di fronte, in piedi e fermo. Di gros-
sezza non si parla; nè pare che si possa vederlo
mai se non in rapporti di lunghezza e di larghezza
contro una parete. La semplificazione delle figure
è tale che, ridotte a zone colorate, poco più com-
plesse delle pecorine che si presentano come ri-
tagliate su carta bianca, come esse si allineano,
sciolte, o dentro forme geometriche di pari sem-
plicità. Le figure perdono l'individualità; non solo
possono esprimere simmetria, ma diventano or-
dine, si sottomettono alla legge del numero. Il
numero è negazione dell'individualità. Ci serviamo
dell'indicazione numerica per le cose di cui non ci
colpisce nessuna qualità singolare; numerando sup-
poniamo l'uguaglianza degli oggetti o non ci cu-
riamo delle differenze.
Nel libro del Male sull'arte del secolo xm,1 si
può vedere quanto la simmetria (espressa anche nel
pensiero teologico contrapponendo ad. es. ai 24
vecchi dell'Apocalisse i 12 profeti ed i 12 apostoli
oppure ai 12 profeti o patriarchi i 12 apostoli) e
una « aritmetica sacra » siano legate alla maggior
parte delle espressioni artistiche medioevah.
Concettualmente, s'arrivò a scoprire il mondo fisico
ed il mondo morale costruiti su numeri eterni;
Sant'Agostino considera i numeri pensieri di Dio.
I più noti e significativi sono stati sfruttati nella
rappresentazione figurata.
Ritroviamo nelle scene chiuse un processo ana-
logo. Anche qui, prima della creazione nessuna li-
bertà all'artista. Le persone che debbono entrare
nella composizione sono già stabilite nel loro
aspetto dalla tradizione e dalla diffidente severità
religiosa. Sono descritte in lunghi elenchi nella
solita Guida. Gli angeli con certi attributi; il pro-
feta Samuele: vecchio, lunga barba, porta veste
sai erdotale ed una mitria; tiene un'ampolla d'olio
ed un turibolo. « Il giusto Giosuè, figlio di Nun:
vecchio, barba rotonda; porta una corona ed una
veste militare, e tiene uno scettro ». 2
I fatti da raccontare hanno ricevuto la loro ver-
sione ufficiale, e sarebbe empietà variarla. Gli
scarti sono pericolosi. Qui prende fisionomia più
determinata, secondo l'avvenimento di cui si
tratta, ogni sacro personaggio. La cosa di prima
importanza è dunque il rispetto della tradizione.
Rimangono chiuse all'artista le vie di esprimere sè
stesso nell'ardita invenzione e in una veduta
personale del soggetto. Non gli resta che dimenti-
carsi, nella venerazione per la verità trascendente,
più alta d'ogni pensiero individuale; evocare come
per forza di fede le divine visioni, aspirare ad
1 Mài k, op. cit. Introduz. e capo 1.
2 Didron, op. cit., pag. 130.
GIUSTA NICCO
Nella chiesa i musaici si distribuiscono seguendo
l'architettura, la quale a sua volta appare soltanto
con essi completa. Si tratta dunque d'accompa-
gnare il giro degli archi maggiori, delle lunette,
delle absidi, le striscie murali. Ogni brano ha un
compito preciso decorativo, concorrendo nell'in-
sieme all'ordine supremo del tempio. La simmetria,
che per tutto il medioevo suggerì emozioni arti-
stiche, in arte e in letteratura, dai muri s'impone
con la sua facilità di persuasione, resa più autore-
vole dall'ordinamento ideale delle cose rappre-
sentate.
Perchè accompagnano le masse architettoniche,
non ci sono ligure libere dalla loro collocazione.
Ma invece d'esser questa una schiavitù, si vedrà
che quanto più è stretta la dipendenza, più forte e
meglio realizzatore è l'effetto. 1 modi principali
di composizione sono: serie continuate come fregio,
stese non capricciosamente, ma seguendo le linee
fondamentali dell'edificio; scene chiuse. Compon-
gono le prime figure d'animali simbolici (S. Apol-
linare in Classe), medaglioni chiudenti teste di
santi (S. Vitale, ecc.), figure intiere di santi, pro-
feti apostoli (S. Apollinare Nuovo).
Per rappresentare il corpo umano il monaco
Dionigi del monte Athos dedica un capitolo: n, in-
dicazione delle proporzioni del corpo umano ». 1
« Impara, scolaro mio, che l'uomo ha nove teste
d'altezza, cioè nove misure dalla fronte ai calcagni.
Fa subito la prima misura in. modo da dividerla
in tre parti: la fronte, per la prima; il naso, per la
seconda; e la barba, per la terza... In seguito, a
partire dal mento lino a metà del corpo, ci sono
tre misure; fino ai ginocchi due altre misure, ecc. ».
Le norme sono complete, l'istruttore ci tiene a
dar precetti accurati. Si dirà perciò che le intime
proporzioni del corpo umano fossero per i bizan-
tini cosa di prima importanza? piuttosto il con-
trario. Con questo paragrafo il monaco pittore
lia insegnato quanto basta; e, in genere, fatta sua
questa scienza, l'allievo ha finito d'interessarsi
all'organismo umano. L'esattezza delle regole dice
appunto che l'arte non ci ha che fare. Si noti che
questo capitoletto sta in mezzo a molti di ricette
per fare il bianco per i visi, per preparare belli
indachi, per segnare le pieghe, dorare, far: calchi;
dove, se di colore si parla molto, non si dice come
il pittore debba servirsene; proprio perchè mettere
assieme i colori a fine di farne risaltare la bellezza,
e distribuirli sul piano, è compito dell'artista.
Le regole del monaco del monte Athos (che ri-
flettono per la lunghezza delle figure la tratta-
zione già tarda) si limitano a scoprire l'equilibrio
1 Didron, op. cit., pag. 52.
del corpo visto di fronte, in piedi e fermo. Di gros-
sezza non si parla; nè pare che si possa vederlo
mai se non in rapporti di lunghezza e di larghezza
contro una parete. La semplificazione delle figure
è tale che, ridotte a zone colorate, poco più com-
plesse delle pecorine che si presentano come ri-
tagliate su carta bianca, come esse si allineano,
sciolte, o dentro forme geometriche di pari sem-
plicità. Le figure perdono l'individualità; non solo
possono esprimere simmetria, ma diventano or-
dine, si sottomettono alla legge del numero. Il
numero è negazione dell'individualità. Ci serviamo
dell'indicazione numerica per le cose di cui non ci
colpisce nessuna qualità singolare; numerando sup-
poniamo l'uguaglianza degli oggetti o non ci cu-
riamo delle differenze.
Nel libro del Male sull'arte del secolo xm,1 si
può vedere quanto la simmetria (espressa anche nel
pensiero teologico contrapponendo ad. es. ai 24
vecchi dell'Apocalisse i 12 profeti ed i 12 apostoli
oppure ai 12 profeti o patriarchi i 12 apostoli) e
una « aritmetica sacra » siano legate alla maggior
parte delle espressioni artistiche medioevah.
Concettualmente, s'arrivò a scoprire il mondo fisico
ed il mondo morale costruiti su numeri eterni;
Sant'Agostino considera i numeri pensieri di Dio.
I più noti e significativi sono stati sfruttati nella
rappresentazione figurata.
Ritroviamo nelle scene chiuse un processo ana-
logo. Anche qui, prima della creazione nessuna li-
bertà all'artista. Le persone che debbono entrare
nella composizione sono già stabilite nel loro
aspetto dalla tradizione e dalla diffidente severità
religiosa. Sono descritte in lunghi elenchi nella
solita Guida. Gli angeli con certi attributi; il pro-
feta Samuele: vecchio, lunga barba, porta veste
sai erdotale ed una mitria; tiene un'ampolla d'olio
ed un turibolo. « Il giusto Giosuè, figlio di Nun:
vecchio, barba rotonda; porta una corona ed una
veste militare, e tiene uno scettro ». 2
I fatti da raccontare hanno ricevuto la loro ver-
sione ufficiale, e sarebbe empietà variarla. Gli
scarti sono pericolosi. Qui prende fisionomia più
determinata, secondo l'avvenimento di cui si
tratta, ogni sacro personaggio. La cosa di prima
importanza è dunque il rispetto della tradizione.
Rimangono chiuse all'artista le vie di esprimere sè
stesso nell'ardita invenzione e in una veduta
personale del soggetto. Non gli resta che dimenti-
carsi, nella venerazione per la verità trascendente,
più alta d'ogni pensiero individuale; evocare come
per forza di fede le divine visioni, aspirare ad
1 Mài k, op. cit. Introduz. e capo 1.
2 Didron, op. cit., pag. 130.