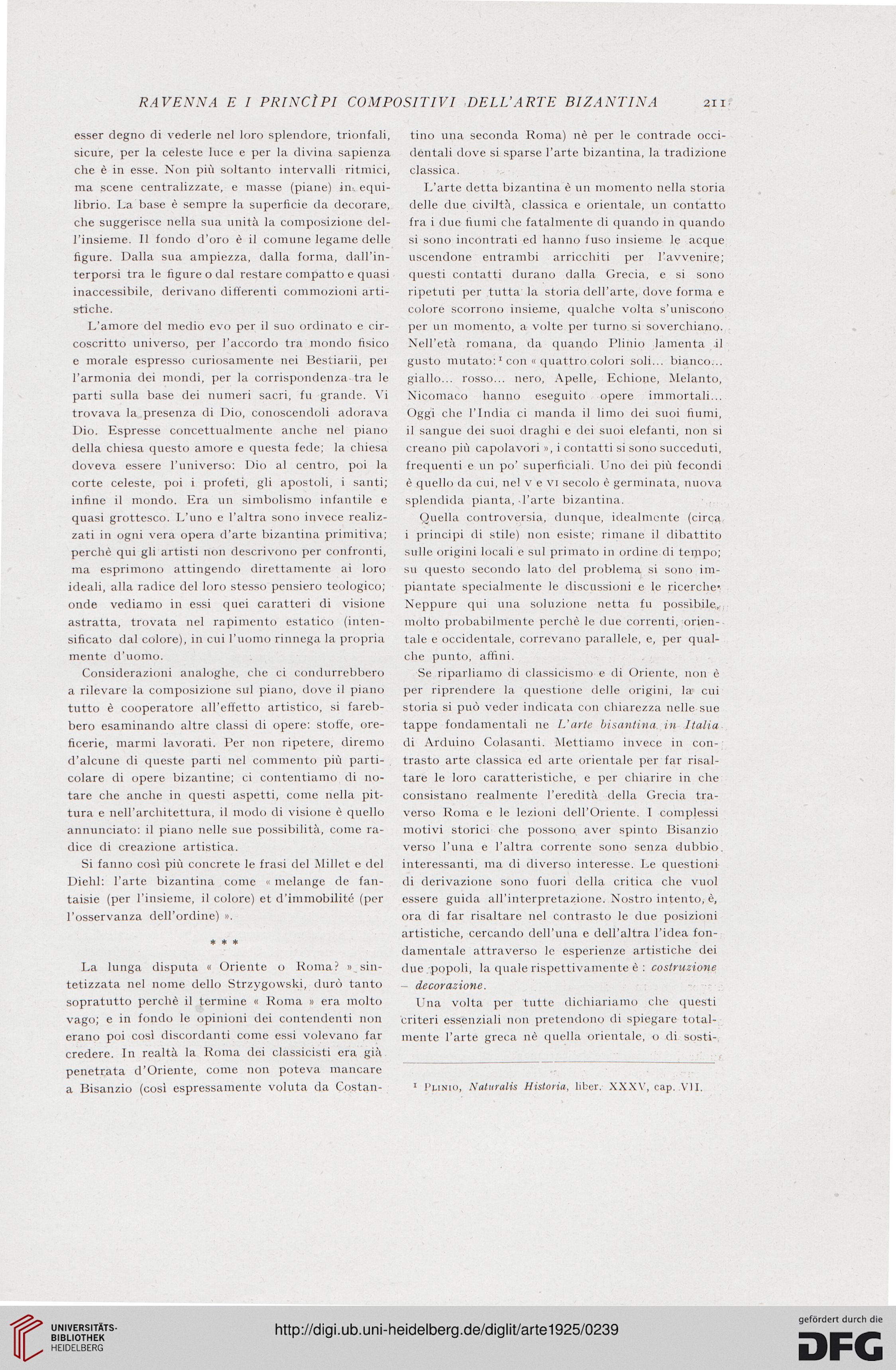RAVENNA E I PRINCÌPI COMPOSITIVI DELL'ARTE BIZANTINA
21 I
esser degno di vederle nel loro splendore, trionfali,
sicure, per la celeste luce e per la divina sapienza
che è in esse. Non più soltanto intervalli ritmici,
ma scene centralizzate, e masse (piane) im equi-
librio. La base è sempre la superficie da decorare,
che suggerisce nella sua unità la composizione del-
l'insieme. Il fondo d'oro è il comune legame delle
figure. Dalla sua ampiezza, dalla forma, dall'in-
terporsi tra le figure o dal restare compatto e quasi
inaccessibile, derivano differenti commozioni arti-
stiche.
L'amore del medio evo per il suo ordinato e cir-
coscritto universo, per l'accordo tra mondo tìsico
e morale espresso curiosamente nei Bestiarii, pei
l'armonia dei mondi, per la corrispondenza tra le
parti sulla base dei numeri sacri, fu grandi'. Vi
trovava la presenza di Dio, conoscendoli adorava
Uio. Espresse concettualmente anche nel piano
della chiesa questo amore e questa fede; la chiesa
doveva essere l'universo: Dio al centro, poi la
corte celeste, poi i profeti, gli apostoli, i santi;
infine il mondo. Era un simbolismo infantile e
quasi grottesco. L'uno e l'altra sono invece realiz-
zati in ogni vera opera d'arte bizantina primitiva;
perchè qui gli artisti non descrivono per confronti,
ma esprìmono attingendo direttamente ai loro
ideali, alla radice del loro stesso pensiero teologico;
onde vediamo in essi quei caratteri di visione
astratta, trovata nel rapimento estatico (inten-
sificato dal colore), in cui l'uomo rinnega la propria
mente d'uomo.
Considerazioni analoghe, che ci condurrebbero
a rilevare la composizione sul piano, dove il piano
tutto è cooperatore all'effetto artistico, si fareb-
bero esaminando altre classi di opere: stoffe, ore-
ficerie, marmi lavorati. Per non ripetere, diremo
d'alcune di queste parti nel commento più parti-
colare di opere bizantine; ci contentiamo di no-
tare che anche in questi aspetti, come nella pit-
tura e nell'architettura, il modo di visione è quello
annunciato: il piano nelle sue possibilità, come ra-
dice di creazione artistica.
Si fanno cosi più concrete le frasi del Millet e del
Diehl: l'arte bizantina come « melange de fan-
taisie (per l'insieme, il colore) et d'immobilité (per
l'osservanza dell'ordine) ».
* * *
La lunga disputa « Oriente o Roma? » sin-
tetizzata nel nome dello Strzygowski, durò tanto
sopratutto perchè il termine « Roma » era molto
vago; e in fondo le opinioni dei contendenti non
erano poi cosi discordanti come essi volevano far
credere. In realtà la Roma dei classicisti era gii)
penetrata d'Oriente, come non poteva mancare
a Bisanzio (cosi espressamente voluta da Costan-
tino una seconda Roma) nè per le contrade occi-
dentali dove si sparse l'arte bizantina, la tradizione
classica.
L'arte detta bizantina è un momento nella storia
delle due civiltà, classica e orientale, un contatto
fra i due fiumi che fatalmente di quando in quando
si sono incontrati ed hanno fuso insieme le acque
uscendone entrambi arriccili ti per l'avvenire;
questi contatti durano dalla Grecia, e si sono
ripetuti per tutta la storia dell'arte, dove forma e
colore scorrono insieme, qualche volta s'uniscono
per un momento, a volte per turno si soverchiano.
Nell'età romana, da (piando Plinio lamenta il
gusto mutato:1 con « quattro colori soli... bianco...
giallo... rosso... nero, Apelle, Echione, Melanto,
Nicomaco hanno eseguito opere immortali...
Oggi che l'India ci manda il limo dei suoi fiumi,
il sangue dei suoi draghi e dei suoi elefanti, non si
creano più capolavori », i contatti si sono succeduti,
frequenti e un po' superficiali. Uno dei più fecondi
è quello da cui, nel v e vi secolo è germinata, nuova
splendida pianta, l'arte bizantina.
Quella controversia, dunque, idealmente (circa
i principi di stile) non esiste; rimane il dibattito
sulle origini locali e sul primato in ordine di tempo;
su questo secondo lato del problema si sono im-
piantate specialmente le discussioni e le ricerche"
Neppure qui una soluzione netta fu possibile,
molto probabilmente perchè le due correnti, orien-
tale e occidentale, correvano parallele, e, per qual-
che punto, all'ini.
Se riparliamo di classicismo e di Oriente, non è
per riprendere la questione delle origini, la cui
storia si può veder indicata con chiarezza nelle sue
tappe fondamentali ne L'arte bisantina. in Italia
di Arduino Colasanti. Mettiamo invece in con-
trasto arte classica ed arte orientale per far risal-
tare le loro caratteristiche, e per chiarire in che
consistano realmente l'eredità della Grecia tra-
verso Roma e le lezioni dell'Oriente. I complessi
motivi storici che possono aver spinto Bisanzio
verso l'una e l'altra corrente sono senza dubbio,
interessanti, ma di diverso interesse. Le questioni
di derivazione sono fuori della critica che vuol
essere guida all'interpretazione. Nostro intento, è,
ora di far risaltare nel contrasto le due posizioni
artistiche, cercando dell'una e dell'altra l'idea fon-
damentale attraverso le esperienze artistiche dei
due .popoli, la (piale rispettivamente è : costruzione
- decorazione.
Una volta per tutte dichiariamo che questi
criteri essenziali non pretendono di spiegare total-
mente l'arte greca nè quella orientale, o di sosti-
1 I'mnio, Naturali* Historia, liber. XXXV, cap. .VII,
21 I
esser degno di vederle nel loro splendore, trionfali,
sicure, per la celeste luce e per la divina sapienza
che è in esse. Non più soltanto intervalli ritmici,
ma scene centralizzate, e masse (piane) im equi-
librio. La base è sempre la superficie da decorare,
che suggerisce nella sua unità la composizione del-
l'insieme. Il fondo d'oro è il comune legame delle
figure. Dalla sua ampiezza, dalla forma, dall'in-
terporsi tra le figure o dal restare compatto e quasi
inaccessibile, derivano differenti commozioni arti-
stiche.
L'amore del medio evo per il suo ordinato e cir-
coscritto universo, per l'accordo tra mondo tìsico
e morale espresso curiosamente nei Bestiarii, pei
l'armonia dei mondi, per la corrispondenza tra le
parti sulla base dei numeri sacri, fu grandi'. Vi
trovava la presenza di Dio, conoscendoli adorava
Uio. Espresse concettualmente anche nel piano
della chiesa questo amore e questa fede; la chiesa
doveva essere l'universo: Dio al centro, poi la
corte celeste, poi i profeti, gli apostoli, i santi;
infine il mondo. Era un simbolismo infantile e
quasi grottesco. L'uno e l'altra sono invece realiz-
zati in ogni vera opera d'arte bizantina primitiva;
perchè qui gli artisti non descrivono per confronti,
ma esprìmono attingendo direttamente ai loro
ideali, alla radice del loro stesso pensiero teologico;
onde vediamo in essi quei caratteri di visione
astratta, trovata nel rapimento estatico (inten-
sificato dal colore), in cui l'uomo rinnega la propria
mente d'uomo.
Considerazioni analoghe, che ci condurrebbero
a rilevare la composizione sul piano, dove il piano
tutto è cooperatore all'effetto artistico, si fareb-
bero esaminando altre classi di opere: stoffe, ore-
ficerie, marmi lavorati. Per non ripetere, diremo
d'alcune di queste parti nel commento più parti-
colare di opere bizantine; ci contentiamo di no-
tare che anche in questi aspetti, come nella pit-
tura e nell'architettura, il modo di visione è quello
annunciato: il piano nelle sue possibilità, come ra-
dice di creazione artistica.
Si fanno cosi più concrete le frasi del Millet e del
Diehl: l'arte bizantina come « melange de fan-
taisie (per l'insieme, il colore) et d'immobilité (per
l'osservanza dell'ordine) ».
* * *
La lunga disputa « Oriente o Roma? » sin-
tetizzata nel nome dello Strzygowski, durò tanto
sopratutto perchè il termine « Roma » era molto
vago; e in fondo le opinioni dei contendenti non
erano poi cosi discordanti come essi volevano far
credere. In realtà la Roma dei classicisti era gii)
penetrata d'Oriente, come non poteva mancare
a Bisanzio (cosi espressamente voluta da Costan-
tino una seconda Roma) nè per le contrade occi-
dentali dove si sparse l'arte bizantina, la tradizione
classica.
L'arte detta bizantina è un momento nella storia
delle due civiltà, classica e orientale, un contatto
fra i due fiumi che fatalmente di quando in quando
si sono incontrati ed hanno fuso insieme le acque
uscendone entrambi arriccili ti per l'avvenire;
questi contatti durano dalla Grecia, e si sono
ripetuti per tutta la storia dell'arte, dove forma e
colore scorrono insieme, qualche volta s'uniscono
per un momento, a volte per turno si soverchiano.
Nell'età romana, da (piando Plinio lamenta il
gusto mutato:1 con « quattro colori soli... bianco...
giallo... rosso... nero, Apelle, Echione, Melanto,
Nicomaco hanno eseguito opere immortali...
Oggi che l'India ci manda il limo dei suoi fiumi,
il sangue dei suoi draghi e dei suoi elefanti, non si
creano più capolavori », i contatti si sono succeduti,
frequenti e un po' superficiali. Uno dei più fecondi
è quello da cui, nel v e vi secolo è germinata, nuova
splendida pianta, l'arte bizantina.
Quella controversia, dunque, idealmente (circa
i principi di stile) non esiste; rimane il dibattito
sulle origini locali e sul primato in ordine di tempo;
su questo secondo lato del problema si sono im-
piantate specialmente le discussioni e le ricerche"
Neppure qui una soluzione netta fu possibile,
molto probabilmente perchè le due correnti, orien-
tale e occidentale, correvano parallele, e, per qual-
che punto, all'ini.
Se riparliamo di classicismo e di Oriente, non è
per riprendere la questione delle origini, la cui
storia si può veder indicata con chiarezza nelle sue
tappe fondamentali ne L'arte bisantina. in Italia
di Arduino Colasanti. Mettiamo invece in con-
trasto arte classica ed arte orientale per far risal-
tare le loro caratteristiche, e per chiarire in che
consistano realmente l'eredità della Grecia tra-
verso Roma e le lezioni dell'Oriente. I complessi
motivi storici che possono aver spinto Bisanzio
verso l'una e l'altra corrente sono senza dubbio,
interessanti, ma di diverso interesse. Le questioni
di derivazione sono fuori della critica che vuol
essere guida all'interpretazione. Nostro intento, è,
ora di far risaltare nel contrasto le due posizioni
artistiche, cercando dell'una e dell'altra l'idea fon-
damentale attraverso le esperienze artistiche dei
due .popoli, la (piale rispettivamente è : costruzione
- decorazione.
Una volta per tutte dichiariamo che questi
criteri essenziali non pretendono di spiegare total-
mente l'arte greca nè quella orientale, o di sosti-
1 I'mnio, Naturali* Historia, liber. XXXV, cap. .VII,