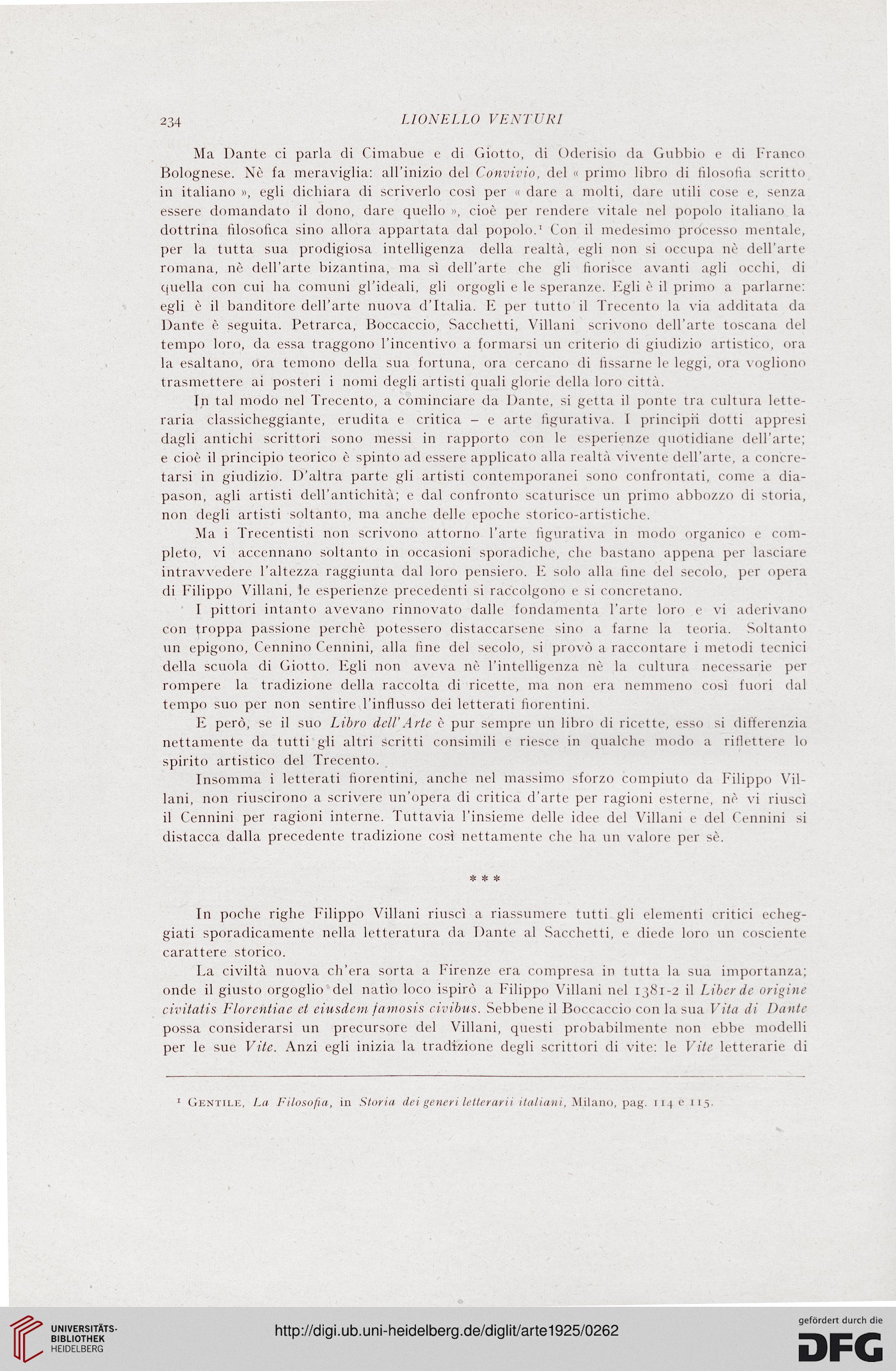234
LIONELLO VENTURI
Ma Dante ci parla di Cimabue e di (dotto, di Oderisio da Gubbio e di Franco
Bolognese. Nò fa meraviglia: all'inizio del Convivio, del « primo libro di filosofia scritto
in italiano », egli dichiara di scriverlo così per « dare a molti, dare utili cose e, senza
essere domandato il dono, dare quello », cioè per rendere vitale nel popolo italiano la
dottrina filosofica sino allora appartata dal popolo.' Con il medesimo processo mentale,
per la tutta sua prodigiosa intelligenza della realtà, egli non si occupa nò dell'arte
romana, nè dell'arte bizantina, ma sì dell'arte che gli fiorisce avanti agli occhi, di
ciucila con cui ha comuni gl'ideali, gli orgogli e le speranze. Egli è il primo a parlarne:
egli è il banditore dell'arte nuova d'Italia. E per tutto il Trecento la via additata da
Dante è seguita. Petrarca, Boccaccio, Sacchetti, Villani scrivono dell'arte toscana del
tempo loro, da essa traggono l'incentivo a formarsi un criterio di giudizio artistico, ora
la esaltano, ora temono della sua fortuna, ora cercano di fissarne le leggi, ora vogliono
trasmettere ai posteri i nomi degli artisti quali glorie della loro città.
In tal modo nel Trecento, a cominciare da Dante, si getta il ponte tra cultura lette-
raria classicheggiante, erudita e critica - e arte figurativa. I principii dotti appresi
dagli antichi scrittori sono messi in rapporto con le esperienze quotidiane dell'arte;
e cioè il principio teorico è spinto ad essere applicato alla realtà vivente dell'arte, a (-onere-
tarsi in giudizio. D'altra parte gli artisti contemporanei sono confrontati, come a dia-
pason, agli artisti dell'antichità; e dal confronto scaturisce un primo abbozzo di storia,
non degli artisti soltanto, ma anche delle epoche storico-artistiche.
Ma i Trecentisti non scrivono attorno l'arte figurativa in modo organico e com-
pleto, vi accennano soltanto in occasioni sporadiche, che bastano appena per lasciare
intravvedere l'altezza raggiunta dal loro pensiero. K Milo alla line del secolo, per opera
di Filippo Villani, !e esperienze precedenti si raccolgono e si concretano.
I pittori intanto avevano rinnovato dalle fondamenta l'arti' loro e vi aderivano
con groppa passione perchè potessero distaccarsene sino a farne la teoria. Soltanto
un epigono, Cennino Cennini, alla fine del secolo, si provò a raccontare i metodi tecnici
della scuola di Giotto. Egli non aveva nè l'intelligenza nè la cultura necessarie per
rompere la tradizione della raccolta di ricette, ma non era nemmeno così fuori dal
tempo suo per non sentire l'influsso dei letterati fiorentini.
E però, se il suo Libro dell'Arte è pur sempre un libro di ricette, esso si differenzia
nettamente da tutti gli altri scritti consimili e riesce in qualche modo a riflettere lo
spirito artistico del Trecento.
Insomma i letterati fiorentini, anche nel massimo sforzo compiuto da Filippo Vil-
lani, non riuscirono a scrivere un'opera di critica d'arte per ragioni esterne, nè vi riuscì
il Cennini per ragioni interne. Tuttavia l'insieme delle idee del Villani e del Cennini si
distacca dalla precedente tradizione così nettamente che ha un valore per sè.
* * *
In poche righe Filippo Villani riuscì a riassumere tutti gli elementi critici echeg-
giati sporadicamente nella letteratura da Dante al Sacchetti, e diede loro un cosciente
carattere storico.
La civiltà nuova ch'era sorta a Firenze era compresa in tutta la sua importanza;
onde il giusto orgoglio del natio loco ispirò a Filippo Villani nel 1381-2 il Liba-de origine
civitatis Florcntiae et eiusdem jamosis civibus. Sebbene il Boccaccio con la sua Vita di Dante
possa considerarsi un precursore del Villani, questi probabilmente non ebbe modelli
per le sue Vite. Anzi egli inizia la tradizione degli scrittori di vite: le Vite letterarie di
1 Gentili:, La Filosofia, in Storia dei generi le Iterarli italiani, Milano, pax- 1 1 | <• 1 15.
LIONELLO VENTURI
Ma Dante ci parla di Cimabue e di (dotto, di Oderisio da Gubbio e di Franco
Bolognese. Nò fa meraviglia: all'inizio del Convivio, del « primo libro di filosofia scritto
in italiano », egli dichiara di scriverlo così per « dare a molti, dare utili cose e, senza
essere domandato il dono, dare quello », cioè per rendere vitale nel popolo italiano la
dottrina filosofica sino allora appartata dal popolo.' Con il medesimo processo mentale,
per la tutta sua prodigiosa intelligenza della realtà, egli non si occupa nò dell'arte
romana, nè dell'arte bizantina, ma sì dell'arte che gli fiorisce avanti agli occhi, di
ciucila con cui ha comuni gl'ideali, gli orgogli e le speranze. Egli è il primo a parlarne:
egli è il banditore dell'arte nuova d'Italia. E per tutto il Trecento la via additata da
Dante è seguita. Petrarca, Boccaccio, Sacchetti, Villani scrivono dell'arte toscana del
tempo loro, da essa traggono l'incentivo a formarsi un criterio di giudizio artistico, ora
la esaltano, ora temono della sua fortuna, ora cercano di fissarne le leggi, ora vogliono
trasmettere ai posteri i nomi degli artisti quali glorie della loro città.
In tal modo nel Trecento, a cominciare da Dante, si getta il ponte tra cultura lette-
raria classicheggiante, erudita e critica - e arte figurativa. I principii dotti appresi
dagli antichi scrittori sono messi in rapporto con le esperienze quotidiane dell'arte;
e cioè il principio teorico è spinto ad essere applicato alla realtà vivente dell'arte, a (-onere-
tarsi in giudizio. D'altra parte gli artisti contemporanei sono confrontati, come a dia-
pason, agli artisti dell'antichità; e dal confronto scaturisce un primo abbozzo di storia,
non degli artisti soltanto, ma anche delle epoche storico-artistiche.
Ma i Trecentisti non scrivono attorno l'arte figurativa in modo organico e com-
pleto, vi accennano soltanto in occasioni sporadiche, che bastano appena per lasciare
intravvedere l'altezza raggiunta dal loro pensiero. K Milo alla line del secolo, per opera
di Filippo Villani, !e esperienze precedenti si raccolgono e si concretano.
I pittori intanto avevano rinnovato dalle fondamenta l'arti' loro e vi aderivano
con groppa passione perchè potessero distaccarsene sino a farne la teoria. Soltanto
un epigono, Cennino Cennini, alla fine del secolo, si provò a raccontare i metodi tecnici
della scuola di Giotto. Egli non aveva nè l'intelligenza nè la cultura necessarie per
rompere la tradizione della raccolta di ricette, ma non era nemmeno così fuori dal
tempo suo per non sentire l'influsso dei letterati fiorentini.
E però, se il suo Libro dell'Arte è pur sempre un libro di ricette, esso si differenzia
nettamente da tutti gli altri scritti consimili e riesce in qualche modo a riflettere lo
spirito artistico del Trecento.
Insomma i letterati fiorentini, anche nel massimo sforzo compiuto da Filippo Vil-
lani, non riuscirono a scrivere un'opera di critica d'arte per ragioni esterne, nè vi riuscì
il Cennini per ragioni interne. Tuttavia l'insieme delle idee del Villani e del Cennini si
distacca dalla precedente tradizione così nettamente che ha un valore per sè.
* * *
In poche righe Filippo Villani riuscì a riassumere tutti gli elementi critici echeg-
giati sporadicamente nella letteratura da Dante al Sacchetti, e diede loro un cosciente
carattere storico.
La civiltà nuova ch'era sorta a Firenze era compresa in tutta la sua importanza;
onde il giusto orgoglio del natio loco ispirò a Filippo Villani nel 1381-2 il Liba-de origine
civitatis Florcntiae et eiusdem jamosis civibus. Sebbene il Boccaccio con la sua Vita di Dante
possa considerarsi un precursore del Villani, questi probabilmente non ebbe modelli
per le sue Vite. Anzi egli inizia la tradizione degli scrittori di vite: le Vite letterarie di
1 Gentili:, La Filosofia, in Storia dei generi le Iterarli italiani, Milano, pax- 1 1 | <• 1 15.