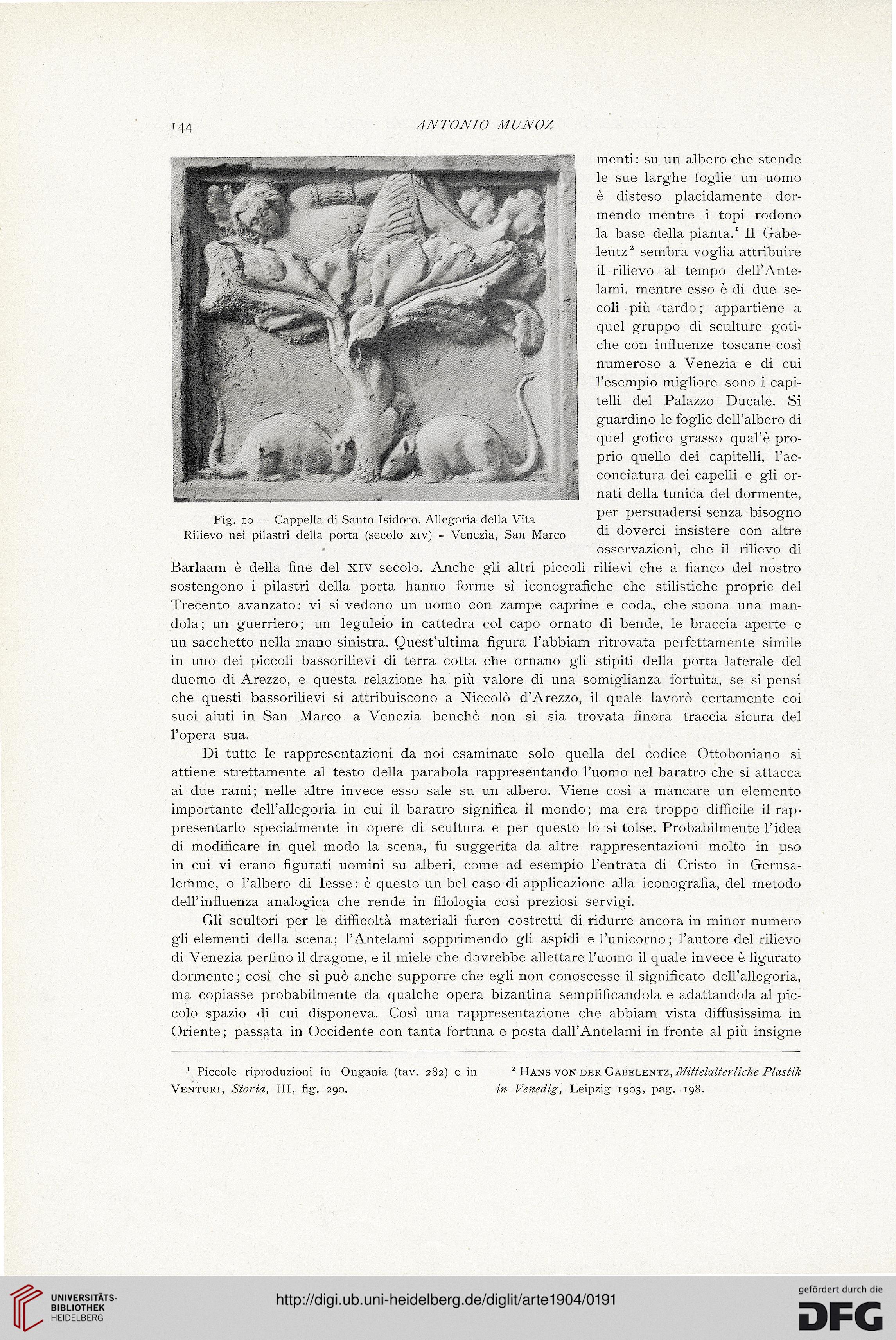44
ANTONIO MUNOZ
Fig. io — Cappella di Santo Isidoro. Allegoria della Vita
Rilievo nei pilastri della porta (secolo xiv) - Venezia, San Marco
menti: su un albero che stende
le sue larghe foglie un uomo
è disteso placidamente dor-
mendo mentre i topi rodono
la base della pianta.1 Il Gabe-
lentz2 sembra voglia attribuire
il rilievo al tempo dell’Ante-
lami, mentre esso è di due se-
coli più tardo ; appartiene a
quel gruppo di sculture goti-
che con influenze toscane così
numeroso a Venezia e di cui
l’esempio migliore sono i capi-
telli del Palazzo Ducale. Si
guardino le foglie dell’albero di
quel gotico grasso qual’è pro-
prio quello dei capitelli, l’ac-
conciatura dei capelli e gli or-
nati della tunica del dormente,
per persuadersi senza bisogno
di doverci insistere con altre
osservazioni, che il rilievo di
Barlaam è della fine del XIV secolo. Anche gli altri piccoli rilievi che a fianco del nostro
sostengono i pilastri della porta hanno forme sì iconografiche che stilistiche proprie del
Trecento avanzato: vi si vedono un uomo con zampe caprine e coda, che suona una man-
dola; un guerriero; un leguleio in cattedra col capo ornato di bende, le braccia aperte e
un sacchetto nella mano sinistra. Quest’ultima figura l’abbiam ritrovata perfettamente simile
in uno dei piccoli bassorilievi di terra cotta che ornano gli stipiti della porta laterale del
duomo di Arezzo, e questa relazione ha più valore di una somiglianza fortuita, se si pensi
che questi bassorilievi si attribuiscono a Niccolò d’Arezzo, il quale lavorò certamente coi
suoi aiuti in San Marco a Venezia benché non si sia trovata finora traccia sicura del
l’opera sua.
Di tutte le rappresentazioni da noi esaminate solo quella del codice Ottoboniano si
attiene strettamente al testo della parabola rappresentando l’uomo nel baratro che si attacca
ai due rami; nelle altre invece esso sale su un albero. Viene così a mancare un elemento
importante dell’allegoria in cui il baratro significa il mondo; ma era troppo difficile il rap-
presentarlo specialmente in opere di scultura e per questo lo si tolse. Probabilmente l’idea
di modificare in quel modo la scena, fu suggerita da altre rappresentazioni molto in uso
in cui vi erano figurati uomini su alberi, come ad esempio l’entrata di Cristo in Gerusa-
lemme, o l’albero di lesse : è questo un bel caso di applicazione alla iconografia, del metodo
dell’influenza analogica che rende in filologia così preziosi servigi.
Gli scultori per le difficoltà materiali furon costretti di ridurre ancora in minor numero
gli elementi della scena; l’Antelami sopprimendo gli aspidi e l’unicorno ; l’autore del rilievo
di Venezia perfino il dragone, e il miele che dovrebbe allettare l’uomo il quale invece è figurato
dormente ; così che si può anche supporre che egli non conoscesse il significato dell’allegoria,
ma copiasse probabilmente da qualche opera bizantina semplificandola e adattandola al pic-
colo spazio di cui disponeva. Così una rappresentazione che abbiam vista diffusissima in
Oriente ; passata in Occidente con tanta fortuna e posta dall’Antelami in fronte al più insigne
1 Piccole riproduzioni in Ongania (tav. 282) e in 2 Hans von der Ga.b'ei.wtz, Mittelalterliche Plastik
Venturi, Storia, III, fig. 290. in Venedig, Leipzig 1903, pag. 198.
ANTONIO MUNOZ
Fig. io — Cappella di Santo Isidoro. Allegoria della Vita
Rilievo nei pilastri della porta (secolo xiv) - Venezia, San Marco
menti: su un albero che stende
le sue larghe foglie un uomo
è disteso placidamente dor-
mendo mentre i topi rodono
la base della pianta.1 Il Gabe-
lentz2 sembra voglia attribuire
il rilievo al tempo dell’Ante-
lami, mentre esso è di due se-
coli più tardo ; appartiene a
quel gruppo di sculture goti-
che con influenze toscane così
numeroso a Venezia e di cui
l’esempio migliore sono i capi-
telli del Palazzo Ducale. Si
guardino le foglie dell’albero di
quel gotico grasso qual’è pro-
prio quello dei capitelli, l’ac-
conciatura dei capelli e gli or-
nati della tunica del dormente,
per persuadersi senza bisogno
di doverci insistere con altre
osservazioni, che il rilievo di
Barlaam è della fine del XIV secolo. Anche gli altri piccoli rilievi che a fianco del nostro
sostengono i pilastri della porta hanno forme sì iconografiche che stilistiche proprie del
Trecento avanzato: vi si vedono un uomo con zampe caprine e coda, che suona una man-
dola; un guerriero; un leguleio in cattedra col capo ornato di bende, le braccia aperte e
un sacchetto nella mano sinistra. Quest’ultima figura l’abbiam ritrovata perfettamente simile
in uno dei piccoli bassorilievi di terra cotta che ornano gli stipiti della porta laterale del
duomo di Arezzo, e questa relazione ha più valore di una somiglianza fortuita, se si pensi
che questi bassorilievi si attribuiscono a Niccolò d’Arezzo, il quale lavorò certamente coi
suoi aiuti in San Marco a Venezia benché non si sia trovata finora traccia sicura del
l’opera sua.
Di tutte le rappresentazioni da noi esaminate solo quella del codice Ottoboniano si
attiene strettamente al testo della parabola rappresentando l’uomo nel baratro che si attacca
ai due rami; nelle altre invece esso sale su un albero. Viene così a mancare un elemento
importante dell’allegoria in cui il baratro significa il mondo; ma era troppo difficile il rap-
presentarlo specialmente in opere di scultura e per questo lo si tolse. Probabilmente l’idea
di modificare in quel modo la scena, fu suggerita da altre rappresentazioni molto in uso
in cui vi erano figurati uomini su alberi, come ad esempio l’entrata di Cristo in Gerusa-
lemme, o l’albero di lesse : è questo un bel caso di applicazione alla iconografia, del metodo
dell’influenza analogica che rende in filologia così preziosi servigi.
Gli scultori per le difficoltà materiali furon costretti di ridurre ancora in minor numero
gli elementi della scena; l’Antelami sopprimendo gli aspidi e l’unicorno ; l’autore del rilievo
di Venezia perfino il dragone, e il miele che dovrebbe allettare l’uomo il quale invece è figurato
dormente ; così che si può anche supporre che egli non conoscesse il significato dell’allegoria,
ma copiasse probabilmente da qualche opera bizantina semplificandola e adattandola al pic-
colo spazio di cui disponeva. Così una rappresentazione che abbiam vista diffusissima in
Oriente ; passata in Occidente con tanta fortuna e posta dall’Antelami in fronte al più insigne
1 Piccole riproduzioni in Ongania (tav. 282) e in 2 Hans von der Ga.b'ei.wtz, Mittelalterliche Plastik
Venturi, Storia, III, fig. 290. in Venedig, Leipzig 1903, pag. 198.