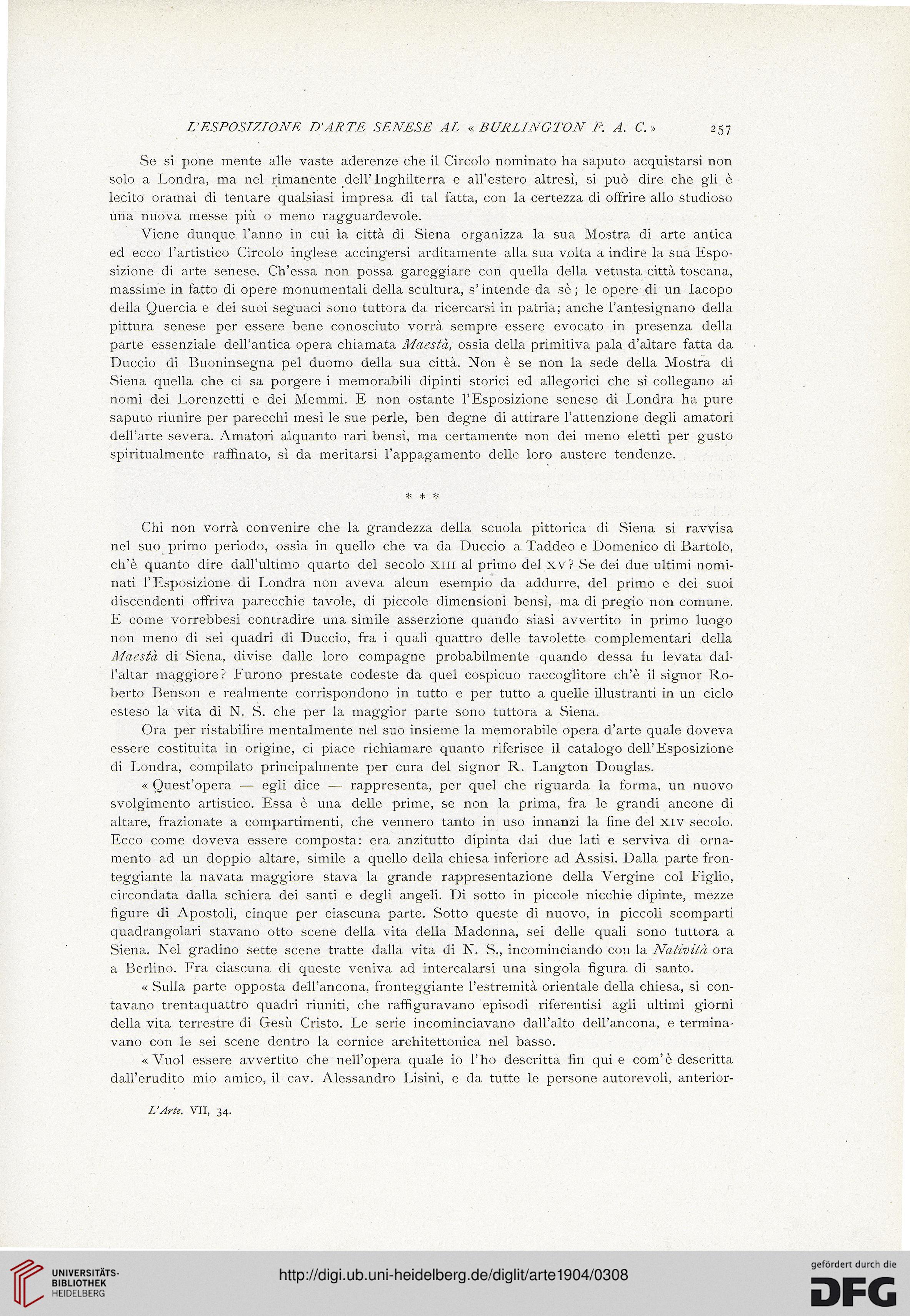L'ESPOSIZIONE D'ARTE SENESE AL « BURLINGTON P. A. C.
257
Se si pone mente alle vaste aderenze che il Circolo nominato ha saputo acquistarsi non
solo a Londra, ma nel rimanente dell’ Inghilterra e all’estero altresì, si può dire che gli è
lecito oramai di tentare qualsiasi impresa di tal fatta, con la certezza di offrire allo studioso
una nuova messe più o meno ragguardevole.
Viene dunque l’anno in cui la città di Siena organizza la sua Mostra di arte antica
ed ecco l’artistico Circolo inglese accingersi arditamente alla sua volta a indire la sua Espo-
sizione di arte senese. Ch’essa non possa gareggiare con quella della vetusta città toscana,
massime in fatto di opere monumentali della scultura, s’intende da sè ; le opere di un Iacopo
della Quercia e dei suoi seguaci sono tuttora da ricercarsi in patria; anche l’antesignano della
pittura senese per essere bene conosciuto vorrà sempre essere evocato in presenza della
parte essenziale dell’antica opera chiamata Maestà, ossia della primitiva pala d’altare fatta da
Duccio di Buoninsegna pel duomo della sua città. Non è se non la sede della Mostra di
Siena quella che ci sa porgere i memorabili dipinti storici ed allegorici che si collegano ai
nomi dei Lorenzetti e dei Memmi. E non ostante l’Esposizione senese di Londra ha pure
saputo riunire per parecchi mesi le sue perle, ben degne di attirare l’attenzione degli amatori
dell’arte severa. Amatori alquanto rari bensì, ma certamente non dei meno eletti per gusto
spiritualmente raffinato, sì da meritarsi l’appagamento delle loro austere tendenze.
* * *
Chi non vorrà convenire che la grandezza della scuola pittorica di Siena si ravvisa
nel suo primo periodo, ossia in quello che va da Duccio a Taddeo e Domenico di Bartolo,
ch’è quanto dire dall’ultimo quarto del secolo XIII al primo del XV? Se dei due ultimi nomi-
nati l’Esposizione di Londra non aveva alcun esempio da addurre, del primo e dei suoi
discendenti offriva parecchie tavole, di piccole dimensioni bensì, ma di pregio non comune.
E come vorrebbesi contradire una simile asserzione quando siasi avvertito in primo luogo
non meno di sei quadri di Duccio, fra i quali quattro delle tavolette complementari della
Maestà di Siena, divise dalle loro compagne probabilmente quando dessa fu levata dal-
l’altar maggiore? Furono prestate codeste da quel cospicuo raccoglitore ch’è il signor Ro-
berto Benson e realmente corrispondono in tutto e per tutto a quelle illustranti in un ciclo
esteso la vita di N. S. che per la maggior parte sono tuttora a Siena.
Ora per ristabilire mentalmente nel suo insieme la memorabile opera d’arte quale doveva
essere costituita in origine, ci piace richiamare quanto riferisce il catalogo dell’Esposizione
di Londra, compilato principalmente per cura del signor R. Langton Douglas.
« Quest’opera — egli dice — rappresenta, per quel che riguarda la forma, un nuovo
svolgimento artistico. Essa è una delle prime, se non la prima, fra le grandi ancone di
altare, frazionate a compartimenti, che vennero tanto in uso innanzi la fine del XIV secolo.
Ecco come doveva essere composta: era anzitutto dipinta dai due lati e serviva di orna-
mento ad un doppio altare, simile a quello della chiesa inferiore ad Assisi. Dalla parte fron-
teggiante la navata maggiore stava la grande rappresentazione della Vergine col Figlio,
circondata dalla schiera dei santi e degli angeli. Di sotto in piccole nicchie dipinte, mezze
figure di Apostoli, cinque per ciascuna parte. Sotto queste di nuovo, in piccoli scomparti
quadrangolari stavano otto scene della vita della Madonna, sei delle quali sono tuttora a
Siena. Nel gradino sette scene tratte dalla vita di N. S., incominciando con la Natività ora
a Berlino. Fra ciascuna di queste veniva ad intercalarsi una singola figura di santo.
« Sulla parte opposta dell’ancona, fronteggiante l’estremità orientale della chiesa, si con-
tavano trentaquattro quadri riuniti, che raffiguravano episodi riferentisi agli ultimi giorni
della vita terrestre di Gesù Cristo. Le serie incominciavano dall’alto dell’ancona, e termina-
vano con le sei scene dentro la cornice architettonica nel basso.
«Vuol essere avvertito che nell’opera quale io l’ho descritta fin qui e com’è descritta
dall’erudito mio amico, il cav. Alessandro Lisini, e da tutte le persone autorevoli, anterior-
L'Arte. VII, 34.
257
Se si pone mente alle vaste aderenze che il Circolo nominato ha saputo acquistarsi non
solo a Londra, ma nel rimanente dell’ Inghilterra e all’estero altresì, si può dire che gli è
lecito oramai di tentare qualsiasi impresa di tal fatta, con la certezza di offrire allo studioso
una nuova messe più o meno ragguardevole.
Viene dunque l’anno in cui la città di Siena organizza la sua Mostra di arte antica
ed ecco l’artistico Circolo inglese accingersi arditamente alla sua volta a indire la sua Espo-
sizione di arte senese. Ch’essa non possa gareggiare con quella della vetusta città toscana,
massime in fatto di opere monumentali della scultura, s’intende da sè ; le opere di un Iacopo
della Quercia e dei suoi seguaci sono tuttora da ricercarsi in patria; anche l’antesignano della
pittura senese per essere bene conosciuto vorrà sempre essere evocato in presenza della
parte essenziale dell’antica opera chiamata Maestà, ossia della primitiva pala d’altare fatta da
Duccio di Buoninsegna pel duomo della sua città. Non è se non la sede della Mostra di
Siena quella che ci sa porgere i memorabili dipinti storici ed allegorici che si collegano ai
nomi dei Lorenzetti e dei Memmi. E non ostante l’Esposizione senese di Londra ha pure
saputo riunire per parecchi mesi le sue perle, ben degne di attirare l’attenzione degli amatori
dell’arte severa. Amatori alquanto rari bensì, ma certamente non dei meno eletti per gusto
spiritualmente raffinato, sì da meritarsi l’appagamento delle loro austere tendenze.
* * *
Chi non vorrà convenire che la grandezza della scuola pittorica di Siena si ravvisa
nel suo primo periodo, ossia in quello che va da Duccio a Taddeo e Domenico di Bartolo,
ch’è quanto dire dall’ultimo quarto del secolo XIII al primo del XV? Se dei due ultimi nomi-
nati l’Esposizione di Londra non aveva alcun esempio da addurre, del primo e dei suoi
discendenti offriva parecchie tavole, di piccole dimensioni bensì, ma di pregio non comune.
E come vorrebbesi contradire una simile asserzione quando siasi avvertito in primo luogo
non meno di sei quadri di Duccio, fra i quali quattro delle tavolette complementari della
Maestà di Siena, divise dalle loro compagne probabilmente quando dessa fu levata dal-
l’altar maggiore? Furono prestate codeste da quel cospicuo raccoglitore ch’è il signor Ro-
berto Benson e realmente corrispondono in tutto e per tutto a quelle illustranti in un ciclo
esteso la vita di N. S. che per la maggior parte sono tuttora a Siena.
Ora per ristabilire mentalmente nel suo insieme la memorabile opera d’arte quale doveva
essere costituita in origine, ci piace richiamare quanto riferisce il catalogo dell’Esposizione
di Londra, compilato principalmente per cura del signor R. Langton Douglas.
« Quest’opera — egli dice — rappresenta, per quel che riguarda la forma, un nuovo
svolgimento artistico. Essa è una delle prime, se non la prima, fra le grandi ancone di
altare, frazionate a compartimenti, che vennero tanto in uso innanzi la fine del XIV secolo.
Ecco come doveva essere composta: era anzitutto dipinta dai due lati e serviva di orna-
mento ad un doppio altare, simile a quello della chiesa inferiore ad Assisi. Dalla parte fron-
teggiante la navata maggiore stava la grande rappresentazione della Vergine col Figlio,
circondata dalla schiera dei santi e degli angeli. Di sotto in piccole nicchie dipinte, mezze
figure di Apostoli, cinque per ciascuna parte. Sotto queste di nuovo, in piccoli scomparti
quadrangolari stavano otto scene della vita della Madonna, sei delle quali sono tuttora a
Siena. Nel gradino sette scene tratte dalla vita di N. S., incominciando con la Natività ora
a Berlino. Fra ciascuna di queste veniva ad intercalarsi una singola figura di santo.
« Sulla parte opposta dell’ancona, fronteggiante l’estremità orientale della chiesa, si con-
tavano trentaquattro quadri riuniti, che raffiguravano episodi riferentisi agli ultimi giorni
della vita terrestre di Gesù Cristo. Le serie incominciavano dall’alto dell’ancona, e termina-
vano con le sei scene dentro la cornice architettonica nel basso.
«Vuol essere avvertito che nell’opera quale io l’ho descritta fin qui e com’è descritta
dall’erudito mio amico, il cav. Alessandro Lisini, e da tutte le persone autorevoli, anterior-
L'Arte. VII, 34.