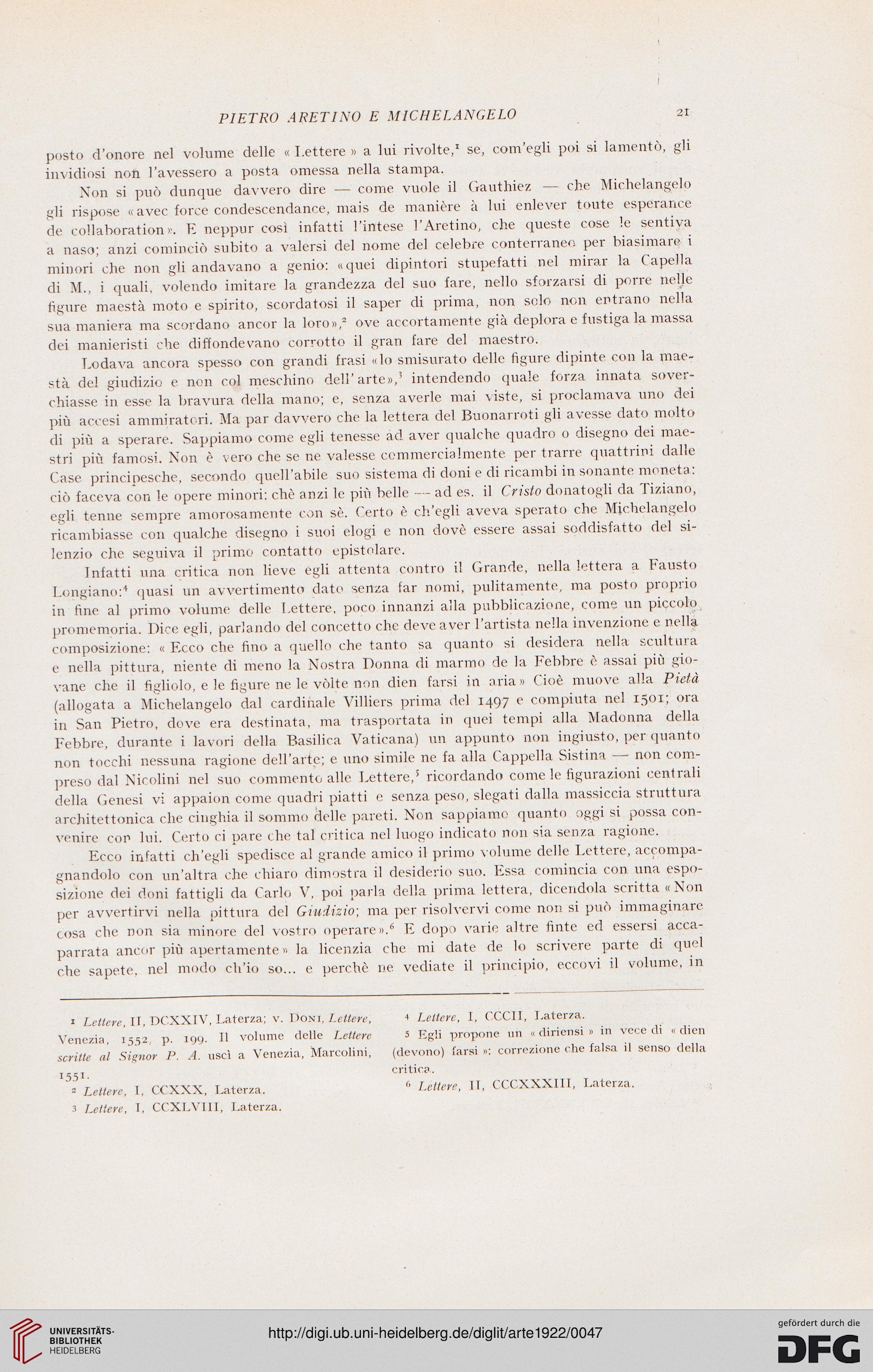PIETRO ARETINO E MICHELANGELO
21
posto d'onore nel volume delle « Lettere » a lui rivolte,1 se, com'egli poi si lamentò, gli
invidiosi non l'avessero a posta omessa nella stampa.
Non si può dunque davvero dire — come vuole il Gauthiez — che Michelangelo
gli rispose « avec force condescendance, mais de manière à lui enlever toute espera net-
de collaboration ». E neppur così infatti l'intese l'Aretino, che queste cose le sentiva
a naso; anzi cominciò subito a valersi del nome del celebre conterraneo per biasimare i
minori clie non gli andavano a genio: «quei dipintori stupefatti nel mirar la Capella
di AI., i quali, volendo imitare la grandezza del suo fare, nello sforzarsi di porre nelle
figure maestà moto e spirito, scordatosi il saper di prima, non scio non entrano nella
sua maniera ma scordano ancor la loro»,2 ove accortamente già deplora e fustiga la massa
dei manieristi che diffondevano corrotto il gran fare del maestro.
Lodava ancora spesso con grandi frasi «lo smisurato delle figure dipinte con la mae-
stà de! giudizio e non coJ meschino dell'arte»,' intendendo quale forza innata sover-
chiasse in esse la bravura della mano; e, senza averle mai \iste, si proclamava uno dei
più accesi ammiratori. Ala par davvero che la lettera del Buonarroti gli avesse dato molto
di più a sperare. Sappiamo come egli tenesse ad aver qualche quadro o disegno dei mae-
stri più famosi. Non è vero che se ne valesse commercialmente per trarre quattrini dalle
Case principesche, secondo quell'abile suo sistema di doni e di ricambi in sonante moneta :
ciò faceva con le opere minori: che anzi le più belle — ad es. il Cristo donatogli da Tiziano,
egli tenne sempre amorosamente con sè. Certo è ch'egli aveva sperato che Michelangelo
ricambiasse con qualche disegno i suoi elogi e non dovè essere assai soddisfatto del si-
lenzio che seguiva il primo contatto epistolare.
Infatti una critica non lieve egli attenta contro i! Grande, nella lettera a Fausto
Longiano:4 quasi un avvertimento dato senza far nomi, pulitamente, ma posto proprio
in fine al primo volume delle Lettere', poco innanzi alla pubblicazione-, come un piccolo
promemoria. Dice egli, parlando del concetto che deve aver l'artista nella invenzione e nella
composizione: « Ecco che fino a quello che tanto sa quanto si desidera nella scultura
e nella pittura, niente di meno la Nostra Donna di marmo de la Febbre è assai più gio-
vane che il figliolo, e le figure ne le vòlte non dien farsi in aria» Cioè muove alla Pietà
(allogata a Michelangelo dal cardinale Villiers prima del 1497 e compiuta nel 1501; ora
in San Pietro, dove era destinata, ma trasportata in epici tempi alla Madonna della
Febbre, durante i lavori della Basilica Vaticana) un appunto non ingiusto, per quanto
non tocchi nessuna ragione dell'arte'; e uno simile ne fa alla Cappe lla Sistina — non ce>m-
preso dal Nicolini nel suo commento alle Lettere,5 ricordando come le figurazioni centrali
della Genesi vi appaion come quadri piatti e senza peso, slegati dalla massiccia struttura
architettonica che cinghia il sommo delle pareti. Non sappiamo (pianto ,»«gi si possa con-
venire con lui. Certo ci pare che tal critica nel luogo indicato non sia senza ragione.
Ecco infatti ch'egli spedisce al grande amico il primo volume delle Lettere, accompa-
gnandolo con un'altra che chiaro dimostra il desiderio suo. Essa comincia con una espo-
sizione dei doni fattigli da Carlo V, poi parla della prima lettera, dicendola scritta «Non
per avvertirvi nella pittura del Giudizio; ma per risolvervi come non si può immaginare
(osa che non sia minore del vostro operare».6 E dopo varie altre finte ed essersi acca-
parrata ancor più apertamente » la licenzia che mi date de lo scrivere parte di quel
che sapete, nel modo ch'io so... e perchè ne vediate il principio, eccovi il volume, in
1 Lettere, II, DCXXIV, Laterza: v. Doni. Lettere,
Venezia, 1552 p. 100. 11 volume delle Lettere
scritte al Signor P. A. uscì a Venezia, Marcolini,
15.51-
2 Lettere, I, CCXXX, Laterza.
S Lettere, I, CCXLVIII. Laterza.
» Lettere, I, CCCII, Laterza.
5 Egli propone un « diriensi » in vece di « dien
(devono) farsi »: correzione che falsa il senso della
• litica.
6 Lettere, II, CCCXXXIII, Laterza.
21
posto d'onore nel volume delle « Lettere » a lui rivolte,1 se, com'egli poi si lamentò, gli
invidiosi non l'avessero a posta omessa nella stampa.
Non si può dunque davvero dire — come vuole il Gauthiez — che Michelangelo
gli rispose « avec force condescendance, mais de manière à lui enlever toute espera net-
de collaboration ». E neppur così infatti l'intese l'Aretino, che queste cose le sentiva
a naso; anzi cominciò subito a valersi del nome del celebre conterraneo per biasimare i
minori clie non gli andavano a genio: «quei dipintori stupefatti nel mirar la Capella
di AI., i quali, volendo imitare la grandezza del suo fare, nello sforzarsi di porre nelle
figure maestà moto e spirito, scordatosi il saper di prima, non scio non entrano nella
sua maniera ma scordano ancor la loro»,2 ove accortamente già deplora e fustiga la massa
dei manieristi che diffondevano corrotto il gran fare del maestro.
Lodava ancora spesso con grandi frasi «lo smisurato delle figure dipinte con la mae-
stà de! giudizio e non coJ meschino dell'arte»,' intendendo quale forza innata sover-
chiasse in esse la bravura della mano; e, senza averle mai \iste, si proclamava uno dei
più accesi ammiratori. Ala par davvero che la lettera del Buonarroti gli avesse dato molto
di più a sperare. Sappiamo come egli tenesse ad aver qualche quadro o disegno dei mae-
stri più famosi. Non è vero che se ne valesse commercialmente per trarre quattrini dalle
Case principesche, secondo quell'abile suo sistema di doni e di ricambi in sonante moneta :
ciò faceva con le opere minori: che anzi le più belle — ad es. il Cristo donatogli da Tiziano,
egli tenne sempre amorosamente con sè. Certo è ch'egli aveva sperato che Michelangelo
ricambiasse con qualche disegno i suoi elogi e non dovè essere assai soddisfatto del si-
lenzio che seguiva il primo contatto epistolare.
Infatti una critica non lieve egli attenta contro i! Grande, nella lettera a Fausto
Longiano:4 quasi un avvertimento dato senza far nomi, pulitamente, ma posto proprio
in fine al primo volume delle Lettere', poco innanzi alla pubblicazione-, come un piccolo
promemoria. Dice egli, parlando del concetto che deve aver l'artista nella invenzione e nella
composizione: « Ecco che fino a quello che tanto sa quanto si desidera nella scultura
e nella pittura, niente di meno la Nostra Donna di marmo de la Febbre è assai più gio-
vane che il figliolo, e le figure ne le vòlte non dien farsi in aria» Cioè muove alla Pietà
(allogata a Michelangelo dal cardinale Villiers prima del 1497 e compiuta nel 1501; ora
in San Pietro, dove era destinata, ma trasportata in epici tempi alla Madonna della
Febbre, durante i lavori della Basilica Vaticana) un appunto non ingiusto, per quanto
non tocchi nessuna ragione dell'arte'; e uno simile ne fa alla Cappe lla Sistina — non ce>m-
preso dal Nicolini nel suo commento alle Lettere,5 ricordando come le figurazioni centrali
della Genesi vi appaion come quadri piatti e senza peso, slegati dalla massiccia struttura
architettonica che cinghia il sommo delle pareti. Non sappiamo (pianto ,»«gi si possa con-
venire con lui. Certo ci pare che tal critica nel luogo indicato non sia senza ragione.
Ecco infatti ch'egli spedisce al grande amico il primo volume delle Lettere, accompa-
gnandolo con un'altra che chiaro dimostra il desiderio suo. Essa comincia con una espo-
sizione dei doni fattigli da Carlo V, poi parla della prima lettera, dicendola scritta «Non
per avvertirvi nella pittura del Giudizio; ma per risolvervi come non si può immaginare
(osa che non sia minore del vostro operare».6 E dopo varie altre finte ed essersi acca-
parrata ancor più apertamente » la licenzia che mi date de lo scrivere parte di quel
che sapete, nel modo ch'io so... e perchè ne vediate il principio, eccovi il volume, in
1 Lettere, II, DCXXIV, Laterza: v. Doni. Lettere,
Venezia, 1552 p. 100. 11 volume delle Lettere
scritte al Signor P. A. uscì a Venezia, Marcolini,
15.51-
2 Lettere, I, CCXXX, Laterza.
S Lettere, I, CCXLVIII. Laterza.
» Lettere, I, CCCII, Laterza.
5 Egli propone un « diriensi » in vece di « dien
(devono) farsi »: correzione che falsa il senso della
• litica.
6 Lettere, II, CCCXXXIII, Laterza.