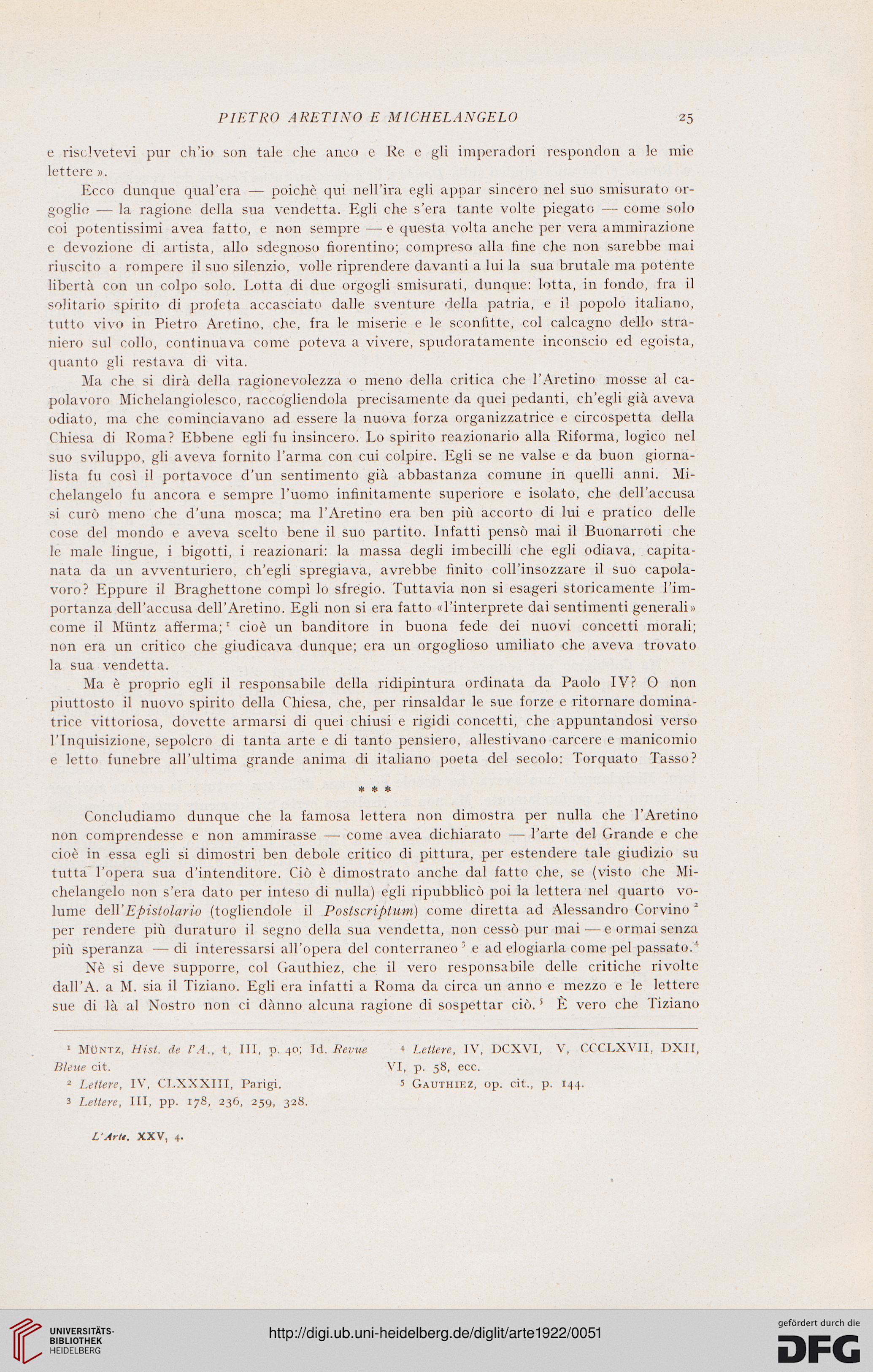PIETRO ARETINO E MICHELANGELO
*5
e risolvetevi pur ch'io son tale che anco e Re e gli imperadori respondon a le mie
lettere ».
Ecco dunque qual'era — poiché qui nell'ira egli appar sincero nel suo smisurato or-
goglio — la ragione della sua vendetta. Egli che s'era tante volte piegato — come solo
coi potentissimi avea fatto, e non sempre — e questa volta anche per vera ammirazione
e devozione di artista, allo sdegnoso fiorentino; compreso alla fine che non sarebbe mai
riuscito a rompere il suo silenzio, volle riprendere davanti a lui la sua brutale ma potente
libertà con un colpo solo. Lotta di due orgogli smisurati, dunque: lotta, in fondo, fra il
solitario spirito di profeta accasciato dalle sventure della patria, e il popolo italiano,
tutto vivo in Pietro Aretino, che, fra le miserie e le sconfitte, col calcagno dello stra-
niero sul collo, continuava come poteva a vivere, spudoratamente inconscio ed egoista,
(pianto gli restava di vita.
Ma che si dirà della ragionevolezza o meno della critica che l'Aretino mosse al ca-
polavoro Michelangiolesco, raccogliendola precisamente da quei pedanti, ch'egli già aveva
odiato, ma che cominciavano ad essere la nuova forza organizzatrice e circospetta della
Chiesa di Roma? Ebbene egli fu insincero. Lo spirito reazionario alla Riforma, logico nel
suo sviluppo, gli aveva fornito l'arma con cui colpire. Egli se ne valse e da buon giorna-
lista fu così il portavoce d'un sentimento già abbastanza comune in quelli anni. Mi-
chelangelo fu ancora e sempre l'uomo infinitamente superiore e isolato, che dell'accusa
si curò meno che d'una mosca; ma l'Aretino era ben più accorto di lui e pratico delle
cose del mondo e aveva scelto bene il suo partito. Infatti pensò mai il Buonarroti che
le male lingue, i bigotti, i reazionari: la massa degli imbecilli che egli odiava, capita-
nata da un avventuriero, ch'egli spregiava, avrebbe finito coll'insozzare il suo capola-
voro? Eppure il Braghettone compì lo sfregio. Tuttavia non si esageri storicamente l'im-
portanza dell'accusa dell'Aretino. Egli non si era fatto «l'interprete dai sentimenti generali»
come il Miintz afferma;1 cioè un banditore in buona fede dei nuovi concetti morali;
non era un critico che giudicava dunque; era un orgoglioso umiliato che aveva trovato
la sua vendetta.
Ma è proprio egli il responsabile della ridipintura ordinata da Paolo IV? O non
piuttosto il nuovo spirito della Chiesa, che, per rinsaldar le sue forze e ritornare domina-
trice vittoriosa, dovette armarsi di quei chiusi e rigidi concetti, che appuntandosi verso
l'Inquisizione, sepolcro di tanta arte e di tanto pensiero, allestivano carcere e manicomio
e letto funebre all'ultima grande anima di italiano poeta del secolo: Torquato Tasso?
* * *
Concludiamo dunque che la famosa lettera non dimostra per nulla che l'Aretino
non comprendesse e non ammirasse — come avea dichiarato — l'arte del Grande e che
cioè in essa egli si dimostri ben debole critico di pittura, per estendere tale giudizio su
tutta l'opera sua d'intenditore. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, se (visto che Mi-
chelangelo non s'era dato per inteso di nulla) egli ripubblicò poi la lettera nel quarto vo-
lume dell'Epistolario (togliendole il Postscriptum) come diretta ad Alessandro Corvino 2
per rendere più duraturo il segno della sua vendetta, non cessò pur mai — e ormai senza
più speranza — di interessarsi all'opera del conterraneo *' e ad elogiarla come pel passato.4
Nè si deve supporre, col Gauthiez, che il vero responsabile delle critiche rivolte
dall'A. a M. sia il Tiziano. Egli era infatti a Roma da circa un anno e mezzo e le lettere
sue di là al Nostro non ci dànno alcuna ragione di sospettar ciò.s È vero che Tiziano
1 Muntz, Hist. de VA., t, III, p. 40; Id. Revtie
Mene cit.
2 Lettere, IV, CI.XXXIII, Parigi.
3 Lettere, III, pp. 178, 236, 259, 328.
4 Lettere, IV, DCXVI, V, CCCLXVII, DXII,
VI, p. 58, ecc.
5 Gauthiez, op. cit., p. 144.
L Arlt. XXV, 4.
*5
e risolvetevi pur ch'io son tale che anco e Re e gli imperadori respondon a le mie
lettere ».
Ecco dunque qual'era — poiché qui nell'ira egli appar sincero nel suo smisurato or-
goglio — la ragione della sua vendetta. Egli che s'era tante volte piegato — come solo
coi potentissimi avea fatto, e non sempre — e questa volta anche per vera ammirazione
e devozione di artista, allo sdegnoso fiorentino; compreso alla fine che non sarebbe mai
riuscito a rompere il suo silenzio, volle riprendere davanti a lui la sua brutale ma potente
libertà con un colpo solo. Lotta di due orgogli smisurati, dunque: lotta, in fondo, fra il
solitario spirito di profeta accasciato dalle sventure della patria, e il popolo italiano,
tutto vivo in Pietro Aretino, che, fra le miserie e le sconfitte, col calcagno dello stra-
niero sul collo, continuava come poteva a vivere, spudoratamente inconscio ed egoista,
(pianto gli restava di vita.
Ma che si dirà della ragionevolezza o meno della critica che l'Aretino mosse al ca-
polavoro Michelangiolesco, raccogliendola precisamente da quei pedanti, ch'egli già aveva
odiato, ma che cominciavano ad essere la nuova forza organizzatrice e circospetta della
Chiesa di Roma? Ebbene egli fu insincero. Lo spirito reazionario alla Riforma, logico nel
suo sviluppo, gli aveva fornito l'arma con cui colpire. Egli se ne valse e da buon giorna-
lista fu così il portavoce d'un sentimento già abbastanza comune in quelli anni. Mi-
chelangelo fu ancora e sempre l'uomo infinitamente superiore e isolato, che dell'accusa
si curò meno che d'una mosca; ma l'Aretino era ben più accorto di lui e pratico delle
cose del mondo e aveva scelto bene il suo partito. Infatti pensò mai il Buonarroti che
le male lingue, i bigotti, i reazionari: la massa degli imbecilli che egli odiava, capita-
nata da un avventuriero, ch'egli spregiava, avrebbe finito coll'insozzare il suo capola-
voro? Eppure il Braghettone compì lo sfregio. Tuttavia non si esageri storicamente l'im-
portanza dell'accusa dell'Aretino. Egli non si era fatto «l'interprete dai sentimenti generali»
come il Miintz afferma;1 cioè un banditore in buona fede dei nuovi concetti morali;
non era un critico che giudicava dunque; era un orgoglioso umiliato che aveva trovato
la sua vendetta.
Ma è proprio egli il responsabile della ridipintura ordinata da Paolo IV? O non
piuttosto il nuovo spirito della Chiesa, che, per rinsaldar le sue forze e ritornare domina-
trice vittoriosa, dovette armarsi di quei chiusi e rigidi concetti, che appuntandosi verso
l'Inquisizione, sepolcro di tanta arte e di tanto pensiero, allestivano carcere e manicomio
e letto funebre all'ultima grande anima di italiano poeta del secolo: Torquato Tasso?
* * *
Concludiamo dunque che la famosa lettera non dimostra per nulla che l'Aretino
non comprendesse e non ammirasse — come avea dichiarato — l'arte del Grande e che
cioè in essa egli si dimostri ben debole critico di pittura, per estendere tale giudizio su
tutta l'opera sua d'intenditore. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, se (visto che Mi-
chelangelo non s'era dato per inteso di nulla) egli ripubblicò poi la lettera nel quarto vo-
lume dell'Epistolario (togliendole il Postscriptum) come diretta ad Alessandro Corvino 2
per rendere più duraturo il segno della sua vendetta, non cessò pur mai — e ormai senza
più speranza — di interessarsi all'opera del conterraneo *' e ad elogiarla come pel passato.4
Nè si deve supporre, col Gauthiez, che il vero responsabile delle critiche rivolte
dall'A. a M. sia il Tiziano. Egli era infatti a Roma da circa un anno e mezzo e le lettere
sue di là al Nostro non ci dànno alcuna ragione di sospettar ciò.s È vero che Tiziano
1 Muntz, Hist. de VA., t, III, p. 40; Id. Revtie
Mene cit.
2 Lettere, IV, CI.XXXIII, Parigi.
3 Lettere, III, pp. 178, 236, 259, 328.
4 Lettere, IV, DCXVI, V, CCCLXVII, DXII,
VI, p. 58, ecc.
5 Gauthiez, op. cit., p. 144.
L Arlt. XXV, 4.