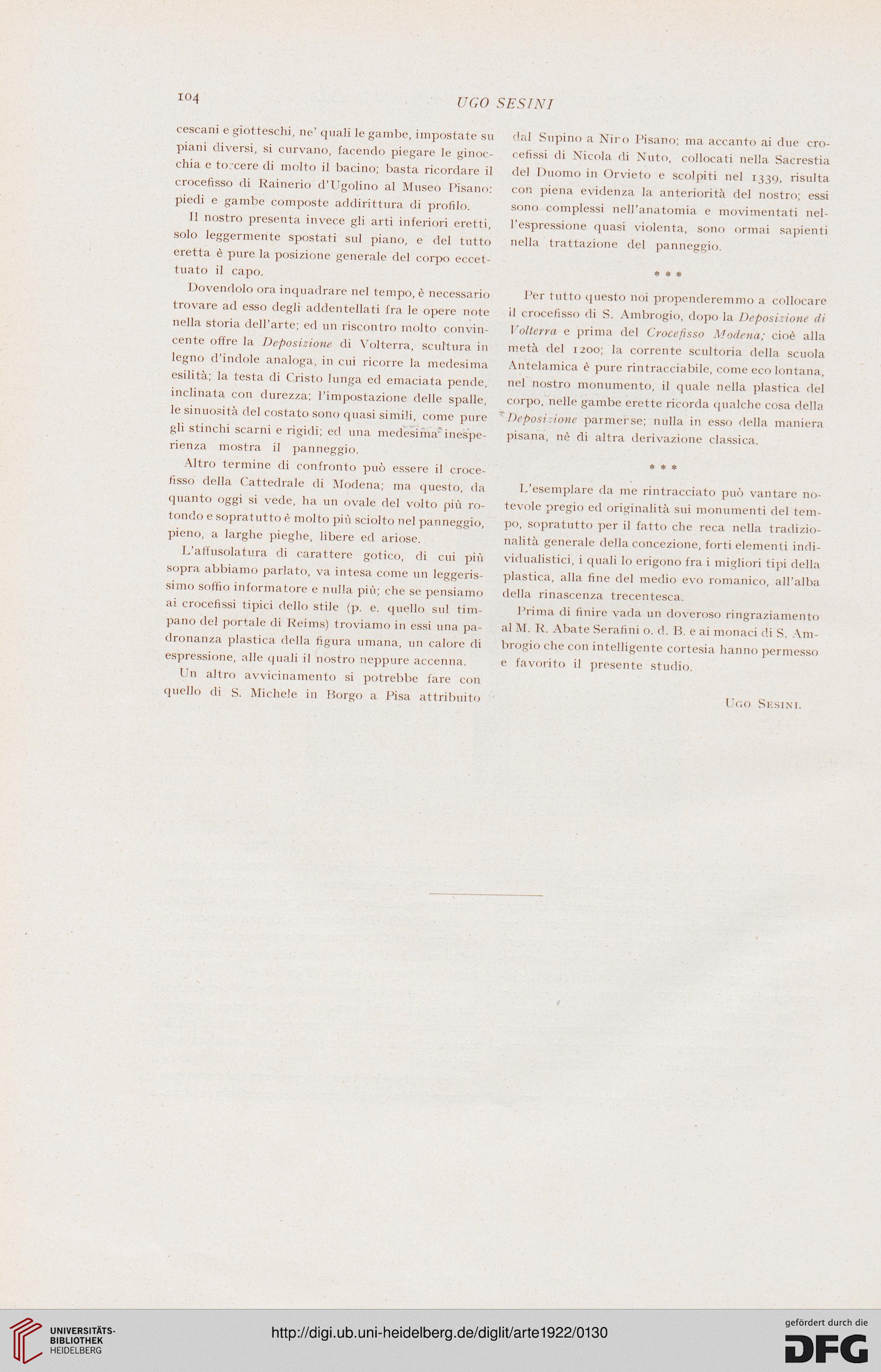104
UGO SESIN1
cescani e giotteschi, ne' quali le gambe, impostate su
piani diversi, si curvano, facendo piegare le ginoc-
chia e torcere di molto il bacino; basta ricordale il
crocefisso di Kainerio d'Ugolino al Museo Pisano:
piedi e gambe composte addirittura di profilo.
Il nostro presenta invece gli arti inferiori cretti,
solo leggermente spostati sul piano, e del tutto
eretta è pure La posizione generale del corpo ecce!
tuato il capo.
Dovendolo ora inquadrare ne) tempo, è necessario
trovare ad esso degli addentellati Ira le opere note
nella storia dell'arte; ed un riscontro molto conviti
cente olire la Deposizione di Volterra, scultura in
legno d'indole analoga, in CUI ricorre la medesima
esilità; la testa di ( risto lunga ed emaciata pende,
inclinata con durezza; l'impostazione delle spalle,
le sinuosità del costato sono quasi simili, come pure
gli stinchi scarni e rigidi; ed una medesima inespe
rienza mostra il panneggio.
Vitro termine di confronto può esseri' il croce
fisso della Cattedrale di Modena; ma questo, da
(pianto oggi si vede, ha un ovale del volto più ro-
tondo e soprai utto è molto più sciolto nel panneggio,
pieno, a larghe pieghe, libere ed ariose.
L'affusolatura di carattere gotico, di cui più
sopra abbiamo parlato, va intesa come un leggeris-
simo sotiio intornia ture e nulla più; che se pensiamo
ai crocefissi tipici dello stile ;p. e. quello sul tim-
pano del poi-tale di Reims) troviamo in essi una pa
dronanza plastica della figura umana, un calore di
espressione, alle quali il nostro neppure accenna.
l'n altro avvicinamento si potrebbe fare con
quello di S. Michele in Borgo a Pisa attribuito
dal Supino a Nino Pisano; ina accanto ai due cro-
cefissi di Nicola di Nuto, collocati nella Sacrestia
del liuoino in Orvieto e scolpiti nel 1:339, risulta
(ini piena evidenza la anteriorità del nostro; essi
sono complessi nell'anatomia e movimentati nel-
l'espressione (piasi violenta, sono ormai sapienti
nella trattazione del panneggio.
* * *
Per tutto questo noi propenderemmo a collocare
il crocefisso di S. Ambrogio, dopo la Deposizione di
Volterra e prima del Crocefisso Modena; cioè alla
metà del [ZOO; la corrente scultoria della scuola
Alitela mica è pure rintracciabile, come eco lontana,
nel nostro monumento, il (piale nella plastica del
corpo, nelle gambe erette ricorda qualche cosa della
Deposizione parmerse; nulla in esso della maniera
pisana, uè di altra derivazione classica.
* * *
L'esemplare da me rintracciato può vantare no-
tevole pregio ed originalità sui monumenti del lem
po, sopratutto per il latto che reca nella tradizio-
nali generale della conce/ione, forti elementi indi-
vidualistici, i (piali lo erigono Ira i migliori tipi della
plastica, alla line del medio evo romanico, all'alba
della rinascenza trecentesca.
Prima di finire vada un doveroso ringraziamento
al M. K. Abate Serafini o. d, I! e ai monaci di S. Atti
brogio che con intelligente cortesia hanno permesso
e favorito il presente studio.
EJtìO Si.siM.
UGO SESIN1
cescani e giotteschi, ne' quali le gambe, impostate su
piani diversi, si curvano, facendo piegare le ginoc-
chia e torcere di molto il bacino; basta ricordale il
crocefisso di Kainerio d'Ugolino al Museo Pisano:
piedi e gambe composte addirittura di profilo.
Il nostro presenta invece gli arti inferiori cretti,
solo leggermente spostati sul piano, e del tutto
eretta è pure La posizione generale del corpo ecce!
tuato il capo.
Dovendolo ora inquadrare ne) tempo, è necessario
trovare ad esso degli addentellati Ira le opere note
nella storia dell'arte; ed un riscontro molto conviti
cente olire la Deposizione di Volterra, scultura in
legno d'indole analoga, in CUI ricorre la medesima
esilità; la testa di ( risto lunga ed emaciata pende,
inclinata con durezza; l'impostazione delle spalle,
le sinuosità del costato sono quasi simili, come pure
gli stinchi scarni e rigidi; ed una medesima inespe
rienza mostra il panneggio.
Vitro termine di confronto può esseri' il croce
fisso della Cattedrale di Modena; ma questo, da
(pianto oggi si vede, ha un ovale del volto più ro-
tondo e soprai utto è molto più sciolto nel panneggio,
pieno, a larghe pieghe, libere ed ariose.
L'affusolatura di carattere gotico, di cui più
sopra abbiamo parlato, va intesa come un leggeris-
simo sotiio intornia ture e nulla più; che se pensiamo
ai crocefissi tipici dello stile ;p. e. quello sul tim-
pano del poi-tale di Reims) troviamo in essi una pa
dronanza plastica della figura umana, un calore di
espressione, alle quali il nostro neppure accenna.
l'n altro avvicinamento si potrebbe fare con
quello di S. Michele in Borgo a Pisa attribuito
dal Supino a Nino Pisano; ina accanto ai due cro-
cefissi di Nicola di Nuto, collocati nella Sacrestia
del liuoino in Orvieto e scolpiti nel 1:339, risulta
(ini piena evidenza la anteriorità del nostro; essi
sono complessi nell'anatomia e movimentati nel-
l'espressione (piasi violenta, sono ormai sapienti
nella trattazione del panneggio.
* * *
Per tutto questo noi propenderemmo a collocare
il crocefisso di S. Ambrogio, dopo la Deposizione di
Volterra e prima del Crocefisso Modena; cioè alla
metà del [ZOO; la corrente scultoria della scuola
Alitela mica è pure rintracciabile, come eco lontana,
nel nostro monumento, il (piale nella plastica del
corpo, nelle gambe erette ricorda qualche cosa della
Deposizione parmerse; nulla in esso della maniera
pisana, uè di altra derivazione classica.
* * *
L'esemplare da me rintracciato può vantare no-
tevole pregio ed originalità sui monumenti del lem
po, sopratutto per il latto che reca nella tradizio-
nali generale della conce/ione, forti elementi indi-
vidualistici, i (piali lo erigono Ira i migliori tipi della
plastica, alla line del medio evo romanico, all'alba
della rinascenza trecentesca.
Prima di finire vada un doveroso ringraziamento
al M. K. Abate Serafini o. d, I! e ai monaci di S. Atti
brogio che con intelligente cortesia hanno permesso
e favorito il presente studio.
EJtìO Si.siM.