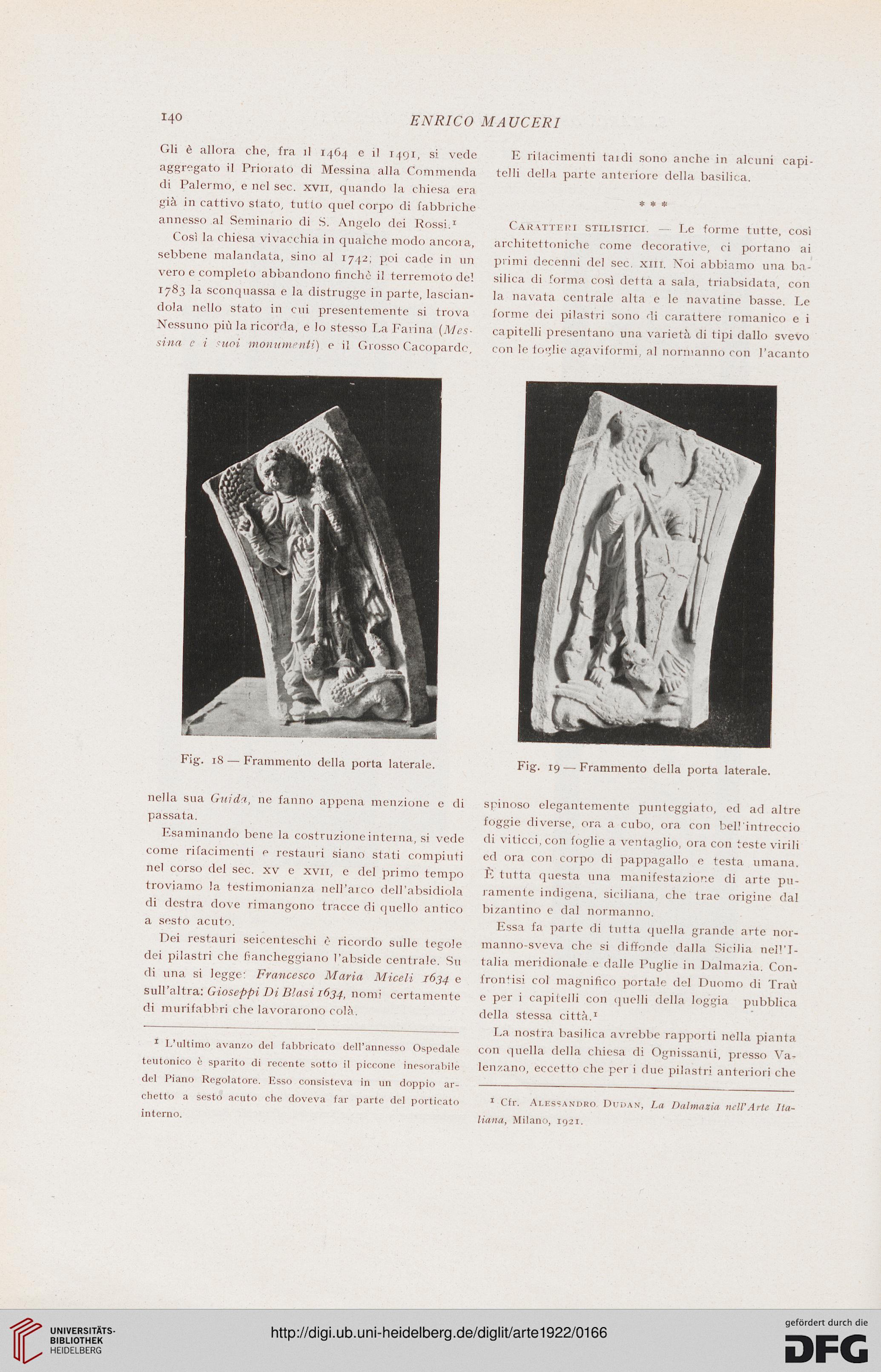140
ENRICO MAUCERI
Gli è allora che, fra il 1464 e il 14<j 1, si vede
aggregato il Priorato di Messina alla Commenda
di Palermo, e nel sec. xvn, quando la chiesa era
già in cattivo stato, tutto quel corpo di fabbriche
annesso al Seminario di S. Angelo dei Rossi.1
Così la chiesa vivacchia in qualche modo ancoia,
sebbene malandata, sino a] 171-!; p"i cade in un
vero e completo abbandono finché il terremoto del
1783 la sconquassa e la distrugge in parte, [ascian-
dola nello stato in cui presentemente si trova
Nessuno più la ricorrla, e lo stesso La Farina (Mes-
sina c i suoi monumenti) e il GrossoCacopardc,
Fig. 18 — Frammento della porta laterale
nella sua Guida, ne fanno appena menzione e di
passata.
Esaminando bene la costruzione interna, si vede
come rifacimenti p restauri siano siati compiuti
nel corso del sec. xv e xvn, e del primo tempo
troviamo la testimonianza nell'arco dell'absidiola
di destra dove rimangono tracce di quello antico
a sesto acuto.
Dei restauri seicenteschi è ricordo sulle tegole
dei pilastri che fiancheggiano l'abside centrale. Su
di una si legge: Francesco Maria Miceli 1634 e
sull'altra: Gioseppi Di Blasi 1634, nomi (ertamente
di murifabbri che lavorarono colà.
1 L'ultimo avanzo del fabbricato dell'annesso Ospedale
teutonico è spanto di recente sotto il piccone inesorabile
del Piano Regolatore. Esso consisteva in un doppio ar-
chetto a sesto acuto che doveva far parte del porticato
interno.
E rilacimenti taidi sono anche in alcuni capi-
telli della parte anteriore della basilica.
* * *
CARATTERI stilistici. — Le forme tutte, così
architettoniche come decorative, ci portano ai
primi decenni del sec. xm. Noi abbiamo una ba-
silica di forma così detta a sala, triabsidata, con
la navata centrale alta e le navatine basse. Le
forme dei pilastri sono di carattere romanico e i
capitelli presentano una varietà di tipi dallo svevo
con le fo'die agaviformi, al normanno con l'acanto
Fig. 19 — Frammento della porta laterale
spinoso elegantemente punteggiato, ed ad altre
foggie diverse, ora a cubo, ora con bel! intreccio
di viticci,con foglie a ventaglio, ora con teste virili
ed ora con corpo di pappagallo e testa umana.
E tutta questa una manifestazione di arte pu-
ramente indigena, siciliana che trae origine dal
bizantino e dal normanno.
Essa fa parte di tutta quella grande arte nor-
manno-sveva che si diffonde dalla Sicilia nell'I-
talia meridionale e dalle Puglie in Dalmazia. Con-
fron'isi col magnifico portale del Duomo di Traù
e per i capitelli con quelli della loggia pubblica
della stessa città.1
La nostra basilica avrebbe rapporti nella pianta
con quella della chiesa di Ognissanti, presso Va-
lenzano, eccetto che per i due pilastri anteriori che
1 Cfr. Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'Arte Ita-
liana, Milano, iQ2i.
ENRICO MAUCERI
Gli è allora che, fra il 1464 e il 14<j 1, si vede
aggregato il Priorato di Messina alla Commenda
di Palermo, e nel sec. xvn, quando la chiesa era
già in cattivo stato, tutto quel corpo di fabbriche
annesso al Seminario di S. Angelo dei Rossi.1
Così la chiesa vivacchia in qualche modo ancoia,
sebbene malandata, sino a] 171-!; p"i cade in un
vero e completo abbandono finché il terremoto del
1783 la sconquassa e la distrugge in parte, [ascian-
dola nello stato in cui presentemente si trova
Nessuno più la ricorrla, e lo stesso La Farina (Mes-
sina c i suoi monumenti) e il GrossoCacopardc,
Fig. 18 — Frammento della porta laterale
nella sua Guida, ne fanno appena menzione e di
passata.
Esaminando bene la costruzione interna, si vede
come rifacimenti p restauri siano siati compiuti
nel corso del sec. xv e xvn, e del primo tempo
troviamo la testimonianza nell'arco dell'absidiola
di destra dove rimangono tracce di quello antico
a sesto acuto.
Dei restauri seicenteschi è ricordo sulle tegole
dei pilastri che fiancheggiano l'abside centrale. Su
di una si legge: Francesco Maria Miceli 1634 e
sull'altra: Gioseppi Di Blasi 1634, nomi (ertamente
di murifabbri che lavorarono colà.
1 L'ultimo avanzo del fabbricato dell'annesso Ospedale
teutonico è spanto di recente sotto il piccone inesorabile
del Piano Regolatore. Esso consisteva in un doppio ar-
chetto a sesto acuto che doveva far parte del porticato
interno.
E rilacimenti taidi sono anche in alcuni capi-
telli della parte anteriore della basilica.
* * *
CARATTERI stilistici. — Le forme tutte, così
architettoniche come decorative, ci portano ai
primi decenni del sec. xm. Noi abbiamo una ba-
silica di forma così detta a sala, triabsidata, con
la navata centrale alta e le navatine basse. Le
forme dei pilastri sono di carattere romanico e i
capitelli presentano una varietà di tipi dallo svevo
con le fo'die agaviformi, al normanno con l'acanto
Fig. 19 — Frammento della porta laterale
spinoso elegantemente punteggiato, ed ad altre
foggie diverse, ora a cubo, ora con bel! intreccio
di viticci,con foglie a ventaglio, ora con teste virili
ed ora con corpo di pappagallo e testa umana.
E tutta questa una manifestazione di arte pu-
ramente indigena, siciliana che trae origine dal
bizantino e dal normanno.
Essa fa parte di tutta quella grande arte nor-
manno-sveva che si diffonde dalla Sicilia nell'I-
talia meridionale e dalle Puglie in Dalmazia. Con-
fron'isi col magnifico portale del Duomo di Traù
e per i capitelli con quelli della loggia pubblica
della stessa città.1
La nostra basilica avrebbe rapporti nella pianta
con quella della chiesa di Ognissanti, presso Va-
lenzano, eccetto che per i due pilastri anteriori che
1 Cfr. Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'Arte Ita-
liana, Milano, iQ2i.