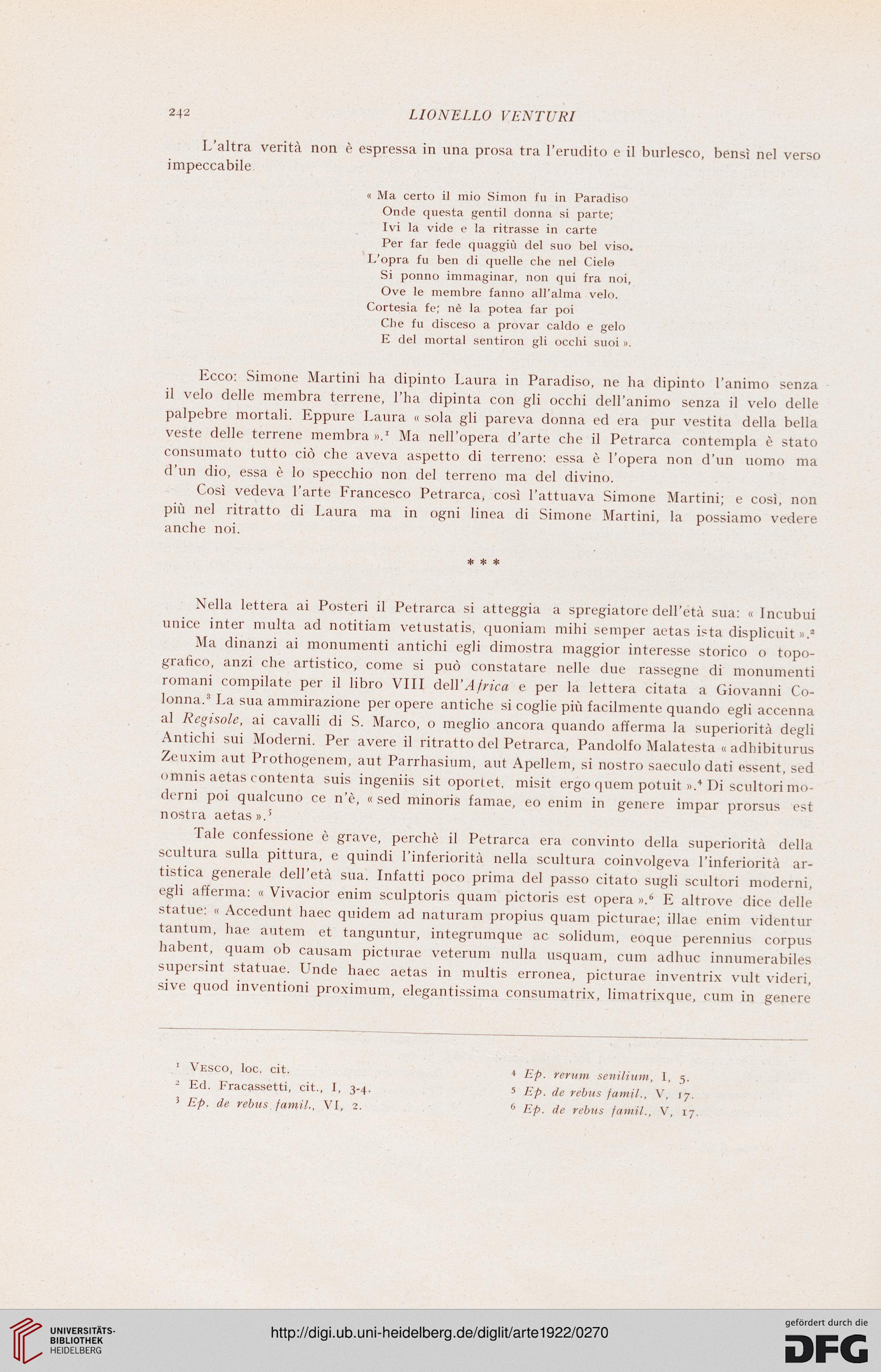242
LIONELLO VENTURI
L'altra verità non è espressa in una prosa tra l'erudito e il burlesco, bensì nel verso
impeccabile
« Ma certo il mio Simon fu in Paradiso
Onde questa gentil donna si parte;
Ivi la vide e la ritrasse in carte
Per far fede quaggiù del suo bel viso.
L'opra fu ben di quelle che nel Cielo
Si ponno immaginar, non qui fra noi,
Ove le membre fanno all'alma velo.
Cortesia fé; uè la potea far poi
Che fu disceso a provar caldo e gelo
E del mortai sentiron gli occhi suoi ».
Ecco: Simone Martini ha dipinto Laura in Paradiso, ne ha dipinto l'animo senza
il velo delle membra terrene, l'ha dipinta con gli occhi dell'animo senza il velo dille
palpebre mortali. Eppure Laura « sola gli pareva donna ed era pur vestita della bella
veste delle terrene membra ».' Ma nell'opera d'arte che il Petrarca contempla è stato
consumato tutto ciò che aveva aspetto di terreno: essa è l'opera non d'un uomo ma
d'un dio, essa è lo specchio non del terreno ma del divino.
Così vedeva l'arte Francesco Petrarca, così l'attuava Simone Martini; e così, non
più nel ritratto di Laura ma in ogni linea di Simone Martini, la possiamo vedere
anche noi.
* * *
Nella lettera ai Posteri il Petrarca si atteggia a spregiatore dell'età sua: « Incubui
unice inter multa ad notitiam vetustatis, quoniam mihi semper aetas ista displicuit ».*
.Ma dinanzi ai monumenti antichi egli dimostra maggior interesse storico o topo-
grafico, anzi che artistico, come si può constatare nelle due rassegne di monumenti
romani compilate per il libro Vili dell'Africa e per la lettera citata a Giovanni Co-
lonna.' La sua ammirazione per opere antiche si coglie più facilmente quando egli accenna
al Regisole, ai cavalli di S. Marco, o meglio ancora quando afferma la superiorità degli
Antichi sui Moderni. Per avere il ritratto del Petrarca, Pandolfo Malatesta « adhibiturus
Zeuxim aut Prothogenem, aut Parrhasium, aut Apellem, si nostro saeculodati cssent, sed
omnis aetas contenta suis ingeniis sit oportet, misit ergo quem potuit ».4 Di scultori mo-
derni poi qualcuno ce n'è, «sed minoris famae, eo enim in genere impar prorsus est
nostra aetas ».'
Tale confessione è grave, perchè il Petrarca era convinto della superiorità della
scultura sulla pittura, e quindi l'inferiorità nella scultura coinvolgeva l'inferiorità ar-
tistica generale dell'età sua. Infatti poco prima del passo citato sugli scultori moderni,
egli afferma: « Vivacior enim sculptoris quam pictoris est opera».6 E altrove dice delle
statue: « Accedunt haec quidem ad naturam propius quam picturae; illae enim videntur
tantum, hae autem et tanguntur, integrumque ac solidum, coque perennius corpus
habent, quam ob causam picturae veterum nulla usquam, ctìm adhuc innumerabiles
supersint statuae. Unde haec aetas in multis erronea, picturae inventrix vult videri,
sive quod inventioni proximum, elegantissima consumatrix, limatrixque, rum in genere
1 Vesco, loc. cit.
2 Ed. Fracassetti, cit., I, 3-4.
' Ep. de rebus fami!., VI, 2.
* Ep. rerum seni li um, 1, 5,
5 Ep. de rebus fami/., V, 17.
6 Ep. de rebus famil., V, 17.
LIONELLO VENTURI
L'altra verità non è espressa in una prosa tra l'erudito e il burlesco, bensì nel verso
impeccabile
« Ma certo il mio Simon fu in Paradiso
Onde questa gentil donna si parte;
Ivi la vide e la ritrasse in carte
Per far fede quaggiù del suo bel viso.
L'opra fu ben di quelle che nel Cielo
Si ponno immaginar, non qui fra noi,
Ove le membre fanno all'alma velo.
Cortesia fé; uè la potea far poi
Che fu disceso a provar caldo e gelo
E del mortai sentiron gli occhi suoi ».
Ecco: Simone Martini ha dipinto Laura in Paradiso, ne ha dipinto l'animo senza
il velo delle membra terrene, l'ha dipinta con gli occhi dell'animo senza il velo dille
palpebre mortali. Eppure Laura « sola gli pareva donna ed era pur vestita della bella
veste delle terrene membra ».' Ma nell'opera d'arte che il Petrarca contempla è stato
consumato tutto ciò che aveva aspetto di terreno: essa è l'opera non d'un uomo ma
d'un dio, essa è lo specchio non del terreno ma del divino.
Così vedeva l'arte Francesco Petrarca, così l'attuava Simone Martini; e così, non
più nel ritratto di Laura ma in ogni linea di Simone Martini, la possiamo vedere
anche noi.
* * *
Nella lettera ai Posteri il Petrarca si atteggia a spregiatore dell'età sua: « Incubui
unice inter multa ad notitiam vetustatis, quoniam mihi semper aetas ista displicuit ».*
.Ma dinanzi ai monumenti antichi egli dimostra maggior interesse storico o topo-
grafico, anzi che artistico, come si può constatare nelle due rassegne di monumenti
romani compilate per il libro Vili dell'Africa e per la lettera citata a Giovanni Co-
lonna.' La sua ammirazione per opere antiche si coglie più facilmente quando egli accenna
al Regisole, ai cavalli di S. Marco, o meglio ancora quando afferma la superiorità degli
Antichi sui Moderni. Per avere il ritratto del Petrarca, Pandolfo Malatesta « adhibiturus
Zeuxim aut Prothogenem, aut Parrhasium, aut Apellem, si nostro saeculodati cssent, sed
omnis aetas contenta suis ingeniis sit oportet, misit ergo quem potuit ».4 Di scultori mo-
derni poi qualcuno ce n'è, «sed minoris famae, eo enim in genere impar prorsus est
nostra aetas ».'
Tale confessione è grave, perchè il Petrarca era convinto della superiorità della
scultura sulla pittura, e quindi l'inferiorità nella scultura coinvolgeva l'inferiorità ar-
tistica generale dell'età sua. Infatti poco prima del passo citato sugli scultori moderni,
egli afferma: « Vivacior enim sculptoris quam pictoris est opera».6 E altrove dice delle
statue: « Accedunt haec quidem ad naturam propius quam picturae; illae enim videntur
tantum, hae autem et tanguntur, integrumque ac solidum, coque perennius corpus
habent, quam ob causam picturae veterum nulla usquam, ctìm adhuc innumerabiles
supersint statuae. Unde haec aetas in multis erronea, picturae inventrix vult videri,
sive quod inventioni proximum, elegantissima consumatrix, limatrixque, rum in genere
1 Vesco, loc. cit.
2 Ed. Fracassetti, cit., I, 3-4.
' Ep. de rebus fami!., VI, 2.
* Ep. rerum seni li um, 1, 5,
5 Ep. de rebus fami/., V, 17.
6 Ep. de rebus famil., V, 17.